Ucraina, Palestina, Taiwan
Le tre direttrici del conflitto mondiale
“Imperialismo e guerra” da Antitesi n.17 – pag.46
Il 24 aprile scorso l’amministrazione Biden, dopo l’approvazione al senato, ha firmato il pacchetto di 95 miliardi di dollari in armi, destinati a Ucraina, “Israele” e Taiwan: una dichiarazione di guerra strategica a livello mondiale ad opera dell’imperialismo Usa con lo scopo di mantenere il proprio primato secondo tre direttrici determinate, una spartizione che descrive in maniera ‘matematica’ come gli Usa hanno intenzione di gestire i rapporti internazionali nel breve e lungo periodo. In questo articolo cercheremo di articolare un ragionamento rispetto allo sviluppo della contraddizione interimperialista ed alla contraddizione imperialismo-popoli oppressi che hanno la propria radice strutturale nella crisi di sovrapproduzione del capitale e che, conseguentemente, in questa fase si manifesta come crisi della superpotenza nordamericana. Per questo motivo, nella nostra analisi, partiremo proprio dagli Stati Uniti.
Nel ventre della bestia
Gli Usa sono oramai in una spirale di crisi che investe ogni segmento della società americana. La borghesia imperialista ha notevoli difficoltà a delineare una strategia di uscita, soprattutto perché appare in una fase di divisione, che non sembra facilmente ricomponibile nel breve e medio periodo. La componente unilateralista repubblicana trumpiana (America First) è in collisione con la visione trilateralista democratica: quest’ultima è la visione democratica classica, nata nel 1973 ad opera di Rockfeller, Brzezisnki e Franklin i quali ambivano a costruire una dimensione politica “trilaterale” appunto perché sviluppata sui tre continenti, aventi come vertici gli Stati Uniti, l’Europa occidentale e il Giappone. Sviluppata nel corso di decenni di politica estera americana, vede gli Stati Uniti come il perno di tale articolato sistema di alleanze globali, ma che appunto in quanto sistema deve quindi tener conto di una serie di delicati equilibri tra i paesi imperialisti, una sorta di Usa come primus inter pares. La visione unilateralista, d’altra parte, determina gli Usa come primo ed unico referente politicostrategico di cui tener conto: gli altri, volenti o nolenti, devono seguire a rimorchio, pena l’esclusione dal complesso dell’alleanza e, quindi, dall’agglomerato imperialista dominante. Le minacce di Trump a chi tra i paesi Nato non ha intenzione di raggiungere la quota del 2% del Pil per le spese militari, o addirittura l’ipotesi di uscita dall’Alleanza atlantica, sono un indicatore di tale atteggiamento.
Queste due diverse visioni della politica estera dell’imperialismo statunitense sono in lotta l’una con l’altra, rappresentando il riflesso della crisi della borghesia imperialista Usa nella sua proiezione internazionale. Nel contempo la crisi egemonica della borghesia imperialista Usa si riflette anche rispetto alle masse popolari statunitensi, con le mobilitazioni per la Palestina e per il Libano che si stanno sviluppando. Tali lotte hanno evidenziato come la componente più a sinistra e progressista delle masse nordamericane sia disposta a scendere in piazza determinatamente e di non riconoscere nessuno dei referenti politici della borghesia imperialista Usa come proprio. Le contestazioni contro Biden e Harris da parte dei giovani statunitensi mobilitatisi per la Palestina e contro le guerre di Netanyahu stanno sicuramente minando un potenziale bacino elettorale per i Democratici. All’opposto Trump ha fatto appello alla parte più apertamente sionista e razzista del paese, anche se sia democratici che repubblicani si vogliono presentare come “difensori dei confini” dal “pericolo” migratorio, ad esempio spingendo per ulteriori blindature del confine con il Messico.
Inoltre, Trump punta apertamente sul voto del proletariato bianco, un comparto di classe centrale negli equilibri politici ed elettorali americani. Ad esempio nel 2016 ha votato repubblicano in maniera compatta, ma nel 2020 significative frazioni di questa classe hanno spostato il loro asse di voto. Inoltre, la lotta di classe negli Stati Uniti ha subito uno profonda accelerazione, si pensi ad esempio alle mobilitazioni negli stabilimenti Kellog’s nel 2021 contro le condizioni bestiali di sfruttamento, o la recente costituzione del sindacato all’interno degli stabilimenti Amazon, oppure alla vittoria nelle vertenze del settore automobilistico, con scioperi e mobilitazioni partecipate nell’ottobre 2023 negli stabilimenti Usa di Stellantis, General Motors e Ford. La tendenza alla sindacalizzazione, che si era persa negli anni del liberismo reaganiano, vive ora di una spinta nuova, che necessariamente ha il suo peso specifico nel delicato equilibrio politico statunitense. In questo senso un altro nodo che la classe dirigente nordamericana è costretta a sciogliere è il fatto che con il rinnovarsi della combattività di classe del proletariato, il riassestamento delle linee produttive tramite reshoring [1] necessariamente dovrà impattare con le lotte portate avanti dalla classe lavoratrice.
Il contesto globale, in termini sia economici che politici, dialetticamente legati, riflette la debolezza strategica Usa: il processo di dedollarizzazione negli scambi economici tra paesi si sta ampliando e la fine dell’intesa sui petrodollari, portata avanti dai reali sauditi è un ennesimo smacco alla dirigenza Usa. Infatti rompendo gli accordi sul petrodollaro la monarchia saudita ha dato una stoccata profonda alla capacità finanziaria nord americana, sebbene gli effetti di questo colpo si vedranno sul lungo periodo. È da sottolineare come entrambi i candidati alla Casa Bianca abbiano posto come elemento di campagna elettorale il ripristino del dollaro come denaro mondiale di scambio, a sottolinearne la vitale importanza per l’economia finanziaria statunitense. [2] Lungo la sponda della de-dollarizzazione, i Brics diventano sempre di più il controaltare politico rispetto al mondo unipolare Usa. Senza cedere all’illusione che i Brics siano una sorta di anti-Nato, i paesi facenti parte di tale piattaforma compartecipano, chi più e chi meno, sempre rispetto ai propri interessi specifici, al processo di emancipazione finanziaria. Tramite l’impostazione delle loro valute per lo scambio internazionale, i paesi Brics denunciano la propria non volontà di sottostare ai diktat yankee, che si dimostrano sempre meno convenienti. Altro fenomeno da tenere sotto controllo sono le fughe dei capitali dei paesi Brics dalle banche occidentali, in particolar modo dopo l’esproprio indebito di asset finanziari russi da parte dell’Inghilterra o dell’Ue che vuole gestire i capitali russi congelati per finanziare gli armamenti all’Ucraina.
In questo contesto, per mantenere il proprio livello egemonico, la borghesia imperialista Usa deve utilizzare ben altri mezzi coercitivi: la guerra. Essa è il punto di sintesi che unisce sia la fazione unilateralista di Trump, fortemente anticinese e perfettamente allineata al boia Netanyahu, sia la fazione trilateralista di Harris, fortemente antirussa e garante, in ogni caso, della copertura politico-militare al boia Netanyahu. La crisi di sovrapproduzione fa collassare gli spazi di agibilità “classici” dell’economia capitalista: nella sua fase imperialista è la guerra l’unico sbocco che la lotta per la ripartizione dei mercati impone alle classi dominanti. L’alternativa è l’aggravarsi della crisi economica interna e questo, in un paese fortemente polarizzato dallo scontro tra fazioni borghesi come lo sono gli Usa, può minare la tenuta istituzionale e può portare alla guerra civile intesa come guerra sociale endemica. Questo spettro aleggia nella pancia degli Stati Uniti, come i tentativi di attentato mortale a Trump testimoniano e come dimostrò, in occasione delle ultime presidenziali, l’assalto a Capitol Hills del 6 Gennaio 2021. Insomma l’esito delle prossime elezioni, con Biden eliminato dalla corsa e sostituito dalla vicepresidente Harris, cavallo di razza della scuderia dem, è tutt’altro che scontato e, soprattutto, l’esito elettorale non è destinato a portare pacificazione interna.
Vediamo ora come la crisi di egemonia si sviluppa a livello globale, analizzando i vari quadranti geografici e la sua relazioni con le contraddizioni che si sviluppano nelle diverse macroregioni del globo.
Medio Oriente in fiamme
Ad ormai un anno dall’inizio dell’operazione Diluvio di Al Aqsa della Resistenza Palestinese, il 7 ottobre scorso, questa si conferma come lo spartiacque della politica regionale nel Medioriente. La Resistenza Palestinese ha infatti sancito un cambio di fase determinante per lo sviluppo futuro nella regione, grazie alla sua capacità nel compattare sia internamente che esternamente l’intero fronte anti-imperialista della regione. L’irriducibile Resistenza a Gaza, tutt’ora zona di guerra, e la costante escalation nella Cisgiordania ed ora in Libano, stanno facendo venire la schiuma alla bocca ai sionisti. La carta vincente della Resistenza si conferma in primo luogo l’aver messo in profonda crisi la normalizzazione dell’entità sionista rispetto ai paesi confinanti. Resta comunque il nodo del comportamento delle borghesie arabe, poiché se da una parte, infatti, sono saltate tutte le possibili normalizzazioni ufficiali e pubbliche con “Israele” – oramai i cosiddetti Patti di Abramo patrocinati dagli Usa sono sostanzialmente sospesi – i governi dei paesi arabi continuano a giocare di sponda con l’entità sionista e l’imperialismo Usa, seppur in grande contraddizione con le masse popolari dei propri paesi, che non mancano di rivendicare il loro sostegno alla causa di liberazione del popolo palestinese ed alla sua Resistenza. Se è vero che gli assetti multipolari, con l’affermazione dei Brics a livello globale, danno più spazio ai regimi arabi di differenziare la loro posizione dagli Usa rispetto a qualche anno, dall’altro lato essi sono spaventati dalla capacità di lotta del popolo palestinese, che si appella costantemente all’insurrezione di tutto il mondo arabo, e vedono soprattutto con timore il compattarsi delle forze antimperialiste della regione sotto il patrocinio di una potenza regionale rivale, cioè l’Iran. Si tratta del cosiddetto Asse della Resistenza, che comprende i combattenti palestinesi, iracheni, libanesi e yemeniti, sostenuto apertamente dal governo di Teheran. Quest’ultimo ha dato prova di forza notevole lanciando centinaia di missili contro “Israele” con l’operazione Promessa Sincera, nell’aprile scorso, causandone un indebolimento soprattutto politico. Sotto i colpi dell’Asse della Resistenza, la Resistenza Palestinese a Gaza e in Cisgiordania, il blocco navale a suon di missili imposto dal governo yemenita nel Mar Rosso ed il sostegno politico e militare fornito dall’Iran, la carta dell’invincibilità per l’entità sionista è perduta.
Dunque, la Resistenza del popolo palestinese e degli altri popoli della regione continua a tenere alto lo scontro e “Israele” vede l’incubo della sconfitta strategica alle porte e può solo alzare il livello dello scontro, allargando il conflitto al Libano e colpendo contemporaneamente i propri avversari nella regione. Non è presente infatti alcun piano per Gaza, a parte i deliranti progetti di resort di lusso sulle spiagge costruiti sulle macerie e sulle ossa dei palestinesi, mentre la questione degli ostaggi sta divenendo politicamente insostenibile e la vittoria militare non sembra all’orizzonte: l’unica carta presente nel mazzo “israeliano” nel lungo periodo è quella del genocidio, ribadito anche con il voto della Knesset, il parlamento di “Israele”, che ha reso fuori legge la possibilità della nascita di uno Stato Palestinese. Quest’ultimo punto deve essere tenuto ben in considerazione dal momento che chi ora parli di una soluzione politica a due Stati, dà voce solo all’opportunismo.
In questo contesto è stata significativa l’iniziativa del governo cinese, nel luglio scorso, di ospitare i leader della Resistenza Palestinese, i quali hanno siglato un accordo per la gestione del territorio della striscia di Gaza una volta finite le ostilità, così come le chiare collaborazioni tra Mosca e Teheran soprattutto in materia militare. Le nuove potenze emergenti non stanno a guardare, insomma, e puntano a ridurre l’influenza statunitense nella regione a vantaggio della propria.
In tutto questo il governo statunitense, fatto salvo il pieno sostegno militare all’entità sionista e l’impegno anche negli altri fronti di guerra, Ucraina in primis, cerca delle soluzioni per gestire questa “patata bollente” mediorientale, come testimoniano i continui viaggi diplomatici del segretario di Stato Blinken tra Egitto, Tel Aviv e Qatar, per arrivare almeno ad una tregua temporanea. Contemporaneamente all’iniziativa diplomatica, gli Usa puntano all’intervento militare diretto, come nel caso della missione avviata contro gli Houti dello Yemen, nel tentativo di venire a capo di una presenza a dir poco scomoda in una zona strategica per il controllo dei traffici globali.
Oltre alla Resistenza Palestinese, all’Asse della Resistenza e alle iniziative di Cina e Russia, la preoccupazione degli Usa si rivolte anche all’ulteriore disgregarsi delle alleanze storiche nell’area, come quella con la Turchia che, approfittando della crisi di egemonia occidentale provocata anche dai fallimenti e dalla barbarie sionista, si sta muovendo in maniera del tutto autonoma e spregiudicata per un proprio disegno di influenza nella regione e di protagonismo globale. Lo si era già visto con il suo ruolo nel sostegno all’Azerbaigian nel conflitto che lo ha visto vincente con l’Armenia, sostenuta dalla Francia. Oggi la candidatura di Ankara all’entrata nei Brics è uno smacco per gli Usa e per l’intera Alleanza Atlantica, di cui la Turchia, va ricordato, costituisce il secondo esercito per numero di uomini dopo quello statunitense. Così come costituiscono una sfida le mosse diplomatiche di Erdogan, che sta tentando una riconciliazione con tutti i suoi storici nemici della regione, dall’Egitto di Al Sisi alla Siria, filoiraniana, di Assad.
Dalla guerra in Europa all’Europa in guerra
L’Ucraina è in difficoltà: pesano i colpi delle offensive russe, la perdita di visione militare strategica e i fallimenti delle offensive per riconquistare il territorio perduto dal 2022. Tutto ciò determina realisticamente il possibile crollo dello Stato ucraino. Per evitare questa possibilità, gli Usa, l’Ue e la Nato devono iniettare fondi quanto mai giganteschi e tali da poter garantire il funzionamento non solo della macchina bellica ucraina, ma dell’esistenza stessa dell’Ucraina come Stato, inteso come stipendi, servizi, pensioni ecc. In aggiunta a questo, l’ammorbidire i “lacci” ai mastini di Kiev rispetto al colpire i russi ben oltre la linea del fronte fa il gioco dell’escalation “controllata”, la quale dimostra che politicamente gli Usa, almeno sotto l’amministrazione Biden, sono pronti a tutto, in prospettiva persino a scendere in campo. La recente incursione Ucraina nella regione di Kursk testimonia una minacciosa spregiudicatezza nella casta politico-militare Ucraina, come anche il rimpasto di governo dopo le dimissioni di quattro ministri, tra cui quello degli esteri Kuleba, seguito immediatamente all’operazione. Questa campagna militare dell’Ucraina aveva lo scopo di alleggerire il fronte nel Donbass, sperando nello spostamento di truppe russe dal Donbass alla regione di Kursk, per presentarsi al tavolo degli alleati occidentali come una formazione militare aggressiva e capace ancora di colpire. Il non aver abboccato all’esca ed il costante avanzamento russo nella regione contesa dal 2022 fa gelare la schiena ai banderisti ucraini, i quali rischiano il collasso del fronte.
In tutto questo l’Europa si barcamena nella crisi economica che morde, basti guardare le micragnose crescite del Pil dell’eurozona e la recessione conclamata della Germania. E intento cerca di capire la sua disposizione militare post elezioni statunitensi: se sarà con una Nato a guida yankee con forte presenza militare a stelle e strisce sul continente, o se dovrà contare di più sulle sue forze qualora Trump diventi presidente, e in quest’ultimo caso una ancor più ampia europeizzazione del conflitto diventerebbe una prospettiva concreta. In tal senso va soprattutto l’aver deciso che la Germania, a Wiesbaden, ospiterà il centro di comando della Nato per il supporto all’Ucraina, dove verranno organizzati i trasferimenti di mezzi militari al fronte e l’addestramento dei militari di Kiev.
D’altra parte, il recente allargamento della Nato alla Svezia e alla Finlandia (quest’ultima ricordiamo fu una delle porte di ingresso dei nazisti contro l’Unione Sovietica nel 1942) ha portato ad una militarizzazione del Baltico e l’estendersi del fronte dal Mar Nero fino al circolo polare artico.
Dal punto di vista della sovrastruttura delle istituzioni europee, le recenti elezioni hanno confermato una dirigenza di ferrei intenti bellicisti anti-russi, con l’estone Kaja Kallas commissaria Ue agli Esteri ed il lituano Andrius Kubilius alla difesa, rappresentanti dei paesi baltici che, insieme alla Polonia, sono la prima linea del fronte europeo contro la Russia, non solo geograficamente.
Sono da registrare tuttavia le grosse difficoltà che l’aggregato europeo, soprattutto Francia e Germania, ha nel compattarsi rispetto alla guerra. Le recenti tornate elettorali in questi due paesi hanno mostrato difatti delle profonde fratture tra i partiti della guerra e le masse popolari, e in Francia Macron addirittura ha effettuato una sorta di colpo di Stato coi guanti, escludendo la sinistra dal salire al governo nonostante la vittoria elettorale. Analogamente in Germania, nell’est le ultime tornate elettorali hanno fatto traballare il governo Scholtz, con la crescita esponenziale di partiti che non vogliono la guerra con la Russia.
In tutto questo, la nostrana formazione imperialista cerca i suoi spazi di rappresentazione nel blocco occidentale con il governo Meloni che scalpitava per aggiudicarsi la rappresentanza speciale dell’Alleanza Atlantica nel fronte Sud, rimanendo frustrato, visto che la scelta è ricaduta sullo spagnolo Colomina. La mancata nomina di un italiano, nonostante il tentativo di Meloni di presentarsi come inquadrata perfettamente nei piani strategici atlantici, riguarda probabilmente la rivalità italo- francese sull’Africa, a partire proprio dai paesi limitrofi al “territorio della Nato”, la Libia in primis.
La guerra in Donbass, che ha cambiato sostanzialmente la realtà europea, si determina come fronte di un conflitto che può diventare l’innesco di una conflagrazione ancora più grande, a cui il blocco occidentale si sta preparando, affilando le sue lame e preparandosi allo scontro. [3]
Il quadrante orientale
In estremo oriente il nodo strategico della tendenza alla guerra imperialista è Taiwan. Nonostante le storiche e ripetute garanzie yankee alla Cina riguardo la “non interferenza” nella politica di riunificazione, considerata ineluttabile dal gigante asiatico, si susseguono le provocazioni e la militarizzazione del Mar Cinese è sotto gli occhi di tutti.
La visita di Nancy Pelosi, al tempo speaker della camera Usa, nell’agosto 2022, è stata un grosso campanello d’allarme per il dragone, dal momento che ha segnato l’escalation politico-militare degli Usa nel Mar Cinese Meridionale. Tale visita è stata un momento di rottura dal momento che formalmente gli Stati Uniti hanno riconosciuto Taiwan come parte inalienabile della Repubblica Popolare Cinese dagli accordi tra Nixon e Mao nel 1972, e nessuna visita di funzionari di alto livello Usa era mai avvenuta.
Le elezioni a Taiwan, all’inizio di quest’anno, hanno ribadito ancora una volta la vicinanza politica tra Formosa e gli Usa, il che ha causato l’inasprimento dei rapporti, già tesi, con Pechino, che ha promosso nuove esercitazioni militari nel mare e vicino alle coste adiacenti all’isola.
Rispetto al pericolo della riunificazione cinese, gli Usa si stanno muovendo a tre livelli. Da un lato stanno conducendo un processo di reshoring [4] nella produzione di chip (con l’apposito Chip Act) in modo da rendersi indipendenti dalle produzioni sia in Cina che a Taiwan. Dall’altro, gli Usa stanno militarizzando, con i propri alleati, il Mar Cinese Meridionale: le portaerei statunitensi vanno e vengono dall’Estremo Oriente, cioè da una condizione di guerra fredda, al Medio Oriente, per coprire e supportare i sionisti nella loro guerra contro i popoli della regione. Persino l’Italia ha deciso di schierare la portaerei Cavour, una fregata e un pattugliatore nel Mar Cinese Meridionale, a fianco delle forze statunitensi e australiane, in funzione di contenimento della Cina. Infine, il terzo livello di intervento degli Usa è quello di armare gli alleati regionali, in modo da creare una catena di contenimento della Cina, come anche della Corea Democratica.
Il Giappone ha iniziato la corsa al riarmo, come rivela l’incremento della spesa militare dall’1% al 2% del Pil e nonostante sia il secondo paese al mondo per numero di basi e soldati statunitensi sul proprio suolo. La Corea del Sud, oltre a ospitare 30 mila soldati statunitensi, ha aumentato pesantemente gli investimenti per la “difesa” negli ultimi anni, arrivando a toccare, il prossimo anno, la cifra di 46,3 miliardi dollari, tanto che ora costituisce anche la principale fornitrice di carri armati per la Polonia. Ora il regime di Seul discute di dotarsi della bomba atomica e gli Usa hanno già ufficialmente annunciato, nella primavera scorsa, di ripristinare lo stanziamento di ordini nucleari in Corea, che era venuto meno dopo lo scioglimento dell’Urss e oggi sarebbe necessario difronte alla cosiddetta minaccia nordcoreana.
Infine vi è il riarmo dell’Australia, membro dei Five Eyes, il coordinamento di controllo e spionaggio globale, includente anche Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Nuova Zelanda, dell’Aukus, l’alleanza militare Regno Unito e Stati Uniti e del Quad, la cosiddetta Nato del Pacifico, formata assieme a India e Giappone. Il governo di Canberra intende raddoppiare la flotta navale, dotandosi anche di sottomarini a propulsione nucleare, e portare la spesa militare complessiva al 2,4% del Pil nel 2030. Già quest’anno lo stanziamento annunciato da parte del governo laburista di Albanese è stato superiore ai 54 miliardi.
Fuori e dentro dallo schema yankee, un colosso si muove per guadagnarsi il suo spazio vitale nel quadrante asiatico: l’India. Giocatrice d’azzardo che, nel suo piano strategico, contende alla Cina porzioni di egemonia nel continente e quindi partecipa ad alleanze come il Quad, ma allo stesso tempo è parte dei Brics, i quali, lo sottolineiamo ancora una volta, vanno intesi non come un blocco granitico, ma come una piattaforma all’interno del quale ogni soggetto si muove per i propri interessi.
L’Asia, infine, si caratterizza come un continente fortemente instabile. La Birmania è zona di guerra dal 2021, con i ribelli sostenuti dalla Cina e i governativi appoggiati dall’India. Il Pakistan ha visto, nel 2022, la rimozione e l’arresto del primo ministro Imran Khan, in una sorta di golpe
patrocinato dagli Usa, visto il suo posizionamento internazionale vicino a Russia e Cina. Il Bangladesh, quest’estate, è stato teatro di una sanguinosa ed eroica rivolta popolare che ha rovesciato il regime filoindiano di Sheik Hasina, al potere dal 2009. In Thailandia, il regime, retto principalmente dalla monarchia e dai militari, ha deciso per lo scioglimento del principale partito di opposizione, che aveva vinto le elezioni del 2024, preservando l’assetto di potere sorto dal golpe del 2014.
Tale instabilità è la sintesi tra il malcontento di massa determinato dalla crisi internazionale del capitalismo e dai nuovi assetti internazionali – riassumibili con la formula del multipolarismo di guerra – che vedono nuove e vecchie potenze contendersi e spartirsi aree del pianeta, mettendo in discussione i tradizionali equilibri e alimentando la tendenza alla guerra.
Popoli vs. imperialismo in Africa, Oceania, America…
In Africa, i paesi del Sahel – Niger, Burkina Faso e Mali – si confermano l’avanguardia antimperialista del continente: cacciando le truppe statunitensi e francesi dai propri territori, nazionalizzando le aziende legate all’estrazione di materie prime, proiettando un’indipendenza economico-finanziaria, tentando di sviluppare una propria moneta e instaurando un’alleanza militare contro possibili aggressioni imperialiste o delle borghesie compradore dei paesi vicini. Insomma, la crisi egemonica occidentale è ben visibile nell’azione decolonizzatrice da parte dei governi di questi tre paesi.
L’imperialismo francese deve fronteggiare la volontà di liberazione dei popoli non solo in Africa, ma anche in Oceania, con i sommovimenti nella Nuova Caledonia. Qui la popolazione autoctona a maggio scorso ha messo in atto una rivolta indipendentista contro Parigi come non se ne vedevano dagli anni ottanta, che ha portato le autorità alla proclamazione dello stato di emergenza, con tanto di coprifuoco.
In America Latina, la vittoria elettorale di Maduro, ad agosto, ha scatenato una nuova campagna mediatica, politica e militare, guidata dagli imperialisti Usa, per rovesciare la Repubblica Bolivariana e recuperare il controllo neocoloniale di uno dei paesi più ricchi di petrolio a livello globale. La vittoria di Maduro conferma la tendenza oramai più che ventennale di un’America Latina che non accetta più di essere il cortile di casa degli yankee, anche se la guida di tale processo appartiene a fazioni borghesi socialdemocratiche, spesso peraltro fortemente divise fra di esse e persino al loro interno. Tanto per fare un esempio: i governi di sinistra brasiliano e colombiano hanno esplicitamente richiesto un rinnovo del voto venezuelano, accodandosi di fatto alla campagna imperialista contro Maduro. E all’interno della Bolivia, il governo in mano al Movimento al Socialismo, partito storicamente guidato da Evo Morales, sta trovando in quest’ultimo il suo principale oppositore, a capo di un malcontento popolare sempre più forte viste le difficili condizioni di vita della popolazione e la corruzione dell’esecutivo.
Lo schieramento di mercenari russi nel Sahel, le bandiere azere in mano ai Canachi e gli appelli di Maduro a Russia, Cina e Iran perché difendano il Venezuela, ci dicono di come le contraddizioni che muovono la fase, quella imperialismo-popoli oppressi e quella interimperialista, tendano a legarsi nel loro sviluppo e nel quadro complesso del multipolarismo di guerra. Questo non deve essere motivo di impedimento, per noi comunisti, nel saper cogliere e appoggiare con chiarezza il tentativo dei popoli oppressi di ricavarsi, in questa situazione concreta, uno spazio di autodeterminazione, vista la crisi delle potenze imperialiste storicamente (e sanguinosamente) dominanti, Usa e Francia in testa.
In questo contesto, resta comunque centrale il ruolo della Resistenza Palestinese, che rappresenta una sfida strategica non solo al regime sionista, ma all’intero blocco imperialista occidentale. Essa ci insegna la forza che i popoli e le classi oppresse possono esercitare per trasformare il mondo, anche senza “santi protettori” a Mosca o Pechino, contando innanzitutto sulle proprie forze. Inoltre i partigiani palestinesi dimostrano che il nemico si può colpire in profondità, e se si può colpire così, si può anche sconfiggere.
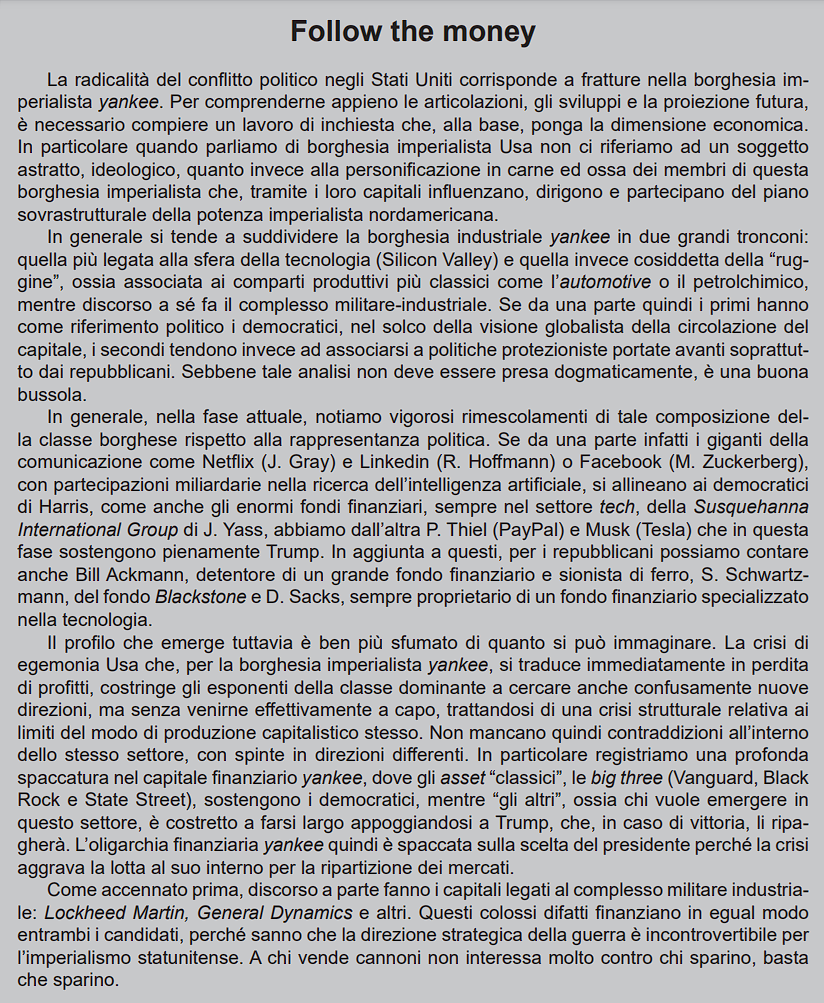
Su questo solco, il nostro compito quindi è costruire dibattito, formazione e organizzazione nel contesto di lotta alla guerra, tenendo a mente che solo i popoli e le classi oppresse possono fermare la guerra. Nessuna crisi delle vecchie formazioni imperialiste e nessuna affermazione delle nuove potenze imperialiste possono rallentare o sviluppo della tendenza alla guerra, anzi lo accelerano. Solo i popoli e le classi oppresse, tramutando la guerra o la tendenza alla guerra in lotta rivoluzionaria, possono fermare la guerra e distruggere la sua causa generatrice: il sistema capitalista.
Note:
[1] Vedi, in questo numero, scheda a p. 25
[2] Vedi Antitesi n° 15, Il gigante vacilla, pp. 26-36
[3] Vedi anche supra La difesa comune europea, nel primo articolo di prima sezione, pp. 11 e ss.
[4] Vedi, in questo numero, la scheda a p. 25
Follow the money
La radicalità del conflitto politico negli Stati Uniti corrisponde a fratture nella borghesia imperialista yankee. Per comprenderne appieno le articolazioni, gli sviluppi e la proiezione futura, è necessario compiere un lavoro di inchiesta che, alla base, ponga la dimensione economica.
In particolare quando parliamo di borghesia imperialista Usa non ci riferiamo ad un soggetto astratto, ideologico, quanto invece alla personificazione in carne ed ossa dei membri di questa borghesia imperialista che, tramite i loro capitali influenzano, dirigono e partecipano del piano sovrastrutturale della potenza imperialista nordamericana.
In generale si tende a suddividere la borghesia industriale yankee in due grandi tronconi: quella più legata alla sfera della tecnologia (Silicon Valley) e quella invece cosiddetta della “ruggine”, ossia associata ai comparti produttivi più classici come l’automotive o il petrolchimico, mentre discorso a sé fa il complesso militare-industriale. Se da una parte quindi i primi hanno come riferimento politico i democratici, nel solco della visione globalista della circolazione del capitale, i secondi tendono invece ad associarsi a politiche protezioniste portate avanti soprattutto dai repubblicani. Sebbene tale analisi non deve essere presa dogmaticamente, è una buona bussola.
In generale, nella fase attuale, notiamo vigorosi rimescolamenti di tale composizione della classe borghese rispetto alla rappresentanza politica. Se da una parte infatti i giganti della comunicazione come Netflix (J. Gray) e Linkedin (R. Hoffmann) o Facebook (M. Zuckerberg), con partecipazioni miliardarie nella ricerca dell’intelligenza artificiale, si allineano ai democratici di Harris, come anche gli enormi fondi finanziari, sempre nel settore tech, della Susquehanna International Group di J. Yass, abbiamo dall’altra P. Thiel (PayPal) e Musk (Tesla) che in questa fase sostengono pienamente Trump. In aggiunta a questi, per i repubblicani possiamo contare anche Bill Ackmann, detentore di un grande fondo finanziario e sionista di ferro, S. Schwartzmann, del fondo Blackstone e D. Sacks, sempre proprietario di un fondo finanziario specializzato nella tecnologia.
Il profilo che emerge tuttavia è ben più sfumato di quanto si può immaginare. La crisi di egemonia Usa che, per la borghesia imperialista yankee, si traduce immediatamente in perdita di profitti, costringe gli esponenti della classe dominante a cercare anche confusamente nuove direzioni, ma senza venirne effettivamente a capo, trattandosi di una crisi strutturale relativa ai limiti del modo di produzione capitalistico stesso. Non mancano quindi contraddizioni all’interno dello stesso settore, con spinte in direzioni differenti. In particolare registriamo una profonda spaccatura nel capitale finanziario yankee, dove gli asset “classici”, le big three (Vanguard, Black Rock e State Street), sostengono i democratici, mentre “gli altri”, ossia chi vuole emergere in questo settore, è costretto a farsi largo appoggiandosi a Trump, che, in caso di vittoria, li ripagherà.
L’oligarchia finanziaria yankee quindi è spaccata sulla scelta del presidente perché la crisi aggrava la lotta al suo interno per la ripartizione dei mercati.
Come accennato prima, discorso a parte fanno i capitali legati al complesso militare industriale: Lockheed Martin, General Dynamics e altri. Questi colossi difatti finanziano in egual modo entrambi i candidati, perché sanno che la direzione strategica della guerra è incontrovertibile per l’imperialismo statunitense. A chi vende cannoni non interessa molto contro chi sparino, basta che sparino.




