La questione femminile
La lotta delle donne e la lotta al riformismo
“Controrivoluzione ed egemonia di classe” da Antitesi n.11 – pag.56
Un esempio eloquente, storico e attuale, per studiare e comprendere come l’influenza dell’ideologia borghese investa il movimento di classe e quello antagonista ci viene offerto dalla questione femminile.
Emblematica, a questo proposito, è la gestione della batosta subita in Afghanistan dall’imperialismo occidentale, con a capo gli Usa. Oggi si strappano le vesti paventando un futuro spaventoso per le donne utilizzando una contraddizione, reale, che attraversa la società afghana, per nascondere i veri interessi predatori che hanno causato vent’anni di intervento militare costato quasi 250 mila morti e 2.330 miliardi di dollari. Siamo abituati alle menzogne, ma ci fa specie che questa “versione in rosa” sia abbracciata anche da parti della sinistra antagonista.
In questo articolo non ci basta solo affermare che le idee borghesi siano sbagliate, consci che rappresentino il prodotto della classe borghese stessa, ma vogliamo provare ad affermare il nostro punto di vista, quello della nostra classe e dei comunisti.
Cercheremo così di esaminare a fondo la questione femminile, andando all’origine del problema per comprendere le contraddizioni che ha creato all’interno del dibattito comunista e per poter mettere in evidenza gli errori e le deviazioni che permettono all’ideologia del nemico di classe di influenzare il nostro campo.
Le ideologie discendono dai rapporti sociali tra le classi e sono espressione e strumento di egemonia delle diverse classi sociali. Nella fase del capitalismo monopolista, quella in cui ci troviamo oggi, lo scontro tra borghesia imperialista e proletariato ha il suo riflesso ideologico in quello tra l’ideologia borghese, ovvero metafisica e idealismo, e l’ideologia del proletariato, ovvero il materialismo dialettico. È in questo scontro contraddittorio che si sviluppa quest’ultima, l’ideologia della nostra classe. Anche nei movimenti si riversa questo scontro: è una lotta incessante per l’affermazione o della direzione borghese o di quella proletaria. La mentalità metafisica e idealistica, che come comunisti dobbiamo combattere, all’origine era anche un prodotto dell’ignoranza e della superstizione, ma con lo sviluppo delle forze produttive, e quindi della scienza, non è stata sconfitta, anzi. Questo perché le ideologie non sono il mero e semplice riflesso dello sviluppo delle forze produttive, ma dei rapporti tra le classi in senso più complessivo, dei rapporti di forza tra di esse che si riversa nel campo della sovrastruttura. La lotta tra idealismo e materialismo è dunque un prodotto della divisione in classi nella società, oggi quella borghese: questa lotta non cesserà fino a quando non verrà interamente superata.
Torna dunque utile andare all’origine di questo scontro, cercheremo di farlo nello specifico della questione che qui trattiamo, quella femminile, per vedere come si è sviluppato nel concreto nel corso della storia fino ai nostri giorni. Vedremo così come tutte le problematiche che ci troviamo di fronte oggi siano state già presenti fin dall’inizio. Dallo studio degli scritti di un’autorevole compagna, Clara Zetkin1 (non a caso “dimenticata” dalla sinistra borghese, pur essendo colei che ha propose l’istituzione dell’8 Marzo come giornata internazionale della donna) emerge con chiarezza che il principale male che ha ostacolato l’avanzamento del movimento delle donne in senso rivoluzionario è il riformismo. E proprio come lo era ieri, è quella contro il riformismo la battaglia principale da affrontare oggi.
Oggi, pur di fronte agli evidenti insuccessi delle ipotesi riformiste nel risolvere o migliorare le condizioni del proletariato e delle masse popolari, il riformismo impregna il campo di classe e la pratica dei movimenti: questo è lampante nella questione della donna.
Abbiamo già affrontato in Antitesi numero 6 come la questione della contraddizione di genere si origini dalla proprietà privata, divenuta poi centrale nel capitalismo. Questo ci ha permesso di puntualizzare, fin da subito, che la principale deviazione sulla questione femminile è stata storicamente quella di porre la risoluzione della stessa principalmente come questione tra i generi e non di classe, mettendo dunque al centro la contraddizione secondaria. Facendo questo si abdica alla rivoluzione e si lavora per migliorare e riformare l’esistente.
Sono le donne proletarie che, con il loro protagonismo, devono porre la questione in una veste politica e di classe.
Riprendiamo Clara Zetkin
Per partire col piede giusto andiamo alle fonti del dibattito nel movimento comunista. Nel testo di Clara Zetkin La questione femminile e la lotta al riformismo2 emerge nitidamente come gli avanzamenti della lotta e delle conquiste delle donne siano stati legati ai progressi avvenuti nella lotta interna al movimento comunista contro le concezioni revisioniste.
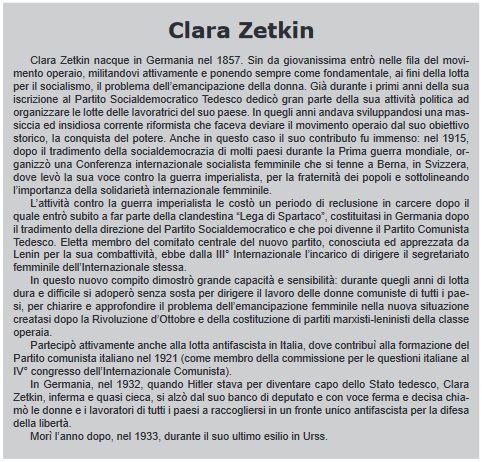
Già nel 1889, al Congresso di fondazione della Seconda Internazionale, Clara partecipa come delegata delle donne socialiste di Berlino, dando avvio all’impegno militante di tutta la sua vita, l’organizzazione del movimento internazionale femminile proletario. Interviene sui diritti della donna dentro e fuori il movimento operaio e lega questo tema alla lotta di classe contro il dilagante riformismo del Partito Socialdemocratico Tedesco; ingloba fin da subito la questione femminile nella questione sociale.
Il testo di Clara attraverso il tema della questione femminile permette di esaminare in concreto un’articolazione della lotta contro il riformismo, che all’epoca era argomento centrale nel dibattito comunista. In quella fase storica di affermazione dell’imperialismo, segnata dal passaggio dalla concorrenza al monopolio, il movimento comunista era in ascesa, anche al suo interno si scontrano le due concezioni del mondo, quella proletaria e quella borghese.
Il lavoro di analisi di Clara Zetkin copre tutto il periodo che va dalla fondazione della Seconda Internazionale (1889) fino al 1933, un lasso di tempo nel quale si registrano numerosi stravolgimenti, compresa la Rivoluzione d’Ottobre e la Prima guerra mondiale. A fronte delle contraddizioni interimperialiste scatenate da quest’ultima e di quella tra paesi imperialisti e popoli oppressi, Clara mette in luce l’importanza della questione femminile, affrontando il rapporto tra le rivendicazioni di tipo riformista e la lotta per la rivoluzione socialista e il rapporto tra l’autonomia dei movimenti di massa e l’egemonia dei comunisti organizzati in partito. Partendo dal particolare della lotta per il diritto di voto e da quella per il diritto al lavoro delle donne emergono tutte le sfaccettature delle varie posizioni che hanno caratterizzato le dispute interne al movimento comunista.
Secondo Zetkin le riforme devono essere “soltanto un mezzo per rendere il proletariato più agguerrito nelle lotta”3, altrimenti le riforme serviranno solo alla borghesia. Questo è ciò che afferma la compagna Clara in molti dei suoi discorsi e dei suoi scritti, nei quali insiste anche sull’obbiettivo di conquistare le donne al socialismo, produrre militanti (una sua espressione ricorrente) per la causa rivoluzionaria.
Il suffragio femminile per borghesia era un ideale “illuminista” di uguaglianza e giustizia “naturale”, per il proletariato invece, come sostiene Zetkin non era lotta per un diritto “naturale”, ma sociale, fondato sull’inserimento della donna nei rapporti di produzione. E in questa, come in tutte le altre problematiche che riguardano le donne proletarie, esiste coincidenza con la questione della condizione generale del proletariato nella fase determinata storicamente.
La lotta per l’uguaglianza giuridica è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per la liberazione delle masse femminili e proletarie e tutti i partiti socialisti avrebbero dovuto intraprendere la lotta per l’introduzione del suffragio universale: “è dovere del movimento femminile socialista (…) di partecipare a tutte le lotte indette dai partiti socialisti per la democratizzazione del diritto di voto” anche se “non sopprime la contraddizione di classe tra sfruttatori e sfruttati (…)” ma riveste funzione positiva poiché “prepara il terreno nel quale questi conflitti raggiungeranno la massima acutezza”4.
Questo è in sintesi ciò che emerge dalla risoluzione che Clara presenta al Congresso socialista internazionale di Stoccarda nel 1907, nella quale specifica che il diritto di voto per i socialisti non può essere l’obiettivo finale come per le donne borghesi, ma un’arma per altre battaglie quali, la più importante, il diritto al lavoro e i diritti nel rapporto tra lavoro e maternità, ma sopratutto un passaggio della lotta per la rivoluzione proletaria. L’equiparazione politica della donna proletaria consentirà ad essa un maggior protagonismo nelle lotte, che scuoteranno la sua coscienza in senso classista, fino alla sua partecipazione alla lotta fondamentale per la conquista del poter politico da parte del proletariato. Zetkin combatté strenuamente contro le posizioni per il diritto al voto limitato5 sostenute dai revisionisti con la giustificazione che per vincere si sarebbero ottenuti più voti con questa rivendicazione. Queste posizioni opportuniste mettevano in luce come l’obbiettivo della lotta non fosse finalizzato al rovesciamento della società borghese, ma ad un suo miglioramento nel quadro degli assetti esistenti.
Al Congresso della Seconda Internazionale, sempre nel 1907, viene adottata una risoluzione che impegna i partiti socialdemocratici a condurre le lotte per il diritto al voto senza distinzioni di sesso e, nella stessa risoluzione, si dichiara che in caso di guerra la situazione doveva essere sfruttata per l’abbattimento del capitalismo. Questo Congresso fece propria la risoluzione della prima Conferenza internazionale femminile socialista che l’aveva preceduto di poco. L’epilogo di questi due consessi, e della lotta che si sviluppò al loro interno contro le posizioni revisioniste, fu sancito con l’avvento della prima guerra mondiale, in particolare con il tradimento dell’internazionalismo operato da parte delle socialdemocrazie, con il voto per i crediti di guerra e con la rinuncia alla lotta per il diritto di voto alla donna senza restrizioni da parte, ad esempio, dei socialisti francesi e belgi.
Il dibattito e lo scontro su questi temi, che avevano come origine posizioni riformiste, provocherà la fine della Seconda Internazionale.
Nel suo impegno contro il riformismo, Clara si trovò affiancata da August Bebel6 e Rosa Luxemburg. Molto interessante fu l’accanito scontro contro Bernstein7 nel Congresso del Partito Socialdemocratico Tedesco del 1898, scontro avvenuto sia sulla questione del diritto al voto sia del lavoro femminile, all’insegna della domanda “Riforma sociale o rivoluzione?”.
La controversia con i riformisti diventò ancora più chiara sul tema del lavoro. Analizzando lo sviluppo del movimento femminile, Clara osservava come la rivoluzione borghese tedesca (1848/49) non avesse compiuto nessun passo in avanti rispetto alle conquiste della Rivoluzione francese. Dopo mezzo secolo di storia, nel quale si stava affermando il capitalismo, le basi del movimento femminile si rifacevano totalmente al femminismo borghese.
La questione del lavoro femminile, in Germania, discendeva fino ad allora, dalle contraddizioni dentro alla borghesia, sviluppatesi nell’ascesa del capitalismo e generate dalla concorrenza tra le professioni liberali, di fronte all’aspirazione delle donne borghesi ad accedervi, visto che in queste professioni vigeva il monopolio dell’uomo.
La dissoluzione dell’economia familiare, la vecchia economia domestica produttiva, non fu solo conseguenza, ma anche presupposto dello sviluppo dell’industria capitalistica. L’entrata nel mondo del lavoro anche delle donne proletarie evidenziò, da subito, come le donne fossero inglobate nel mercato del lavoro poiché soggetti più deboli e più sfruttabili. A fronte di questa lampante verità, che mostrava come il pesante sfruttamento della donna dipendesse dal capitalismo e dalla sua sete di profitto, il dibattito sul tema del lavoro della donna, pian piano, si spostò sulla questione di classe, sugli interessi delle donne proletarie.
Inizia così, con l’entrata massiccia delle donne nel mercato del lavoro, il cammino del movimento femminile proletario, in contemporanea con la maturazione della concezione socialista della società. All’inizio della controversia sul lavoro femminile emergono molte posizioni contro il lavoro alle donne nell’industria. Le motivazioni addotte erano varie, ma la principale era l’ipotesi di abbassamento dei salari dopo il loro ingresso nell’industria. Questa posizione, sostenuta inizialmente da Lassalle8, fa il paio con quella che lo stesso aveva sul diritto di voto alle donne, per le quali proponeva il “diritto di voto limitato” ed evidenzia come già, fin dalle origini il movimento femminile proletario per affermarsi dovette scontrarsi con posizioni opportuniste e riformiste. Ad esempio, ancor prima della Zetkin, nel 1866, Louise Otto Petters9 aveva polemizzato con la socialdemocrazia lassalliana scrivendo l’opuscolo “Il diritto delle donne al lavoro”.
Questo dibattito, svoltosi all’origine del movimento femminile proletario, ci insegna come la questione del lavoro, quindi di classe, sia centrale per l’emancipazione della donna. Il capitalismo impone alle donne una doppia oppressione (di classe e di genere), ma allo stesso tempo crea anche le condizioni per la loro liberazione. Questa centralità vale ancora di più oggi: infatti, nonostante sia passato più di un secolo, la situazione della donna nel mondo del lavoro (tra salari più bassi, lavori precari, mancanze di diritti, licenziamenti più facili) si aggrava sempre più a fronte degli attacchi che i padroni sferrano contro di noi per far fronte alla loro crisi e che comportano per la classe operaia e proletaria il peggioramento sempre più drastico delle condizioni di vita.
Prostituzione, questioni sessuali, privato e politico
Sempre riguardo al dibattito nel movimento comunista è illuminante, nella sua chiarezza e semplicità, lo scritto di Clara Zetkin contenuto in appendice al testo di Lenin “L’emancipazione della donna”10. Un’appassionata conversazione tra Lenin e Zetkin pubblicata nel 1925, un anno dopo la morte di Lenin, e che a quasi 100 anni di distanza rimane incredibilmente attuale.
Una delle prime considerazioni che fa Lenin sull’apporto delle donne lavoratrici alla Rivoluzione d’Ottobre è che “A Pietroburgo e a Mosca, nelle città e nei centri industriali, il comportamento delle donne proletarie fu superbo. Senza di loro, molto probabilmente non avremmo vinto”(…) “La prima dittatura del proletariato apre veramente la strada verso la completa eguaglianza sociale della donna. Sradica più pregiudizi essa che non le montagne di scritti sull’uguaglianza femminile”11. Ponendo molte domande a Clara, nel colloquio Lenin si informa su cosa le dirigenti comuniste insegnino alle compagne, dando a ciò un’importanza decisiva per il lavoro da svolgere tra le masse e afferma: “A questo proposito, ho sentito dire da compagni russi e tedeschi strane cose (…) una comunista molto qualificata pubblica ad Amburgo un giornale per le prostitute e tenta di organizzare queste donne per la lotta rivoluzionaria. Rosa (Luxemburg ndr) ha agito da comunista scrivendo un articolo in cui difendeva le prostitute (…). Doppiamente vittime della società borghese, le prostitute meritano di essere compiante. Esse sono vittime, innanzi tutto, del maledetto sistema della proprietà, poi del maledetto moralismo ipocrita (…). Tuttavia non si tratta di considerare le prostitute come, per così dire, un settore particolare del fronte rivoluzionario e di pubblicare per esse un apposito giornale (…) la prostituzione, anche nel nostro paese, porrà davanti a noi numerosi problemi di difficile soluzione. Si tratta di ricondurre la prostituta al lavoro produttivo, di assegnarle un posto nell’economia sociale (…). Ecco un aspetto della questione femminile che, dopo la conquista del potere da parte del proletariato, ci si pone in tutta la sua ampiezza ed esige di essere risolto”12.
Lenin critica anche i modi con cui in Germania venivano dedicati opuscoli e discussioni sulla questione sessuale. Dice: “La situazione della Germania esige la massima coesione di tutte le forze rivoluzionarie proletarie per respingere gli attacchi sempre più vigorosi della controrivoluzione. Ed ora, proprio ora, le comuniste attive trattano la questione del sesso”13. Aggiunge che l’opuscolo in questione, nonostante si rivesta di forme sovversive, in realtà, ha un rispetto velato per la morale borghese e conclude: “Per questo genere di occupazione non c’è posto nel partito, tra il proletariato che lotta ed ha una coscienza di classe” “quell’opuscolo lo si raccomanda e si diffonde invece di criticarlo. A che cosa conduce in fin dei conti? A questo: che i problemi sessuali e matrimoniali non sono visti come una parte della principale questione sociale e che, al contrario, la grande questione sociale stessa appare come una parte, un’appendice del problema sessuale. La questione fondamentale è ricacciata in secondo piano”14.
Lenin si mostra molto preoccupato del fatto che questo dibattito, promosso anche da compagne del partito, influenzi molto i giovani e afferma: “Anche da noi una parte della gioventù lavora assiduamente a rivedere la concezione borghese della “morale” nei problemi sessuali. Ed è, debbo dirlo, l’élite della nostra gioventù, quella che realmente promette molto (…). Nelle condizioni create dalla guerra e dalla rivoluzione, gli antichi valori ideologici crollano, perdono di forza. I nuovi valori non si cristallizzano che lentamente, con la lotta (…). Ciò è egualmente vero nel campo dei rapporti sessuali, per il matrimonio e la famiglia. La decadenza, la putrefazione, la melma del matrimonio borghese e della famiglia con la libertà per il marito e la schiavitù per la moglie, la menzogna infame della morale sessuale e dei rapporti sessuali riempiono gli uomini migliori di un disgusto profondo (…). In questo campo si approssima una rivoluzione che corrisponde alla rivoluzione proletaria (…). La gioventù protesta contro questo stato di cose con la foga chiassosa della propria età. É comprensibile. Nulla sarebbe più falso che predicare alla gioventù l’ascetismo monastico e la sanità del sudiciume borghese. Ma non è bene, secondo me, che i problemi sessuali, posti in primo piano da cause naturali, divengano in questi anni la preoccupazione principale dei giovani”15.
Anche oggigiorno la questione sessuale viene usata tra i giovani sia dalla borghesia di sinistra che dalla reazione come arma di distrazione rispetto alle contraddizioni di classe, illudendo su una possibile “emancipazione in campo sessuale” all’interno di una società oppressiva e alienante come quella capitalista.
Sempre sulla questione, Lenin critica la dirigente comunista Kollontaj16 e la sua teoria secondo la quale nella società comunista, soddisfare i propri istinti sessuali e il proprio impulso amoroso è tanto semplice e tanto insignificante quanto bere un bicchier d’acqua, affermando “Bel marxismo quello per cui tutti i fenomeni e tutte le modificazioni che intervengono nella sovrastruttura ideologica della società si deducono immediatamente e in linea diretta e senza alcuna riserva unicamente dalla base economica!(…) Io considero la famosa teoria del “bicchier d’acqua” come non marxista ed antisociale per giunta”17. Secondo Lenin, la trasformazione dei rapporti sociali e il superamento delle oppressive convenzioni borghesi, non poteva tradursi nella deresponsabilizzazione delle relazioni tra uomo e donna, nella loro riduzione a impulsi e sentimenti di passaggio, ma nell’arricchimento complessivo del rapporto di coppia e dei rapporti tra i sessi, rifondati sull’eguaglianza, la responsabilità sociale, la crescita culturale, la gioia di vivere e la pienezza dell’amore.
In tutte queste osservazioni, va rilevata la capacità di Lenin di porre sempre le questioni legandole all’analisi del momento concreto e, dunque, alla necessità di relazionarle agli obbiettivi diversi che si pongono i comunisti. Una cosa è ragionare sui paesi dove non si è ancora data la rivoluzione, altra è nella situazione dove si è data la prima rivoluzione proletaria e si è conquistato il potere. Le parole d’ordine e le linee particolari di intervento non sono legate al loro essere giuste in assoluto, ai principi concepiti in senso astratto, ma a quello che serve fare nella determinata situazione concreta per il cammino verso il comunismo. A tal proposito consigliamo la lettura delle “Direttive per il Movimento Comunista Femminile -1920”18 dove vengono specificate le rivendicazioni differenti sulle quali i comunisti devono mobilitare le donne nell’Unione Sovietica, nei paesi dove ancora si lotta per la conquista del potere politico e, infine, nei paesi caratterizzati ancora da uno sviluppo precapitalista.
Le riflessioni che Lenin fa sul sesso e i rapporti tra i sessi ci fanno anche capire quanto sia importante analizzare il concetto di privato e politico, poiché questa è una delle tematiche che hanno caratterizzato il moderno movimento femminista, in particolare a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. Si tratta del famoso slogan: “il personale è politico”. Questa concezione nasce da una impostazione idealista della realtà, personale e politico sono in relazione dialettica tra loro, e per questo distinti.
Il politico è attinente alla politica e riguarda la conquista e la gestione del potere, inteso come gestione della società; il personale è attinente all’individuo. Come in ogni contraddizione può darsi identità tra i due poli opposti, ad esempio il personale può tendenzialmente coincidere con il politico quando un individuo, donna o uomo che sia, fa una scelta di vita rivoluzionaria e cioè mette al primo posto la politica nella sua vita. Viceversa, in larga parte i politici borghesi identificano gli interessi personali con la politica.
Le problematiche relative all’individuo rimandano poi ad un’altra contraddizione, quella tra individuo e collettivo dove, comunque, l’individuo essendo un essere sociale è influenzato e determinato dai rapporti sociali dati. Chi intende rovesciare i rapporti sociali deve porsi sul terreno politico e, nella contraddizione tra individuo e collettivo mettere al centro quest’ultimo, cioè considerare principale il collettivo. Non è uno schema meccanico da applicare, è una concezione di cui appropriarci per capire e vivere la realtà formandoci come comunisti e per influire su di essa.
L’identità del personale col politico utilizzata come slogan nel movimento femminista ha fatto un brutto torto al politico, relegandolo come secondario e mettendo al centro il personale, sviluppando negli anni Settanta l’autoriflessione, l’autocoscienza, il separatismo. Questa impostazione teorizza che dall’analisi del personale e dalla rettifica delle idee e dei comportamenti individuali si giunge alla coscienza che i problemi derivano dalla società e, conseguentemente/successivamente, ci si potrà porre il problema di trasformarla. Oppure che, cambiando la dimensione personale, contemporaneamente si possa trasformare la società.
Si può fare un parallelo con l’impostazione che teorizza che dalla lotta per le rivendicazioni economiche scaturisca la lotta politica, impostazione che Lenin, nel “Che fare?”, critica aspramente. Questa concezione ha spalancato le porte all’uso da parte riformista delle lotte delle donne.
Facendo un esempio concreto sarebbe come, riguardo ad una contraddizione oggi divenuta acuta, quella tra uomo e natura, che i problemi dell’ambiente si risolvano principalmente attraverso i comportamenti individuali, la coscienza dell’individuo ecc. Negare la centralità del politico ha permesso all’ideologia dominante, quella borghese, di influenzare, depotenziare e mettere sotto la propria ala le questioni poste dalle donne. Per noi comunisti, che pensiamo che la contraddizione di genere si risolva alla luce della contraddizione di classe attraverso il rivoluzionamento dei rapporti sociali, non mettere come principale il politico significa togliere potenzialità alla forza inarrestabile che le donne possono mettere in campo per liberarsi dalla loro doppia oppressione: patriarcale, di classe e, in taluni casi, nazionale o di razza (pensiamo alle palestinesi o alle immigrate). Considerando che esistono donne proletarie e donne borghesi, se non si mette al primo posto la questione politica e di classe, è gioco facile per la borghesia “illuminata” depotenziare e fagocitare la lotta delle donne.
Spezzare le catene, rompere gli schemi, ribellarsi ai ruoli nella famiglia e a quelli sessualmente determinati, rifiutarsi di essere oggetti sessuali o macchine riproduttive è parte della lotta generale di classe. E non è una passeggiata, l’oppressione è secolare. Oggi questo concetto è andato perduto, l’egemonia borghese impera. Ciò porta ad un allontanamento dalla questione principale, quella di classe e alla riscoperta dell’”intersezionalità”19.
Abbiamo analizzato come storicamente la famiglia monogamica sia nata sulla base della proprietà privata e si sia affermata col capitalismo. Con il suo avvento il matrimonio è stato definito sulla base della proprietà del patrimonio da parte dell’uomo e, di fatto, come forma della proprietà anche della donna da parte dell’uomo20.
Dove ci sono state esperienze di abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione come, ad esempio in Unione Sovietica dopo la Rivoluzione, si sono sviluppate conquiste per le donne fino ad allora impensabili tramite il “trasferimento” nell’intera società di molte delle responsabilità che ricadevano sulla famiglia, e quindi sulla donna, come la cura dei bambini, degli anziani, dei malati, l’alimentazione, l’abbigliamento e l’educazione. Queste conquiste hanno in parte caratterizzato anche i paesi dalla “rivoluzione mancata” come il nostro, grazie al ruolo esercitato dal movimento operaio.
Per diventare protagoniste e rompere i ruoli fin da ora dobbiamo quindi considerare principale il politico. Solo così potremo contribuire a rafforzare realmente la lotta per l’emancipazione della donna, essendo comunque consapevoli che la contraddizione di genere esisteva anche prima del capitalismo e che non si risolverà automaticamente con la rivoluzione.
Origini e attualità del movimento femminista borghese occidentale
Il movimento femminista occidentale, che ai giorni nostri ha grande seguito, compie i primi passi con il Congresso di Seneca Falls tenutosi negli Stati Uniti, a New York, nel luglio del 1848. Come sopra abbiamo descritto, solo con lo sviluppo del movimento comunista viene influenzato da una visione di classe e proletaria.
Il Congresso di Seneca Falls, al quale parteciparono circa 300 donne borghesi, diede inizio alle battaglie per rivendicare i diritti civili per le donne. Al termine dell’incontro venne stilata la Dichiarazione dei Sentimenti, che poneva alla pari la posizione di uomo e donna, in quanto dotati “dal loro Creatore di diritti inalienabili”, dichiarazione che riprendeva quella redatta nel luglio del 1776 con la quale le tredici colonie nord-americane proclamavano la loro indipendenza.
Il violatore di questi diritti era indicato nell’uomo, considerato un tiranno che opprimeva la donna in ogni situazione quotidiana. L’origine del femminismo ha dunque una radice borghese che non tocca la contraddizione di classe, ma si focalizza sulla contraddizione di genere, tra uomo e donna. Come ci segnala anche Angela Davis in “Donne, razza e classe”21 nelle sue riflessioni sulla storia della lotta per il diritto di voto negli Usa, la direzione borghese di questo movimento rivendicò il diritto di voto solo per le donne bianche e non per le donne nere, con la motivazione che così si sarebbe potuto più facilmente vincere. I fatti le smentirono: la vittoria fu riportata solo quando alla lotta parteciparono le donne lavoratrici nere, le comuniste, le sostenitrici dei minatori e molte altre.
Anche oggi il movimento femminista nelle sue svariate anime e principalmente nella sua direzione, in particolare nei paesi imperialisti, tende ad incentrare la questione della donna sull’identità, su genere e sesso, unendo di fatto le donne in una lotta che pone al centro il patriarcato, antecedente al capitalismo, e non il sistema economico in cui viviamo. In questo modo molte questioni legate all’emancipazione della donna vengono sfruttate dalla classe dominante a suo favore: dall’utilizzo della questione femminile per giustificare la guerra imperialista alla creazione del mito dell’emancipazione di genere con la carriera e l’individualismo.
La critica al patriarcato da parte del femminismo, nell’alveo delle lotte partite dal ‘68, si unì alle rivendicazioni delle comunità gay e trans ed esplose pubblicamente con i moti di Stonewall, a New York, nel giugno 1969: una sollevazione popolare in seguito ad abusi da parte della polizia contro gli omosessuali.
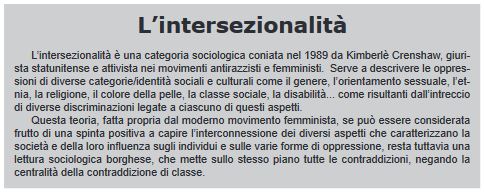
Le basi ideologiche di questi movimenti sono da rintracciare negli stessi paradigmi borghesi e liberali: la libertà individuale, il diritto di ottenere e di essere ciò che si vuole in questo tipo di sistema. Vi è sicuramente una positiva spinta alla ribellione, ma non contenuti di classe e una prospettiva rivoluzionaria. Sviluppatisi su queste basi, sono stati facile preda dell’egemonia della classe dominante, soprattutto a partire dal nuovo secolo, a fronte di una debolezza del movimento proletario. Così oggi assistiamo ad un uso diffuso del pinkwashing da parte di settori della borghesia imperialista: i brand delle multinazionali si colorano della bandiera arcobaleno, politici, economisti borghesi e mass media danno ampio spazio al movimento Lgbtqia+ e ne sostengono le rivendicazioni. I vertici dell’Ue, come Von der Leyen, se ne fanno promotori. I movimenti “di sinistra” risentono di questa ondata apparentemente progressista e molti la fanno propria senza farne un’analisi e una critica di classe, prestando il fianco al riformismo.
La borghesia imperialista e la sinistra borghese al suo servizio non hanno fatto altro che assorbire e sussumere ciò che più era funzionale al mantenimento della propria egemonia.
La classe proletaria, per saper bene interpretare e rispondere adeguatamente con una propria visione della realtà, deve basarsi sull’analisi e sugli interessi materiali della propria classe per giungere a una visione della realtà che non sia derivata in modo pedissequo da quella borghese.
Per realizzare in modo esaustivo un’analisi materialistica e dialettica è necessario svolgere un approfondito lavoro di inchiesta nei movimenti Lgbtqia+. Proponiamo quindi alcuni spunti che possano essere d’aiuto al lavoro dei compagni che intraprenderanno questo lavoro. Un primo campo di riflessione è sicuramente rinvenibile nel cambiamento della struttura familiare nell’epoca della quarta rivoluzione industriale (la nostra) nei paesi imperialisti, in particolare nelle aree metropolitane: la famiglia mononucleare nei paesi tecnologicamente più avanzati appare in evidente declino, la crescita demografica si attesta intorno allo zero e la popolazione invecchia. Gli immigrati contribuiscono, in controtendenza, a non far crollare la natalità in modo drammatico. Le cause del declino della famiglia tradizionale sono molteplici: il lavoro che impone ritmi serrati occupando gran parte della giornata, la città sempre meno umana e vivibile che scoraggia la creazione di legami, la gentrificazione che allontana le classi meno abbienti costringendole al pendolarismo e quindi, in ultima analisi, a sempre maggior tempo dedicato al lavoro, la promozione di modelli e stili di vita che esaltano l’individualismo e il consumo, ecc.
La sinistra borghese incoraggia ed esalta quei comportamenti che si scostano dall’idea della famiglia mononucleare. Questa operazione viene fatta non per ideale progressista, come vuole invece far credere, ma per fondare un modello egemonico basato sull’individualismo, sul singolo consumatore felice e soddisfatto, “emancipato” nella propria dimensione di relazione private, sia a livello umano che mercantile. Emergono a proposito nuovi prodotti sia materiali che intellettuali: a titolo di esempio si vedano le serie tv prodotte dalle grandi multinazionali dell’intrattenimento basate su vicende di personaggi che sfoggiano la loro appartenenza Lgbtqia+. L’individuo atomizzato viene integrato nei meccanismi del capitalismo, senza troppa difficoltà, perché fa della proprio identità, ad esempio sessuale, l’epicentro di tutti i suoi problemi, senza porsi i problemi collettivi, a partire da quelli riguardanti i rapporti economici e produttivi della società.
Gli individui, appagati dal consumo di prodotti apparentemente progressisti e da una dimensione di vita esclusivamente privata, si sentono confermati nella loro individualità, che la classe dominante vuole far intendere sia rivoluzionaria. Un perfetto cerchio che si chiude: la borghesia riesce in questo modo a capitalizzare le spinte progressiste della società, derivate dalla fine dei rapporti tradizionali, con un’operazione di atomizzazione e di individualizzazione senza precedenti, che ostacola e previene il possibile riconoscersi come classe. Così la borghesia imperialista si propone di continuare a tenere ben saldo il potere nelle proprie mani.
Di fatto, non ponendosi su un terreno di classe, ma limitandosi a rivendicare diritti legati alla persona, non si mira all’abbattimento del sistema capitalista, causa di ogni tipo di discriminazione.
In che modo noi comunisti ci possiamo porre di fronte a questi movimenti? Innanzitutto imparando a relazionarsi ai movimenti di massa reali, che scaturiscono da contraddizioni oggettive, e agendo al loro interno dove ci siano le condizioni. Questa azione può affermarsi solo come espressione di una componente politica che porta all’interno di questi movimenti una visione e delle rivendicazioni di classe, ma non solo a livello ideologico, bensì con esempi legati alla propria pratica sociale e politica. Solo così si potrà porre un freno all’uso reazionario che può essere fatto dei movimenti.
Per la nostra classe dovrebbe essere quindi importante fare tesoro dell’avanzamento culturale della società nel senso della liberazione sessuale e di genere, ma ciò va usato per confermare e ampliare la lotta sulle condizioni della donna proletaria e lavoratrice, mettendo al centro la sua condizione e le sue rivendicazioni. Nel fare questo dobbiamo essere attenti a non prestare il fianco a quell’esaltazione dei propri tratti personali come fossero tratti rivoluzionari: questa è un’operazione reazionaria della classe borghese, non bisogna cadere in questo tranello.
Per noi la rivoluzione sarà il rovesciamento della classe borghese da parte della classe proletaria, con la presa del potere politico. Il fatto che gli individui si definiscano come meglio credono sarà un passo avanti nel superamento delle dinamiche patriarcali che caratterizzavano il mondo dominato prima dall’aristocrazia e poi dalla borghesia; ma la società comunista sarà un mondo di parità non solo nominale e idealista, ma in senso materiale e reale. Verranno socializzati i bisogni e il lavoro di cura, e ciascuno potrà realizzarsi come meglio crede, con una concordanza tra bisogni individuali e collettivi che la classe proletaria saprà realizzare. Ma di certo non possiamo accettare che la classe dominante guadagni egemonia sull’identità degli individui, e che spacci questa operazione come rivoluzionaria.
Insegnamenti per l’oggi
Storicamente sono sempre state le donne proletarie ad imporre gli avanzamenti nel campo dei diritti a tutta la società determinando cambiamenti progressisti. Ad esempio in Italia la legge sul divorzio e sull’aborto sono state conquiste ottenute negli anni Settanta, quando le donne sono state protagoniste di ampi movimenti. Ma lo hanno potuto fare in un contesto dove il rapporto di forza dell’intera classe proletaria era favorevole; sono gli anni che vanno dal ‘68 operaio ai movimenti contro la guerra, fino a quelli studenteschi e del proletariato metropolitano. E lo hanno potuto fare anche perché la loro entrata nel mondo del lavoro dalla fine degli anni Sessanta inizia a progredire. Ricordiamo, infatti, che la dipendenza economica è la prima causa che impedisce lo sviluppo dell’emancipazione della donna.
Solo affrontando il problema dell’emancipazione della donna partendo dalle condizioni materiali del suo sfruttamento si potranno fare passi concreti in avanti.
Per fare oggi meglio questo lavoro come comunisti dobbiamo attrezzarci ideologicamente e organizzativamente.
Vogliamo affermare con risolutezza che la questione femminile non è una questione che riguarda solo le donne, ma è una questione politica che investe tutta la classe e quindi tutti i comunisti. La concezione che le questioni della famiglia, dei ruoli, della sessualità, del lavoro domestico, siano temi che riguardano solo le donne e quindi solo le compagne è profondamente errata. Esistono e sono sempre esistite contraddizioni all’interno dei collettivi di compagni, nella storia del movimento comunista e dei suoi partiti. Per noi trattare queste contraddizioni significa diventare protagoniste politicamente rompendo i ruoli che “naturalmente” ci sono anche dentro ai collettivi, essendo tutti noi influenzati dalla società nella quale viviamo. Una società divisa in classi nella quale la famiglia, pur in decadenza, rimane ancora un contratto economico per la perpetuazione del capitalismo e dell’oppressione della donna, è una cellula della società e come tale la influenza tutta. Una società che ci educa continuamente e intimamente all’individualismo come dimensione ideologica fondamentale della borghesia.
Anche qui ci torna in aiuto la conversazione di Zetkin con Lenin: “Il lavoro di propaganda e agitazione tra le donne, la diffusione dello spirito rivoluzionario tra di loro, vengono considerati come questioni occasionali, come faccende che riguardano unicamente le compagne…Ciò è male, assai male. È separatismo bello e buono, è femminismo a rebours, come dicono i francesi, femminismo alla rovescia! Cosa c’è alla base di questo atteggiamento sbagliato nelle nostre sezioni nazionali? In ultima analisi non si tratta altro che di una sottovalutazione della donna e del suo lavoro. Proprio così!…Il nostro lavoro di comunisti tra le donne, il nostro lavoro politico, comporta una buona dose di lavoro educativo tra gli uomini. Dobbiamo sradicare del tutto la vecchia idea del “padrone”. Nel partito e tra le masse. È un nostro compito politico non meno importante del compito urgente e necessario di creare un nucleo direttivo di uomini e donne ben preparati teoricamente e praticamente per svolgere tra le donne un’attività di partito”22.
Lavorare in questo senso significa per noi porre al dibattito la questione negli ambiti comunisti, rafforzare con la formazione la nostra concezione del mondo ed elaborare delle linee politiche di intervento nelle situazioni specifiche che oggi viviamo guidati dell’obbiettivo principale: “Conquistare le donne alla causa del proletariato e della rivoluzione”.
Riprendiamo Clara Zetkin per organizzare il lavoro comunista tra le donne proletarie!
1 Vedi manchette su Clara Zetkin
2 G. Mazzotta editore, 1972
3 Zetkin, op. cit., p. 155.
4 Ivi, p. 93
5 Per diritto di voto limitato si intende il diritto di voto solo ad alcune categorie di donne ad esempio, in Inghilterra, alle mogli dei capi famiglia con certi requisiti di età, sopra i trent’anni. Oppure solo alle possidenti in quanto pagavano le tasse, in ultima analisi non un diritto della persona, ma della proprietà.
6 August Bebel (1840-1913) fu, assieme a Wilhelm Liebknecht (1826-1900) fondatore della socialdemocrazia tedesca. Oppositori dell’espansionismo prussiano, votarono contro i crediti di guerra e promossero la mobilitazione rivoluzionaria contro il conflitto. Bebel portò un grande contributo all’analisi marxista sulla condizione della donna con il testo “La donna e il Socialismo – la donna nel passato, nel presente e nell’avvenire”.
7 Eduard Bernstein (1850-1932) fu il rappresentante principale della corrente riformista tedesca. Sosteneva che, non essendosi verificati nello sviluppo capitalistico il peggioramento ed il crollo teorizzati dal marxismo, i metodi rivoluzionari erano da considerare superati ed andavano sostituiti da lente e successive riforme sociali.
8 Ferdinand Lassalle (1825-1864), fondatore dell’Associazione Generale degli Operai Tedeschi, entrò in contrasto con Marx per il suo riformismo e per il suo appoggio al nazionalismo di Bismarck.
9 Louise Otto Petters nacqe in Germania nel 1819. Dopo la rivoluzione democratica del 1848 fondò il primo giornale politico femminile in Germania e si batté contro la legge che proibiva alle donne di essere redattrici. Fondò l’Allgemeiner Deutscher Frauenverein (Associazione delle donne tedesche).
10 V. Lenin, L’emancipazione della donna, Editori riuniti, 1977
11 Ivi, p. 80.
12 Ivi, p. 84
13 Ivi, p. 85
14 Ivi, p. 88
15 Ivi, p. 90
16 Aleksandra Kollontaj (1872-1952) fu una rivoluzionaria russa e statista sovietica, la prima donna ad essere stata nominata ministra ed ambasciatrice. Si occupò tutta la vita della questione della donna.
17 Ivi, p. 92
18 Ivi, da p. 113
19 Vedi manchette
20 Antitesi n. 6, Donne e lotta di classe, pp. 21 ss.
21 edizioni Alegre, 2018
22 Ivi p.102
Clara Zetkin
Clara Zetkin nacque in Germania nel 1857. Sin da giovanissima entrò nelle fila del movimento operaio, militandovi attivamente e ponendo sempre come fondamentale, ai fini della lotta per il socialismo, il problema dell’emancipazione della donna. Già durante i primi anni della sua iscrizione al Partito Socialdemocratico Tedesco dedicò gran parte della sua attività politica ad organizzare le lotte delle lavoratrici del suo paese. In quegli anni andava sviluppandosi una massiccia ed insidiosa corrente riformista che faceva deviare il movimento operaio dal suo obiettivo storico, la conquista del potere. Anche in questo caso il suo contributo fu immenso: nel 1915, dopo il tradimento della socialdemocrazia di molti paesi durante la Prima guerra mondiale, organizzò una Conferenza internazionale socialista femminile che si tenne a Berna, in Svizzera, dove levò la sua voce contro la guerra imperialista, per la fraternità dei popoli e sottolineando l’importanza della solidarietà internazionale femminile.
L’attività contro la guerra imperialista le costò un periodo di reclusione in carcere dopo il quale entrò subito a far parte della clandestina “Lega di Spartaco”, costituitasi in Germania dopo il tradimento della direzione del Partito Socialdemocratico e che poi divenne il Partito Comunista Tedesco. Eletta membro del comitato centrale del nuovo partito, conosciuta ed apprezzata da Lenin per la sua combattività, ebbe dalla III° Internazionale l’incarico di dirigere il segretariato femminile dell’Internazionale stessa.
In questo nuovo compito dimostrò grande capacità e sensibilità: durante quegli anni di lotta dura e difficile si adoperò senza sosta per dirigere il lavoro delle donne comuniste di tutti i paesi, per chiarire e approfondire il problema dell’emancipazione femminile nella nuova situazione creatasi dopo la Rivoluzione d’Ottobre e della costituzione di partiti marxisti-leninisti della classe operaia.
Partecipò attivamente anche alla lotta antifascista in Italia, dove contribuì alla formazione del Partito comunista italiano nel 1921 (come membro della commissione per le questioni italiane al IV° congresso dell’Internazionale Comunista).
In Germania, nel 1932, quando Hitler stava per diventare capo dello Stato tedesco, Clara Zetkin, inferma e quasi cieca, si alzò dal suo banco di deputato e con voce ferma e decisa chiamò le donne e i lavoratori di tutti i paesi a raccogliersi in un fronte unico antifascista per la difesa della libertà.
L’intersezionalità
L’intersezionalità è una categoria sociologica coniata nel 1989 da Kimberlè Crenshaw, giurista statunitense e attivista nei movimenti antirazzisti e femministi. Serve a descrivere le oppressioni di diverse categorie/identità sociali e culturali come il genere, l’orientamento sessuale, l’etnia, la religione, il colore della pelle, la classe sociale, la disabilità… come risultanti dall’intreccio di diverse discriminazioni legate a ciascuno di questi aspetti.
Questa teoria, fatta propria dal moderno movimento femminista, se può essere considerata frutto di una spinta positiva a capire l’interconnessione dei diversi aspetti che caratterizzano la società e della loro influenza sugli individui e sulle varie forme di oppressione, resta tuttavia una lettura sociologica borghese, che mette sullo stesso piano tutte le contraddizioni, negando la centralità della contraddizione di classe.




