Lottare contro l’imperialismo italiano
“Imperialismo e guerra” da Antitesi n.04 – pag.40
Con questo articolo cercheremo di fornire elementi per l’analisi e la riflessione utili ad impostare l’organizzazione del lavoro politico e di propaganda, per un intervento comunista nel movimento contro la guerra imperialista nel nostro paese.
Nella rivista abbiamo affermato più volte che l’Italia è un paese imperialista: da questo dato bisogna partire per contribuire al movimento contro la guerra imperialista, ponendo al centro la questione della lotta all’imperialismo nostrano.
Da questo punto di vista si tratta di andare oltre alle argomentazioni che portano a mobilitarsi solo in solidarietà alle resistenze dei popoli oppressi e/o hanno come impianto ideologico l’antiamericanismo tout court e/o la collocazione a favore dell’imperialismo russo. Si tratta, invece, di riaffermare il concetto che il principale contributo di solidarietà internazionalista è quello di lottare contro l’imperialismo del proprio paese, in una prospettiva rivoluzionaria. Per questo è d’obbligo analizzare il proprio Stato e la sua forma attuale, ponendosi nell’ottica del rovesciamento del potere: questa è una questione ineludibile. Come diceva Lenin, la questione dello Stato è il problema all’ordine del giorno per il proletariato che lotta.
D’altra parte ci pensano i fatti internazionali più recenti a confutare le tesi fallaci secondo cui le guerre e gli Stati sono ormai obsoleti. Tesi che discendono dalla visione della globalizzazione come governance globale e che riecheggiano la vecchia idea del superimperialismo1 che sottostima la portata strategica delle contraddizioni interimperialiste. Tesi che, data l’influenza dell’ideologia borghese dominante in questa società e in questa fase, hanno caratterizzato anche i movimenti no global, ma che si verificano false di fronte alla situazione attuale – conclamata – di tendenza alla guerra imperialista.
Di conseguenza anche l’idea che la forma Stato-nazione, corollario delle teorie della governance globale, sia sulla via del completo superamento, va sottoposta a critica. Per questo cerchiamo di approfondire l’argomento, evidenziando le caratteristiche attuali delle relazioni tra paesi imperialisti e tra quest’ultimi e i popoli oppressi.
In generale, nella fase imperialista si compie un salto qualitativo nel rapporto tra capitalismo e forma Stato. Con l’avvento del capitale monopolistico si sviluppa l’integrazione tra capitale e Stato. Tale integrazione affonda le sue radici nell’economia di guerra che caratterizza la concorrenza tra i monopoli. La politica degli Stati è posta a tutela degli interessi dei diversi gruppi monopolistici e la guerra è la prosecuzione con altri mezzi di questa politica necessariamente imperialista.
Le concezioni di cui sopra (governance globale) colgono unilateralmente la contraddizione tra lo sviluppo globale della struttura economica e le sovrastrutture (forme Stato di cui lo Stato-nazione è una configurazione). Quello che è in corso è invece un processo di ridefinizione della forma Stato. Il legame tra il capitale monopolistico multinazionale e gli apparati statali non ha fatto che rafforzarsi: le multinazionali vivono in simbiosi con gli Stati imperialisti, saccheggiando le finanze pubbliche e monopolizzando le commesse degli apparati pubblici, militari e civili. In quanto soggetti dell’esportazione di merci e soprattutto di capitali, si servono delle strutture statali per agevolarla. Sui contrasti economici che lo sviluppo del capitale monopolistico necessariamente determina nel campo delle relazioni internazionali, si definiscono quelli politici e conseguentemente anche la loro continuazione con “altri mezzi”. È una dinamica che porta ad una proiezione internazionale strategica degli Stati, tramite lo sviluppo di organismi e accordi sovranazionali. È un processo che non determina la dissolvenza dello Stato-nazione: la sua proiezione internazionale da un lato parte dalla base stato-nazionale, dall’altro la mette in discussione con il definirsi di entità sovranazionali che la integrano e ne ridefiniscono la sovranità. Esiste un rapporto di continuità/rottura che è determinato dalla contraddizione “caratterizzata dalla separazione tra lo spazio mondializzato della gestione economica del capitalismo e gli spazi nazionali della gestione politica e sociale”. [1] È una dialettica del rapporto continuità/rottura, in generale, ad evidenziare il processo di rafforzamento della forma Stato che caratterizza la fase imperialista, in particolare nella fase odierna di tendenza alla guerra generata dalla crisi irreversibile del sistema capitalista.

Questo processo, oltre al versante “esterno” della proiezione internazionale che alimenta la contraddizione con i popoli oppressi e quella tra imperialismi, ne ha uno “interno” che riguarda la strumentazione e i cambiamenti sovrastrutturali necessari a gestire le politiche di guerra all’interno delle contraddizioni che vivono le masse popolari (su questo argomento rimandiamo allo sviluppo dell’approfondimento nella sezione “Controrivoluzione, repressione e solidarietà di classe” in questo numero).
Sulla base della tendenza generale al rafforzamento del ruolo dello Stato nel processo complessivo di riproduzione del capitale si determina la sua proiezione internazionale. Basti pensare al ruolo strategico che gioca la politica degli Stati e la loro spesa pubblica nel settore strategico-militare per lo sviluppo di aree di influenza esterna, per la loro tutela da invadenze dei concorrenti e per il contenimento e la destabilizzazione delle aree di influenza altrui.
Questi processi riguardano tutti i singoli Stati imperialisti, a tutela degli interessi strategici e dei rispettivi capitali e a garanzia dell’approvvigionamento di materie prime, dell’agibilità delle vie di comunicazione e dei mercati di sbocco e della sicurezza degli investimenti. Solo tenendo conto di questo processo risultano chiare le contraddizioni che caratterizzano i rapporti tra gli stessi paesi imperialisti, anche nel cuore della Ue, come ad esempio lo scontro in atto da tempo tra Italia e Francia sull’area di influenza libica.
Lo sviluppo della proiezione internazionale degli Stati si rende evidente, ad esempio, con la formulazione delle dottrine improntate alla logica della “difesa avanzata”. Qui, la proiezione internazionale degli Stati, lungi dall’inibire la tendenza alla guerra, ne caratterizza invece lo sviluppo. Al contrario di quello che prospetta la concezione della governance globale.
Dunque, lo Stato-nazione non si dissolve dentro le forme sovrastatali (ad esempio l’Unione Europea), ma la forma Stato si internazionalizza, perché ogni borghesia nazionale che è divenuta imperialista deve internazionalizzarsi e, per farlo, necessita di uno Stato con una strategia adeguata, anche nel campo della difesa.
Va posto l’accento sul fatto che alla base del processo di internazionalizzazione vi sono la natura economica capitalista degli stati imperialisti, la crisi in atto e il tentativo da parte borghese di fuoriuscirvi. Le cause dello sviluppo di questo processo, dell’acutizzarsi della concorrenza e, quindi, della tendenza alla guerra, non sono la cattiveria e l’antidemocraticità o il desiderio di oppressione dei singoli Stati (che invece ne sono conseguenze), bensì lo sviluppo monopolistico nella formazione economica attuale.
Il carattere imperialista dello Stato italiano si è definito con la formazione dei monopoli. Quest’ultima non è stata un semplice passaggio da un tipo di economia ad un’altra, bensì uno sviluppo del capitale nella fase imperialista. Questo carattere genetico del capitalismo ha potuto affermarsi nelle formazioni deboli, come lo era l’Italia, solo sotto l’ala dello Stato.
Lampante è, ad esempio, il caso del settore siderurgico dove i colossi dell’acciaio, come Genova, Terni o Taranto hanno potuto evolversi solo con denaro pubblico. Oppure pensiamo anche alla nascita dell’Iri (Istituto per la ricostruzione industriale), nato nel 1933 come ente temporaneo per fronteggiare la gravissima crisi bancaria ed industriale, ma divenuto poi Ente permanente nel 1937 per controllare allora la quasi totalità dell’industria degli armamenti, dei servizi di telecomunicazione di gran parte del paese, un’altissima quota della produzione di energia elettrica, una notevole quota dell’industria siderurgica civile, tra l’80% ed il 90% del settore di costruzioni navali e dell’industria della navigazione. Con l’Iri infatti lo Stato ha foraggiato il rafforzamento del capitale monopolistico.
Per altri esempi più recenti, pensiamo anche al caso dell’Eni, azienda multinazionale creata dallo Stato italiano come ente pubblico nel 1953 con la presidenza di Enrico Mattei per reggere la concorrenza nel settore strategico petrolifero delle Sette Sorelle.
Il processo di proiezione militare internazionale dell’Italia, pur con un incedere contradditorio, vista l’influenza della subalternità storica agli Usa (si veda la manchette sull’Hub di Napoli) e dell’inferiorità economica dentro la Ue, si sta delineando con chiarezza. A testimonianza di questo, basti pensare alla reiterata dichiarazione del Ministro dell’Interno Marco Minniti: “Il vero confine dell’Europa è in Africa, a sud della Libia” e alle numerose missioni nelle quali l’Italia è impegnata, con al centro proprio quella libica (si vedano le manchette sul giardino di casa dell’imperialismo italiano e sull’Eni). Non va dimenticata la presenza militare italiana in Afghanistan e quella in Iraq, con un contingente di 500 uomini a difesa del cantiere della diga di Mosul, un appalto affidato alla Trevi di Cesena, per un valore di 273 milioni di euro (quindi direttamente a sostegno di capitale privato) e nell’operazione strategica “Prima Parthica” che fornisce personale ai comandi multinazionali in Kuwait e Iraq (Baghdad ed Erbil) per l’addestramento dell’esercito iracheno. Sempre in Iraq ricordiamo l’operazione “Centuria” con circa 100 uomini, con compiti di coordinamento e di sostegno alle forze armate irachene. L’Italia infatti è la seconda forza militare nel paese dopo quella Usa. Va aggiunta la presenza in Siria all’interno della “Coalizione Internazionale” con compiti di supporto logistico e appoggio militare. E, non ultimo, per definire chiaramente la collocazione dell’Italia, va menzionato il suo stretto rapporto con il sionismo e quindi con l’entità sionista di Israele caratterizzato non solo dagli accordi sulla ricerca, ma anche militari veri e propri (si guardi alla manchette sul Technion e a quella sul satellite Opsat-3000).
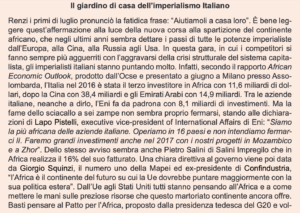

Naturalmente l’imperialismo italiano, per far fronte a questo contesto, è stato spinto a delineare e a normare più precisamente le linee della sua “difesa avanzata”. Infatti il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 10 febbraio 2017, il disegno di legge che consentirà poi l’implementazione del “Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa” a firma della Ministra Pinotti. In esso la difesa della patria stabilita dall’art. 52 della Costituzione viene riformulata come “difesa degli interessi vitali del paese” e come “contributo alla difesa collettiva dell’Alleanza Atlantica e al mantenimento della stabilità nelle aree incidenti sul Mar Mediterraneo, al fine della tutela degli interessi vitali o strategici del paese”. Il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, stabilito dall’art. 11, viene sostituito di fatto con “gestione delle crisi al di fuori delle aree di prioritario intervento, al fine di garantire la pace e la legalità internazionale”.
Il Libro Bianco configura così l’Italia come potenza che può intervenire militarmente nelle aree affacciate sul Mediterraneo, Nord Africa, Medioriente e Balcani, a sostegno dei propri interessi economici e strategici e ovunque nel mondo siano presenti gli interessi dell’Occidente rappresentati dalla Nato, sotto comando Usa.
Organica a tutto ciò è la Legge quadro del 2016 che istituzionalizza le missioni militari all’estero e dà vita a un fondo specifico del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, sul piano interno, viene affidata alle forze armate la “salvaguardia delle libere istituzioni”, con “compiti specifici in casi di straordinaria necessità ed urgenza”: espressione che agevola il proliferare di misure autoritarie.
Il nuovo modello, in aggiunta, ha spalancato le porte delle forze armate ai privati che potranno accedere a incarichi chiave: ciò permetterà ai gruppi dell’industria militare di entrarvi con funzioni dirigenti e gestirle secondo i loro interessi legati alla guerra.
Non a caso l’industria militare viene definita nel Libro Bianco “pilastro del Sistema Paese” poiché “contribuisce, attraverso le esportazioni, al riequilibrio della bilancia commerciale e alla promozione di prodotti dell’industria nazionale in settori ad alta remunerazione creando posti di lavoro qualificati”. Questa definizione corrisponde e istituzionalizza la realtà già in atto: basti scorrere i dati del boom dell’Italia nell’esportazione di armi nel 2016: +85,7%! Il dato è quasi raddoppiato rispetto al 2015.
I dati si possono trovare nell’ultima relazione annuale della Presidenza del Consiglio redatta al Parlamento sull’applicazione della Legge 185 del 1990 che stabiliva “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” stilata con il contributo del Ministero degli Esteri, della Difesa e dello Sviluppo Economico.
Metà delle esportazioni del 2016 (7,3 miliardi di euro) riguardano la fornitura al Kuwait di 28 aerei Eurofighter della Leonardo, progettati e costruiti insieme da Germania, Regno Unito, Italia e Spagna, con linee di produzione nei primi tre paesi.
La seconda categoria di armamenti più venduta è quella di “bombe, siluri, razzi, missili e accessori”, che ha fruttato 1,2 miliardi. Nella relazione annuale è sottolineato, inoltre, che nel corso del 2016 l’Italia ha esportato in 82 paesi in totale, confermandosi uno dei principali attori mondiali per penetrazione del mercato. D’altro canto è cresciuto anche l’import: nel 2016 sono state importate armi per un valore di 612 milioni di euro, con un aumento del 169% rispetto al 2015; l’82% del materiale è Usa.
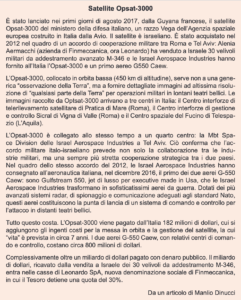
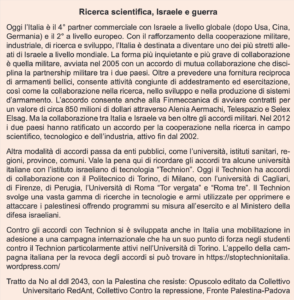
Alcune riflessioni e conclusioni
Il filo conduttore del ragionamento svolto è la messa in evidenza del ruolo dello Stato italiano a tutela degli interessi della borghesia imperialista e necessariamente, in questa fase, a pilastro della tendenza alla guerra.
Le conclusioni tornano all’inizio dell’articolo, ovvero vogliamo riaffermare il fatto che per svolgere un lavoro comunista dentro al movimento contro la guerra imperialista è giusto e necessario il sostegno ai popoli oppressi che resistono e l’opposizione alla guerra, ma non è sufficiente: diventa indispensabile combattere l’imperialismo italiano.
Perché?
Come abbiamo analizzato, il problema della guerra non è una questione principalmente dovuta a politiche aggressive o repressive: esso è un problema dello sviluppo del capitale monopolistico e, quindi, un intervento nel movimento contro la guerra non può essere limitato alla parola d’ordine “basta guerre”, ad un generico pacifismo o al solidarismo. Esso deve estendersi e articolarsi per dire basta al capitale monopolistico e al suo Stato.
La condizione di guerra, a questo stadio dello sviluppo del capitale, è una condizione di fatto. Dire “basta guerre” è utopistico, va invece sviluppata la critica pratica all’imperialismo: la mobilitazione contro la guerra deve alimentare il processo di critica al capitalismo e al suo Stato nella fase odierna.
E non va dimenticato che storicamente se non ci fosse stata la guerra non ci sarebbero state le rivoluzioni.
Come farlo?
La risposta discende dalla domanda: “Come si possono accumulare forze nell’intervento nel movimento contro la guerra imperialista per abbattere il sistema economico che la produce?”.
Dovendo sviluppare una critica pratica all’imperialismo e non alla guerra perché, come diceva Mao Tse Tung, esistono guerre giuste e guerre ingiuste [2] e, considerando che ad ogni azione dello Stato sul fronte esterno ne corrisponde una sul fronte interno, la mobilitazione contro gli interventi militari va collegata alla lotta contro le misure che necessariamente il governo deve prendere: tagli alla spesa pubblica, ai servizi, alla sanità, aumento del costo della vita e taglio ai salari: spese per la repressione e il controllo definite dalla controparte spese per la “sicurezza”.
In altre parole bisogna camminare su due gambe, come diceva Ho Chi Minh, nel senso che bisogna sia opporsi agli interventi militari, sia alla politica interna per sostenerli. Solo in questo modo diviene possibile portare avanti un intervento di classe e adoperarsi all’interno dei settori oggi in lotta, per raccogliere e accumulare le forze per una critica radicale al sistema esistente.
Nell’analisi, per definire una linea è essenziale partire dal generale, dalle ragioni della situazione di crisi e di guerra attuale che genera sempre più miseria e lutti per le classi oppresse e da essa far discendere e articolare le linee di intervento particolari. Nella pratica, all’interno delle singole lotte, occorre invece partire dalla condizione particolare che vivono i vari settori delle classi oppresse ed essere capaci di far emergere il generale, far comprendere cioè le motivazioni che la generano e la necessità di combatterle.
Quindi è indispensabile che si formi una leva di compagni che si riappropri delle categorie dell’analisi di classe, patrimonio del movimento comunista e frutto dell’esperienza di chi ha saputo storicamente fermare la guerra trasformandola in rivoluzione e, attraverso esse, imparino ad organizzare e a partecipare, con percorsi ragionati, alle mobilitazioni contro la guerra, sviluppando l’intervento tra lavoratori, disoccupati, precari, studenti, immigrati, nei movimenti ambientalisti e tra tutto il proletariato.
Alcuni movimenti, che nascono dalle contraddizioni oggettive che le popolazioni vivono, si collocano naturalmente con la loro lotta in opposizione alla guerra imperialista. Pensiamo ai No Muos o alle mobilitazioni contro le basi militari in Sardegna; ma anche al movimento No Tap, che opponendosi al nuovo gasdotto, ultimo segmento del Southern Gas Corridor, si insinua nella contrapposizione tra interessi imperialistici, essendo esso una via del gas promossa dall’Ue in un’ottica concorrenziale rispetto ai progetti russi, dentro ad uno scenario di antagonismo tra il polo imperialista atlantico e quello che lega Mosca a Pechino. Un antagonismo divenuto bollente e che alimenta sempre più la tendenza alla guerra – come testimonia la situazione della Corea del Nord – e alla guerra vera e propria, come quella in Siria e sul fronte ucraino.
Spesso questi movimenti si collocano oggettivamente contro la guerra imperialista, ma non soggettivamente, rischiando di fermarsi al particolare delle contraddizioni territoriali. Così possono essere esposti al riassorbimento da parte istituzionale che ne mina la forza spuntando le armi della lotta e, al tempo stesso, la loro capacità propulsiva di dar vita ad un movimento generale contro l’imperialismo e il suo sistema.
Lo stesso vale per il movimento in solidarietà agli immigrati dove primeggiano le parole d’ordine “No borders”, “diritti”, “no al razzismo” ecc. Qui, solo in pochi casi, viene smascherata la causa reale dell’immigrazione che è l’attuale rapporto di oppressione imperialista: dalla distruzione delle economie di sussistenza di interi popoli (effetto della globalizzazione) alle guerre che li trasformano in carne da macello. Un esempio positivo è quello dei lavoratori in lotta del Si Cobas, in buona parte immigrati, che partendo dal particolare della loro condizione di sfruttamento agitano parole d’ordine e organizzano iniziative contro la guerra imperialista.
All’interno dei lavoratori e delle masse popolari che si mobilitano va superata l’insufficienza dei comunisti di avere una linea di intervento e un’organizzazione conseguente.
In sintesi, pensiamo che oggi la lotta contro l’imperialismo italiano e le sue politiche reazionarie e guerrafondaie sia da porre in relazione allo sviluppo di ogni lotta specifica, promuovendo e partecipando a percorsi e mobilitazioni contro le strutture italiane dello sviluppo della guerra: basi e complessi militari, ricerca scientifica legata al militare.
Opporsi alla guerra imperialista attraverso la lotta di classe contro l’imperialismo italiano, le sue strutture militari e le sue politiche reazionarie! È necessario lottare contro l’assoggettamento e aumento dello sfruttamento della classe operaia, di tutto il proletariato e dei popoli che vuole opprimere!
Note
[1] S. Amin, La gestione capitalistica della crisi, Punto Rosso, 1995, pag 42
[2] “La storia dimostra che le guerre si dividono in due tipi, giuste ed ingiuste. Tutte le guerre progressiste sono giuste, e tutte le guerre che ostacolano il progresso sono ingiuste. Noi Comunisti ci opponiamo a tutte le guerre ingiuste che ostacolano il progresso, ma non a quelle progressiste, che sono giuste. Non solo noi Comunisti non ci opponiamo alle guerre giuste, ma vi partecipiamo attivamente. La Prima Guerra Mondiale è un esempio di guerra ingiusta in cui entrambi gli schieramenti hanno combattuto per interessi imperialisti; di conseguenza i Comunisti di tutto il mondo l’hanno contrastata risolutamente. Opporsi a una guerra di questo tipo significa fare tutto il possibile per prevenirne lo scoppio e, una volta scoppiata, contrastare la guerra con la guerra, contrastare la guerra ingiusta con la guerra giusta, ogni volta che sia possibile. Le rivoluzioni e le guerre rivoluzionarie sono inevitabili in una società classista, senza di esse è impossibile compiere alcun balzo in avanti verso il progresso sociale e rovesciare le classi dirigenti reazionarie, e dunque è impossibile per il popolo conquistare il potere politico”. Mao Tze Tung, Sulla guerra di lunga durata (maggio 1938), Opere Scelte, volume 2.
Hub di Napoli
È in progetto la realizzazione a Napoli di una grande opera: l’Hub per il Sud.
Si tratta di trasformare il comando Nato di Napoli, agli ordini dell’ammiraglia statu-nitense Michelle Howard, capo del comando Nato e comandante delle forze navali Usa per l’Europa e delle forze navali Usa per l’Africa.
L’”area di responsabilità” abbraccia l’Europa, l’intera Russia, il Mediterraneo e l’A-frica.
La guerra alla Libia nel 2011, con il determinante contributo italiano, è stata diretta dalla Nato attraverso il Comando di Napoli. Sempre da Napoli sono state condotte le operazioni militari all’interno della Siria.
Il nuovo Hub per il Sud sarà la base operativa per forze terrestri, aeree e navali. Le forze e le armi necessarie saranno fornite dall’intera rete di basi Usa/Nato in Italia: Aviano, Camp Darby, Gaeta, Sigonella, Augusta. La stazione Muos di Niscemi e altre si occuperanno delle comunicazioni.
Per le operazioni Nato definite “proiezione di stabilità oltre i nostri confini” è disponibile la Forza di risposta della Nato, aumentata a 40 mila uomini, in particolare la sua Forza di punta, che può essere proiettata in 48 ore ovunque e in qualsiasi momento.
In Italia sono di stanza già 30.000 tra militari, impiegati civili e familiari statunitensi.
Non è stata quantificata la spesa del progetto.
Solo la costruzione del nuovo quartier generale di Napoli, inaugurato nel 2012 a Lago Patria (85 mila metri quadri coperti espandibili, in cui lavorano 2500 militari), è venuta a costare circa 200 milioni di euro. Tutto denaro pubblico, che va ad aggiungersi alle spese Nato per la difesa, in continuo aumento. La spesa italiana odierna è stimata circa 70 milioni di euro al giorno.
Dati tratti da un articolo di Manlio Dinucci
Il giardino di casa dell’imperialismo Italiano
Renzi i primi di luglio pronunciò la fatidica frase: “Aiutiamoli a casa loro”. È bene leg-gere quest’affermazione alla luce della nuova corsa alla spartizione del continente africano, che negli ultimi anni sembra dettare i passi di tutte le potenze imperialiste dall’Europa, alla Cina, alla Russia agli Usa. In questa gara, in cui i competitori si fanno sempre più agguerriti con l’aggravarsi della crisi strutturale del sistema capitalista, gli imperialisti italiani stanno puntando molto. Infatti, secondo il rapporto African Economic Outlook, prodotto dall’Ocse e presentato a giugno a Milano presso Asso-lombarda, l’Italia nel 2016 è stata il terzo investitore in Africa con 11,6 miliardi di dollari, dopo la Cina con 38,4 miliardi e gli Emirati Arabi con 14,9 miliardi. Tra le aziende italiane, neanche a dirlo, l’Eni fa da padrona con 8,1 miliardi di investimenti. Ma la fame dello sciacallo a sei zampe non sembra proprio fermarsi, stando alle dichiarazioni di Lapo Pistelli, executive vice-president of International Affairs di Eni: “Siamo la più africana delle aziende italiane. Operiamo in 16 paesi e non intendiamo fermarci lì. Faremo grandi investimenti anche nel 2017 con i nostri progetti in Mozambico e a Zhor”. Dello stesso avviso sembra anche Pietro Salini di Salini Impregilo che in Africa realizza il 16% del suo fatturato. Una chiara direttiva al governo viene poi data da Giorgio Squinzi, il numero uno della Mapei ed ex-presidente di Confindustria, “l’Africa è il continente del futuro su cui la Ue dovrebbe puntare maggiormente con la sua politica estera”. Dall’Ue agli Stati Uniti tutti stanno pensando all’Africa e a come mettere le mani sulle preziose risorse che questo martoriato continente ancora offre. Basti pensare al Patto per l’Africa, proposto dalla presidenza tedesca del G20 e volto a intensificare gli investimenti privati a lungo termine, o ancora al fatto che l’Africa è stata uno dei tavoli di discussione tanto al G7 di Taormina quanto al G20 di Amburgo. Durante il primo di questi, Gentiloni si è apprestato a sottolineare: “L’agenda del G7 deve dialogare con quella per lo sviluppo per l’Africa, l’Agenda 2063 (si tratta di un progetto ancora in divenire per il futuro dell’Africa), che è un caposaldo strategico per lo sviluppo del Continente”. Da questa sintetica carrellata appare evidente che tutti i paesi imperialisti occidentali siano concordi nella necessità di continuare la rapina delle risorse e lo sfruttamento che da secoli perseguono contro i popoli africani. Ma la concordia tra essi appare alquanto effimera se pensiamo allo stretto groviglio di interessi che stanno alla base della corsa alla ripartizione africana.
Vediamo ora gli interessi dell’Eni (Ente nazionale idrocarburi) azienda multinazionale creata dallo Stato italiano, convertita in società per azioni nel 1992 con principali azionisti, ai nostri giorni, la cassa depositi e prestiti e il ministero dell’economia e delle finanze.
Da note di fase autunno 2017 del Collettivo Tazebao www.tazebao.org
Eni è presente in Libia dal 1959. L’attività è condotta nell’offshore mediterraneo di fronte a Tripoli e nel deserto libico per una superficie complessiva sviluppata e non sviluppata di 26.635 chilometri quadrati (13.294 chilometri quadrati in quota Eni).
Nel 2016 l’attività produttiva in Libia è stata in linea con quanto pianificato e l’equi-ty di Eni nel paese è statadi 352 mila barili al giorno, il livello più elevato dal 2010. Attualmente la Libia rappresenta circa il 20% della produzione d’idrocarburi com-plessiva di Eni; tale incidenza rimarrà significativa negli anni del piano quadriennale 2017-2020, nonostante un certo ridimensionamento rispetto al 2016-2019.
Gas & Power
L’attività di gas si esplica attraverso il gasdotto Green Stream per l’importazione del gas libico prodotto dai giacimenti di Wafa e Bahr Essalam operati da Eni. Il gasdotto, composto da una linea di 520 chilometri, realizza l’attraversamento sottomarino del Mar Mediterraneo collegando l’impianto di trattamento di Mellitah sulla costa libica con Gela in Sicilia, punto di ingresso nella rete nazionale di gasdotti. La capacità del gasdotto ammonta a circa 8 miliardi di metri cubi/anno. L’approvvigionamento di gas naturale in Libia nel 2016 è stato pari a 4,87 miliardi di metri cubi (-32,8% rispetto al 2015).“Eni si è costruita forti prospettive di crescita in Africa con scoperte importanti in Egit-to, Angola, Congo, Gabon, Ghana e in Mozambico. Sono 15 i paesi in cui operiamo, in otto di loro svolgiamo attività di esplorazione mentre altri sette ci vedono impegna-ti anche in operazioni legati alla produzione. Aprendo la gallery dei paesi e cliccando sulle foto puoi scoprire quali sono le attività e i progetti di sostenibilità di Eni.”
Dal sito dell’Eni www.eni.com
Satellite Opsat-3000
È stato lanciato nei primi giorni di agosto 2017, dalla Guyana francese, il satellite Opsat-3000 del ministero della difesa italiano, un razzo Vega dell’Agenzia spaziale europea costruito in Italia dalla Avio. Il satellite è israeliano. È stato acquistato nel 2012 nel quadro di un accordo di cooperazione militare tra Roma e Tel Aviv: Alenia Aermacchi (azienda di Finmeccanica, ora Leonardo) ha venduto a Israele 30 velivoli militari da addestramento avanzato M-346 e le Israel Aerospace Industries hanno fornito all’Italia l’Opsat-3000 e un primo aereo G550 Caew.
L’Opsat-3000, collocato in orbita bassa (450 km di altitudine), serve non a una gene-rica “osservazione della Terra”, ma a fornire dettagliate immagini ad altissima risolu-zione di “qualsiasi parte della Terra” per operazioni militari in lontani teatri bellici. Le immagini raccolte da Optsat-3000 arrivano a tre centri in Italia: il Centro interforze di telerilevamento satellitare di Pratica di Mare (Roma), il Centro interforze di gestione e controllo Sicral di Vigna di Valle (Roma) e il Centro spaziale del Fucino di Telespa-zio (L’Aquila).
L’Opsat-3000 è collegato allo stesso tempo a un quarto centro: la Mbt Spa-ce Division delle Israel Aerospace Industries a Tel Aviv. Ciò conferma che l’ac-cordo militare italo-israeliano prevede non solo la collaborazione tra le indu-strie militari, ma una sempre più stretta cooperazione strategica tra i due paesi. Nel quadro dello stesso accordo del 2012, le Israel Aerospace Industries hanno consegnato all’aeronautica italiana, nel dicembre 2016, il primo dei due aerei G-550 Caew: sono Gulfstream 550, jet di lusso per executive made in Usa, che le Israel Aerospace Industries trasformano in sofisticatissimi aerei da guerra. Dotati dei più avanzati sistemi radar, di spionaggio e comunicazione adeguati agli standard Nato, questi aerei costituiscono la punta di lancia di un sistema di comando e controllo per l’attacco in distanti teatri bellici.
Tutto questo costa. L’Opsat-3000 viene pagato dall’Italia 182 milioni di dollari, cui si aggiungono gli ingenti costi per la messa in orbita e la gestione del satellite, la cui “vita” è prevista in circa 7 anni. I due aerei G-550 Caew, con relativi centri di coman-do e controllo, costano circa 800 milioni di dollari.Complessivamente oltre un miliardo di dollari pagato con denaro pubblico. Il miliardo di dollari, ricavato dalla vendita a Israele dei 30 velivoli da addestramento M-346, entra nelle casse di Leonardo SpA, nuova denominazione sociale di Finmeccanica, in cui il Tesoro detiene una quota del 30%.
Da un articolo di Manlio Dinucci
Ricerca scientifica, Israele e guerra
Oggi l’Italia è il 4° partner commerciale con Israele a livello globale (dopo Usa, Cina, Germania) e il 2° a livello europeo. Con il rafforzamento della cooperazione militare, industriale, di ricerca e sviluppo, l’Italia è destinata a diventare uno dei più stretti alle-ati di Israele a livello mondiale. La forma più inquietante e più grave di collaborazione è quella militare, avviata nel 2005 con un accordo di mutua collaborazione che disciplina la partnership militare tra i due paesi. Oltre a prevedere una fornitura reciproca di armamenti bellici, consente attività congiunte di addestramento ed esercitazione, così come la collaborazione nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di sistemi d’armamento. L’accordo consente anche alla Finmeccanica di avviare contratti per un valore di circa 850 milioni di dollari attraverso Alenia Aermachi, Telespazio e Selex Elsag. Ma la collaborazione tra Italia e Israele va ben oltre gli accordi militari. Nel 2012 i due paesi hanno ratificato un accordo per la cooperazione nella ricerca in campo scientifico, tecnologico e dell’industria, attivo fin dal 2002.
Altra modalità di accordi passa da enti pubblici, come l’università, istituti sanitari, re-gioni, province, comuni. Vale la pena qui di ricordare gli accordi tra alcune università italiane con l’istituto israeliano di tecnologia “Technion”. Oggi il Technion ha accordi di collaborazione con il Politecnico di Torino, di Milano, con l’università di Cagliari, di Firenze, di Perugia, l’Università di Roma “Tor vergata” e “Roma tre”. Il Technion svolge una vasta gamma di ricerche in tecnologie e armi utilizzate per opprimere e attaccare i palestinesi offrendo programmi su misura all’esercito e al Ministero della difesa israeliani.
Contro gli accordi con Technion si è sviluppata anche in Italia una mobilitazione in adesione a una campagna internazionale che ha un suo punto di forza negli studenti contro il Technion particolarmente attivi nell’Università di Torino. L’appello della campagna italiana per la revoca degli accordi si può trovare in https://stoptechnionitalia.wordpress.com/
Tratto da No al ddl 2043, con la Palestina che resiste: Opuscolo editato da Collettivo Universitario RedAnt, Collettivo Contro la repressione, Fronte Palestina-Padova




