La fabbrica che non può chiudere
Storia e contraddizioni della più grande acciaieria d’Italia
“Classi sociali, proletariato e lotte” da Antitesi n.17 – pag. 37
L’ex Ilva di Taranto è in crisi oramai da decenni e con essa traballa l’intero sistema siderurgico italiano. Agli inizi dello scorso anno, Federacciai ha diffuso i dati della produzione dell’acciaio sul suolo nazionale nel 2022. “L’Italia ha prodotto 21,6 milioni di tonnellate d’acciaio, in calo dell’11.5% ri spetto all’anno precedente” [1], dichiarava il presidente Antonio Gozzi. La causa principale di questo calo è stata additata alla riduzione della produzione dell’ex Ilva. La storica acciaieria ha prodotto 3 milioni di tonnellate, il 5% in meno rispetto all’anno precedente. Un deciso calo visto che prima del commissariamento, lo stabilimento siderurgico aveva raggiunto, nel 2012, il picco di una produzione di 6,2 milioni di tonnellate d’acciaio.
Se consideriamo questi dati, sia in merito al calo della produzione interna allo stabilimento, sia al suo contributo in termini generali (per l’appunto, appena 3 milioni di tonnellate su 21,6 milioni prodotte a livello nazionale), la decadenza dello stabilimento tarantino è evidente.
La sua situazione attuale si iscrive peraltro nella crisi generale e globale del capitalismo, che tocca anche il settore dell’acciaio, il quale ha registrato nel 2022, a livello mondiale, una contrazione del 4,3% [2].
La crisi dell’impianto Ilva di Taranto ha avuto il suo culmine fra la fine del 2023 e l’inizio dell’anno corrente creando una situazione in cui la possibilità di una definitiva chiusura dell’impianto sembrava certa come non mai. Ma, come vedremo, il governo ha deciso di intervenire per garantirne la continuità.
Sono circa 8 mila i lavoratori impiegati attualmente nel polo siderurgico, di cui circa 5 mila operai, mentre 3.500 sono attualmente in cassa integrazione. Una situazione che è destinata a peggiorare nonostante i proclami dei sindacati confederali, che millantano il reimpiego di tutti entro il 2026. Precaria è la situazione lavorativa tanto quanto lo sono le stesse condizioni degli impianti. Nel loro decadimento, particolarmente perseguito dall’ultima gestione privata, quella di ArcelorMittal, non pochi sono stati gli incidenti, provocando ferimenti e morti sfiorate, tanto da spingere i padroni, lo scorso dicembre, a vagliare la possibilità di aggiungere in busta paga fra le 100 e le 150 euro nei due mesi successivi agli operai che non si fossero infortunati [3].
Breve storia dell’Ilva
Per comprendere la crisi attuale, dobbiamo guardare ai processi storici dello stabilimento. Nel contesto di una fase caratterizzata dal grande investimento di capitale pubblico al sud, il polo siderurgico di Taranto fu inaugurato nel 1965, divenendo il quarto stabilimento dell’Italsider e arrivando, nel 1980, a produrre il 79% del totale d’acciaio del monopolio pubblico. Dopo una decennale crisi di produzione, la fabbrica fu privatizzata e acquistata nel 1995 dal gruppo Riva, assieme a tutti gli altri stabilimenti Ilva – ex Italsider a livello nazionale.
Il fatto che l’impianto siderurgico fosse stato costruito a ridosso del quartiere Tamburi, moltiplicò le conseguenze dell’impatto inquinante, fino a configurare un vero e proprio disastro ambientale negli anni della gestione del gruppo Riva. Quest’ultimo aveva infatti deciso di spostare l’intera produzione di acciaio primario a Taranto, chiudendo la cokeria e l’altoforno dello stabilimento Ilva di Genova, provocando un aumento delle emissioni di diossina nei cieli della città pugliese del 60%, secondo i dati dell’Inventario Nazionale delle Emissioni e delle loro Sorgenti. Un rapporto dello Studio Epidemiologico Nazionale ha riportato, fra il 2000 e il 2015, 600 casi di nascite con malformazioni congenite, un eccesso del 70% nei casi di tumore alla tiroide fra i giovani e un eccesso del 90% nel rischio di linfomi. I dati del Registro Tumori tra il 2006 e il 2015 della provincia riportavano dati allarmanti sull’incremento dei tumori nella popolazione. “Si evidenziano tassi standardizzati più elevati in provincia di Taranto rispetto al pool (campione, ndr) nazionale e al pool sud per mesotelioma, carcinoma epatico, vescicale e polmonare nel sesso maschile a conferma della probabile responsabilità di esposizioni professionali. I dati della provincia presentano tassi più elevati rispetto al sud anche per tutte le sedi (di tumore, ndr): carcinoma di fegato, rene, linfoma non Hodgkin, prostata e stomaco nei maschi, mammella nelle donne, colon, melanoma, tiroide, encefalo in entrambi i sessi” [4]. Ulteriore conferma è stata evidenziata per il maggior interessa mento dei territori del capoluogo Taranto e del vicino comune di Statte “rispetto all’intera provincia per quel che riguarda tutte le sedi, carcinoma dello stomaco, colon, fegato, polmone, melanoma, mesotelioma, rene, vescica, tiroide nei maschi, linfoma non Hodgkin, mammella, cervice uterina e prostata” [5].
A farne spesa dunque furono principalmente i lavoratori dell’impianto e i residenti dei quartieri proletari di Tamburi, Paolo VI° e di tutta la periferia di Taranto nonché di Statte. Contro questa situazione di avvelenamento di massa, si sviluppava un movimento popolare ambientalista che poneva la questione della salute collettiva.
Intanto, a livello di mercato mondiale dell’acciaio, la crescita della concorrenza cinese ed indiana, aggravava la condizione di sovrapproduzione degli industriali europei, tra cui il gruppo Riva, che negli anni tra il 2008 e il 2010 poneva in cassa integrazione un terzo degli operai dell’acciaieria tarantina. Nel 2012 vi fu un picco della produzione complessiva globale di acciaio e l’Ilva, con la gestione Riva, vi contribuì, superando i sei milioni di tonnellate di fabbricato. Si assiste dunque, da parte del gruppo industriale lombardo, ad una gestione “temeraria” della produzione: ricorso continuo alla cassa integrazione per gestire la fase di crisi e massima esplosione di fabbrica nei momenti di crescita del mercato.
In questo clima di contestazione popolare e cassa integrazione a singhiozzo, nel 2012 la magistratura avviò un’indagine per disastro ambientale, sequestrando l’area a caldo. Gli operai, affiancati da molti abitanti dei quartieri, reagirono alla minaccia di per dita del posto di lavoro, con una manifestazione di massa che bloccò di fatto l’uscita e l’ingresso alla città.
Nel periodo successivo, si svilupparono da una parte mobilitazioni operaie per la difesa dei posti di lavoro e dall’altra quelle degli ambientalisti e da settori di masse popolari che ponevano la questione dell’avvelenamento della salute collettiva. Raramente le rivendicazioni si unirono, a causa della direzione della lotta operaia in mano alle burocrazie confederali, tutte tese semplicemente alla continuità produttiva – e dall’altra per l’egemonia dell’ambientalismo borghese [6], che non si poneva la questione occupazionale. Inoltre, era evidente come per lo Stato, nel suo compito di tutela complessiva degli interessi della classe dominante, la gestione dei Riva fosse divenuta scomoda: sia per la gestione spregiudicata della produzione, sia per le tensioni derivate dalla loro impopolarità, sia perché il gruppo industriale non aveva mai voluto integrarsi con l’alta finanza, rifiutando la quotazione in borsa e gestendo l’azienda in termini familiari. Tutto ciò portava all’approvazione del decreto “salva Ilva” da parte del governo Letta il 4 giugno del 2013, in cui si stabiliva un commissariamento dell’impianto siderurgico, visto il suo costituire “interesse strategico nazionale”, approvando poi l’anno successivo un piano ambientale di facciata. Nel gennaio del 2015, l’intero gruppo Ilva, comprendente dunque anche sia gli impianti di Taranto che quello di Genova, fu posto in amministrazione straordinaria, in attesa di nuovo investitore, rivelatosi poi, due anni dopo, in ArcelorMittal, un colosso dell’acciaio mondiale nato nel 2006 dal la fusione delle aziende Arcelor (a capita le francese, lussemburghese e spagnolo) e dalla Mittal Acciaio (a capitale indiano). ArcelorMittal ha inglobato a sé numerose aziende a livello mondiale, molte delle quali hanno poi subito gravi perdite economiche e alcuni altoforni sono stati gradualmente spenti, anche in Europa, in attuazione di una strategia monopolista di centralizzazione [7] e ristrutturazione/distruzione di capitali e forze produttive concorrenti e in eccedenza.
Tre anni dopo, nel 2020, lo Stato, tramite la società Invitalia, controllata dal ministero dell’economia, rientra nella gestione del gruppo ex Ilva, tramite un accordo del governo con i monopolisti di ArcelorMittal. Sempre in nome della strategicità dell’impianto per gli interessi del capitalismo italiano, la società governativa entra nel capitale del gruppo al 38%, lasciando il 62% in mano ai monopolisti euro-indiani. Passano gli anni e i rapporti tra i soci si complicano sui nodi della strategia industriale e finanziaria complessiva, anche perché nel frattempo i volumi di produzione diminuiscono e si parla nuovamente di chiusura. All’inizio di quest’anno, arriva al pettine la contraddizione tra l’acquisizione speculativa di ArcerlorMittal e l’interesse strategico del capitalismo italiano. Invitalia a febbraio formalizza la richiesta di amministrazione straordinaria all’esecutivo di Meloni e a marzo la ottiene in maniera scontata, trattandosi di fatto dello stesso soggetto governativo che agisce con due facce diverse. Si è verificato, dunque, lo scenario particolare per cui una società governativa abbia chiesto al governo di rimettere le mani su un’azienda strategica: un’operazione politica di chiara matrice dirigista nel contesto della crisi capitalistica, dell’inasprimento della concorrenza intermonopolista e della necessaria difesa dall’alto degli interessi generali della formazione imperialista italiana.
Attualmente, quindi, il gruppo ex Ilva è in amministrazione straordinaria da parte del governo, che vi ha posto a capo, temporaneamente, dei commissari, in attesa di un nuovo compratore. L’obbiettivo dell’esecutivo pare quello di trovare un acquirente che sappia contraccambiare la possibilità di mettere le mani sul più grande stabilimento di produzione dell’acciaio d’Italia con la garanzia della sua continuità produttiva, nell’interesse generale del sistema capitalistico nazionale.
Movimento ambientalista e ruolo della classe operaia
L’ordinanza della magistratura, nel luglio del 2012, fu un trampolino di lancio per le mobilitazioni ambientaliste che si sono venute a generare a ridosso, dando vita a un vero e proprio movimento No Ilva. L’intervento della magistratura si è collocato così all’apice della mobilitazione ambientalista, costituendo la risposta con cui lo Stato, dunque la classe dominante nel suo complesso, puntano a coltivare la propria egemonia, governando le contraddizioni sociali che il loro sistema produttivo determina. Magistratura che, ricordiamolo, è uno dei bracci dello Stato posto a tutela degli interessi del capitale: da un lato reprime chi mette in discussione lo status quo delle cose (come è accaduto anche a Taranto), dall’altro per interessi interni alla stessa borghesia dominante si fa protagonista delle rivendicazioni ambientali collettive, strumentalizzandole e storpiandole. L’intervento della magistratura, in un momento nel quale la situazione stava fuggendo di mano al gruppo Riva in termini industriali e nel quale le masse erano in movimento, ha normalizzato lo sviluppo di tali contraddizioni, coltivando l’egemonia dello Stato e preparando il terreno a nuovi padroni, sfruttatori e avvelenatori quanto i vecchi.
Se guardiamo al passato di questa vicenda, notiamo come il movimento ambientalista, ponendosi al carro della magistratura, ha contribuito all’isolamento della classe operaia. Affidarsi ad uno strumento della classe dominante per “combattere dall’interno” le sue stesse contraddizioni, non può che sfociare in un giustizialismo piccolo borghese, che immagina un “capitalismo pulito e sano” poiché comandato a bacchetta da “toghe integerrime”.
L’egemonia borghese nel movimento ha determinato il prevalere di parole d’ordine e azioni mirate verso una generica “cittadinanza”, piuttosto che a chi vive ogni giorno all’interno della fabbrica stessa e rispetto alle masse popolari dei quartieri. La disgregazione del movimento è avvenuta quando si è prodotto lo stacco netto fra operai e “cittadinanza”. La terminologia non può che essere espressione dell’ideologia che ne sta alla base: auspicare la mobilitazione di operai e “cittadini” pone già basi per un divario fra i due. Ma un problema ancora più grande sorge quando la borghesia utilizzando la categoria della “cittadinanza” si insinua nel movimento e ne devia la lotta. Chi
erano e sono questi fantomatici “cittadini”? Gli operai non sono forse “cittadini”? I “cittadini” non possono essere operai o, quantomeno, mogli, padri, madri, figli, amici delle migliaia e migliaia di operai impiegati nell’acciaieria?
Un fatto allo stesso tempo curioso e tragico, considerando che Taranto è una città prevalentemente operaia, precaria, dalle mille contraddizioni. Ed infatti, il movimento era, specie ai suoi albori, formato principalmente dalle fasce popolari della città, e aveva raggiunto elevati numeri nelle piazze.
Nel successivo sviluppo, il classismo borghese, con la maschera del cittadinismo, non poteva che palesarsi nella colpevolizzazione dell’operaio, visto come nemico, coincidendo in questo con gli stessi interessi dei padroni dell’Ilva e dei vari governi, che così potevano e possono far passare ristrutturazioni e privatizzazioni trovando una classe lavoratrice isolata e intimorita dalle accuse di essere causa dell’inquinamento, solo perché ricava il suo salario dal lavoro nell’acciaieria.
“No Ilva” ha finito per significare no all’Ilva in quanto fabbrica, non in quanto contraddizione del capitale con la salute collettiva. “Chiusa l’Ilva, Taranto potrà rinascere”, si ripeteva come un mantra. Numerose sono state le petizioni, i banchetti per le firme per la chiusura della fabbrica, le denunce alla classe dirigente e politica (comunale, provinciale e regionale), conclusi in generiche condanne per i vecchi padroni e i loro rappresentanti (Riva e Vendola) mentre i nuovi (Mittal ed Emiliano) continuavano con i medesimi meccanismi di devastazione del territorio e dei suoi abitanti.
Si è prodotta così la frattura netta fra la classe operaia e la gestione opportunista del movimento ambientalista. D’altra parte la classe operaia, per difetto di consapevolezza e di direzione, non è riuscita a promuovere un proprio campo di alleanze attorno a sé, trattando la contraddizione lavoro-salute sul la base esclusivamente del proprio interesse a mantenere il posto di lavoro, tralasciando la questione ambientale. Responsabili in tal senso sono stati i burocrati dei sindacati confederali, che sono andati a braccetto coi padroni, collaborando sulle casse integrazioni, sulla produttività a tutti i costi, con la scusante della tutela dei posti di lavoro, proclamando scioperi farlocchi per fare da gran cassa al ricatto occupazionale agitato da Riva e, successivamente, dai governi subentrati nell’amministrazione commissariale.
La città intera – la classe operaia e i proletari dei quartieri in primis – venivano ricattati con il dover scegliere fra la salute e il lavoro. Questo ricatto, nel dare priorità all’uno piuttosto che all’altro e viceversa, è stato, per forza di cose, un ricatto padrona le e dello Stato italiano. Questo ricatto si è tradotto anche nella polarizzazione dell’opinione pubblica. Gli operai non venivano più solo schiacciati dal ricatto padronale, ma anche lacerati tra chi pretendeva una chiusura immediata per l’esclusiva tutela della salute e chi auspicava ad una continuità
della produzione sacrificando la salute. Due facce della stessa medaglia che, in chiave anti-operaia ed anti-popolare, hanno soffocato quella parte di classe operaia e masse popolari attivi su entrambi i fronti.
Ogni spontaneismo delle masse, come ci insegna Lenin, non può che inevitabilmente risultare fallimentare se non si compie il passaggio successivo, se quindi non si forma coscienza e lotta di classe. Solo la classe operaia poteva essere fautrice e protagonista della mobilitazione popolare che rivendicava sia la tutela dell’ambiente che quella del lavoro, poiché essa viveva concretamente ambedue le contraddizioni, pa
tendo contemporaneamente la nocività e il ricatto occupazionale.
Immaginario borghese e realtà
Dal movimento ambientalista sono emerse delle rivendicazioni puramente interclassiste che vedono nella turistificazione della città un presunto riscatto sociale. Un immaginario sentito in città, che purtroppo ha fatto breccia anche fra le masse. “Taranto deve e può vivere di turismo”, si dice. Ma come può un’ennesima espressione del capitale affermarsi come riscatto per una città intera, in cui la precarietà, gli sfratti, le malattie e l’incertezza del domani sono la quotidianità per la stragrande maggioranza della popolazione? Ancora una volta la classe operaia e le masse popolari continuano ad essere spettatrici della propria oppressione e la palla passa ai nuovi padroni (della ristorazione, dei lidi privati, degli hotel), riproducendo le stesse dinamiche, o addirittura amplificandole, di miseria e povertà, di contratti inesistenti, di salari da fame e di sfruttamento esasperato.
Ed è qui che prendono tristemente vita gli immaginari della classe dominante e dei nuovi padroni locali. Ad esempio il turismo delle navi da crociera, promosso anche da alcuni pseudo ambientalisti, rappresenta gli interessi di una borghesia commerciale e speculatrice, peraltro anch’essa nociva per l’ambiente come quella industriale [8]. Gli opportunisti [9] dell’ambientalismo piccolo borghese che hanno alimentato questa idea, tralasciano però il dato che l’occupazione di massa nel settore turistico è possibile solo attraverso i salari da fame, l’occupazione stagionale, i contratti inesistenti, le condizioni di lavoro precarie e i ricatti padronali, odiosi tanto quelli imposti dentro l’Ilva. Tralasciano il fatto che il turismo si porta dietro la gentrificazione dei quartieri, in cui chi vive il territorio è cacciato dalla propria casa. I dati alla mano di luglio 2024 riportano che cinquecento famiglie sono a rischio sfratto. Un numero in aumento di anno in anno, che puntualmente vede fra le duecento e le trecento famiglie rischiare di perdere la propria abitazione. Un disagio sociale individualizzato e invisibilizzato, nonostante sia il quotidiano in città. Case che vengono trasformate in Bed and Breakfast, facendo profitto sulla pelle delle famiglie che finiscono in strada.
Un quadro in cui si colora per i turisti l’ingresso della Città Vecchia attraverso l’apertura di locali escludenti verso gli stessi abitanti della zona e in cui prende piede l’opportunista narrazione dei padroni della ristorazione: volere l’Ilva chiusa per la tutela della città a parole, ma nei fatti per far andare bene i propri affari. Sono i medesimi soggetti che propinano la narrazione colpevolizzante verso gli operai dell’Ilva, visti come fautori del disastro, alimentando un classismo feroce.
In un contesto come quello contemporaneo in cui la guerra è alle porte di casa e il rischio di un conflitto globale cresce sempre di più, anche l’Ilva può avere potenzialmente un ruolo nei venti bellici che soffiano sull’Italia. Lo scorso 11 giugno, rappresentanti di Metinvest, multinazionale ucraina dell’acciaio, hanno fatto visita allo stabilimento pugliese in vista di un possibile acquisto.
C’è da sottolineare che l’Ilva non è stata mai finora impegnata nella produzione di acciaio bellico, il quale richiede un trattamento differente rispetto a quello adottato nella produzione che conosciamo fin ora nel polo. Tuttavia una potenziale riconversione non è da escludersi. Seppur non bolle (ufficialmente) nulla in pentola sul futuro del polo siderurgico, il rischio di coinvolgimento dello stabilimento nella produzione bellica non è da escludere, vista la situazione internazionale, e gli stessi sindacati confederali non si trattengono dall’ennesima porcata, definendo come “un segnale di appetibilità produttiva” [10] la visita degli ucraini a Taranto. Metinvest è parte della classe dominante ucraina, finanziatrice di retta dell’esercito del regime di Zelensky: ora forse cerca nell’ex Ilva uno stabilimento che sostituisca quello di Azovstal a Mariupol, che era di sua proprietà e aveva una capacità produttiva paragonabile all’Ilva. Azovstal è andato distrutto nel maggio del 2022 durante l’assedio dei russi, dopo che al suo interno si erano rintanati i nazisti del battaglione Azov. Già attualmente, l’ex Ilva di Taranto è stata inserita nelle catene del valore di Metinvest, ridefinite a seguito dell’annessione da parte russa di Mariupol [11].
In uno scenario come questo, dove tutto si è detto e nulla si è fatto, in cui le masse locali si sono fatte dividere, è ora di aprire ad una prospettiva di lotta di classe contro ogni tipo di sfruttamento: dalla nocività della produzione alla devastazione ambientale, dalla turistificazione e gentrificazione, fino all’economia di guerra. Taranto non può continuare ad essere oggetto di ricatto nelle mani dei padroni, c’è bisogno di lotta delle masse, di aprire nuovi immaginari di liberazione, e non passaggi di palla fra sfruttamenti differenti.
La ricostruzione di un movimento cosciente della propria condizione di classe non deve ripetere gli errori del passato: è nella fabbrica che bisogna agitare, lottare, bloccare, scioperare. E nella stessa misura si farà nei quartieri e in tutti i luoghi di lavoro; lottando così per la tutela del proprio luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente, men tre si sviluppa anche la coscienza di classe e politica tra le masse e i lavoratori. Solo in questa prospettiva il generico “No Ilva” assumerà senso compiuto, rompendo con l’ambientalismo piccolo borghese, diventando no allo sfruttamento e alla distruzione della natura e delle persone, andando di pari passo con il no al turismo di massa, il no al lavoro precario, no a una vita di stenti, di malattie, morte, miseria e guerra.
Nella condizione della “fabbrica che non può chiudere”, perché finora la classe dominante ha deciso così, o c’è un rilancio del movimento operaio in grado di porre al centro i propri interessi di classe, inclusa la trasformazione rivoluzionaria dei rapporti sociali, oppure la borghesia avrà sempre buon gioco a dividere le masse per imporre loro i suoi interessi di sfruttamento, oppressione e guerra che, come la storia del capitalismo insegna, portano con sé anche la tragedia della devastazione ambientale. La necessità di un cambiamento rivoluzionario è un’esigenza storica che riguarda il mondo intero e Taranto non può esserne esente. E i popoli in rivolta che stanno scrivendo la storia, a partire dalla Palestina, indicano il sentiero.
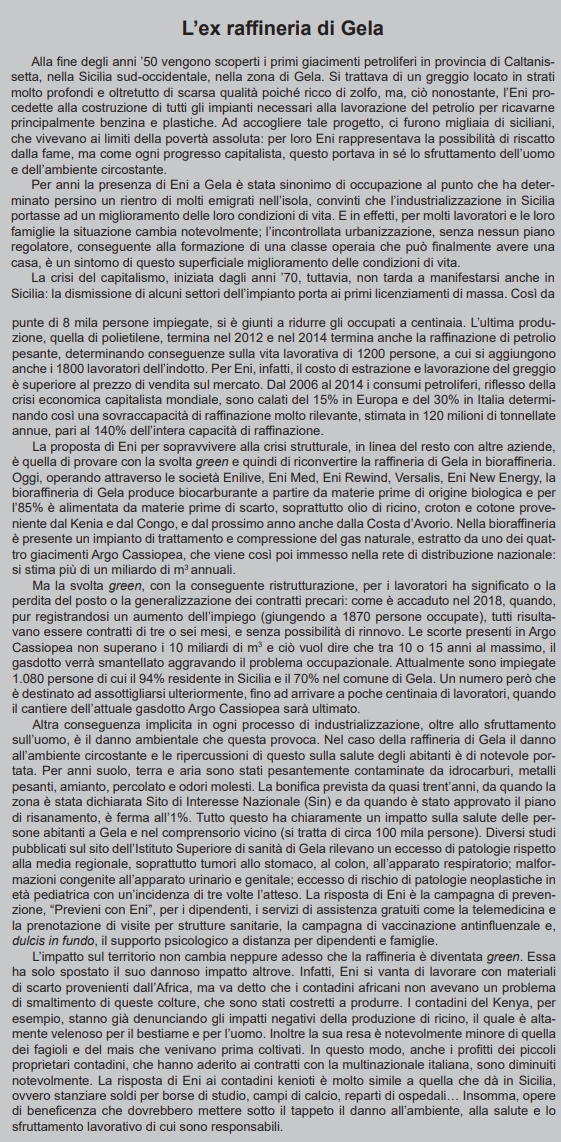
NOTE:
[1] Siderweb: nel 2022 cala in Italia la produzione di acciaio (-11,5%). 2023 tra stabilità e recessione, industriaitaliana.it 19.1.23
[2] La produzione mondiale di acciaio torna a scendere, siderweb.com, 24.4.24
[3] A. Tundo, L’ex Ilva fissa il prezzo della sicurezza: 100 euro (forse) agli operai che non si fanno male, fattoquotidiano.it, 2.12.23
[4] Allarme del registro tumori: emergenza per l’area di Taranto, quotidianodipuglia.it, 8.6.16
[5] Ibidem
[6] Vedi Antitesi n° 5, Ambientalismo e lotta di classe, pp. 19 ss. e Antitesi n° 8, Ambientalismo e capitale, pp. 24 ss
[7] Vedi sopra pp. 17 e ss.
[8] Quanto inquinano le navi da crociera? (Spoiler: troppo), eicomenenergia.it, 14.6.24 [9] Vedi Glossario pp. 84 [10] C. Bechis, Ex Ilva, distrutta Mariupol gli ucraini puntano su Taranto: visita allo stabilimento e incontro con i commissari, bari.corriere.it, 24.6.24 [11] Vedi G. Di Meo, Ponte d’acciaio tra Taranto e Mariupol, buonasera24.it, 14.3.23L’ex raffineria di Gela
Alla fine degli anni ’50 vengono scoperti i primi giacimenti petroliferi in provincia di Caltanissetta, nella Sicilia sud-occidentale, nella zona di Gela. Si trattava di un greggio locato in strati molto profondi e oltretutto di scarsa qualità poiché ricco di zolfo, ma, ciò nonostante, l’Eni procedette alla costruzione di tutti gli impianti necessari alla lavorazione del petrolio per ricavarne principalmente benzina e plastiche. Ad accogliere tale progetto, ci furono migliaia di siciliani, che vivevano ai limiti della povertà assoluta: per loro Eni rappresentava la possibilità di riscatto dalla fame, ma come ogni progresso capitalista, questo portava in sé lo sfruttamento dell’uomo e dell’ambiente circostante. Per anni la presenza di Eni a Gela è stata sinonimo di occupazione al punto che ha determinato persino un rientro di molti emigrati nell’isola, convinti che l’industrializzazione in Sicilia portasse ad un miglioramento delle loro condizioni di vita. E in effetti, per molti lavoratori e le loro famiglie la situazione cambia notevolmente; l’incontrollata urbanizzazione, senza nessun piano regolatore, conseguente alla formazione di una classe operaia che può finalmente avere una casa, è un sintomo di questo superficiale miglioramento delle condizioni di vita.
La crisi del capitalismo, iniziata dagli anni ’70, tuttavia, non tarda a manifestarsi anche in Sicilia: la dismissione di alcuni settori dell’impianto porta ai primi licenziamenti di massa. Così da punte di 8 mila persone impiegate, si è giunti a ridurre gli occupati a centinaia. L’ultima produzione, quella di polietilene, termina nel 2012 e nel 2014 termina anche la raffinazione di petrolio pesante, determinando conseguenze sulla vita lavorativa di 1200 persone, a cui si aggiungono anche i 1800 lavoratori dell’indotto. Per Eni, infatti, il costo di estrazione e lavorazione del greggio è superiore al prezzo di vendita sul mercato. Dal 2006 al 2014 i consumi petroliferi, riflesso della crisi economica capitalista mondiale, sono calati del 15% in Europa e del 30% in Italia determinando così una sovraccapacità di raffinazione molto rilevante, stimata in 120 milioni di tonnellate annue, pari al 140% dell’intera capacità di raffinazione.
La proposta di Eni per sopravvivere alla crisi strutturale, in linea del resto con altre aziende, è quella di provare con la svolta green e quindi di riconvertire la raffineria di Gela in bioraffineria. Oggi, operando attraverso le società Enilive, Eni Med, Eni Rewind, Versalis, Eni New Energy, la bioraffineria di Gela produce biocarburante a partire da materie prime di origine biologica e per l’85% è alimentata da materie prime di scarto, soprattutto olio di ricino, croton e cotone prove niente dal Kenia e dal Congo, e dal prossimo anno anche dalla Costa d’Avorio. Nella bioraffineria è presente un impianto di trattamento e compressione del gas naturale, estratto da uno dei quattro giacimenti Argo Cassiopea, che viene così poi immesso nella rete di distribuzione nazionale: si stima più di un miliardo di m3 annuali. Ma la svolta green, con la conseguente ristrutturazione, per i lavoratori ha significato o la perdita del posto o la generalizzazione dei contratti precari: come è accaduto nel 2018, quando, pur registrandosi un aumento dell’impiego (giungendo a 1870 persone occupate), tutti risultavano essere contratti di tre o sei mesi, e senza possibilità di rinnovo. Le scorte presenti in Argo Cassiopea non superano i 10 miliardi di m3 e ciò vuol dire che tra 10 o 15 anni al massimo, il gasdotto verrà smantellato aggravando il problema occupazionale. Attualmente sono impiegate 1.080 persone di cui il 94% residente in Sicilia e il 70% nel comune di Gela. Un numero però che è destinato ad assottigliarsi ulteriormente, fino ad arrivare a poche centinaia di lavoratori, quando il cantiere dell’attuale gasdotto Argo Cassiopea sarà ultimato. Altra conseguenza implicita in ogni processo di industrializzazione, oltre allo sfruttamento sull’uomo, è il danno ambientale che questa provoca. Nel caso della raffineria di Gela il danno all’ambiente circostante e le ripercussioni di questo sulla salute degli abitanti è di notevole portata. Per anni suolo, terra e aria sono stati pesantemente contaminate da idrocarburi, metalli pesanti, amianto, percolato e odori molesti. La bonifica prevista da quasi trent’anni, da quando la zona è stata dichiarata Sito di Interesse Nazionale (Sin) e da quando è stato approvato il piano di risanamento, è ferma all’1%. Tutto questo ha chiaramente un impatto sulla salute delle persone abitanti a Gela e nel comprensorio vicino (si tratta di circa 100 mila persone). Diversi studi pubblicati sul sito dell’Istituto Superiore di sanità di Gela rilevano un eccesso di patologie rispetto alla media regionale, soprattutto tumori allo stomaco, al colon, all’apparato respiratorio; malformazioni congenite all’apparato urinario e genitale; eccesso di rischio di patologie neoplastiche in età pediatrica con un’incidenza di tre volte l’atteso. La risposta di Eni è la campagna di prevenzione, “Previeni con Eni”, per i dipendenti, i servizi di assistenza gratuiti come la telemedicina e la prenotazione di visite per strutture sanitarie, la campagna di vaccinazione antinfluenzale e, dulcis in fundo, il supporto psicologico a distanza per dipendenti e famiglie.
L’impatto sul territorio non cambia neppure adesso che la raffineria è diventata green. Essa ha solo spostato il suo dannoso impatto altrove. Infatti, Eni si vanta di lavorare con materiali di scarto provenienti dall’Africa, ma va detto che i contadini africani non avevano un problema di smaltimento di queste colture, che sono stati costretti a produrre. I contadini del Kenya, per esempio, stanno già denunciando gli impatti negativi della produzione di ricino, il quale è altamente velenoso per il bestiame e per l’uomo. Inoltre la sua resa è notevolmente minore di quella dei fagioli e del mais che venivano prima coltivati. In questo modo, anche i profitti dei piccoli proprietari contadini, che hanno aderito ai contratti con la multinazionale italiana, sono diminuiti notevolmente. La risposta di Eni ai contadini kenioti è molto simile a quella che dà in Sicilia, ovvero stanziare soldi per borse di studio, campi di calcio, reparti di ospedali… Insomma, opere di beneficenza che dovrebbero mettere sotto il tappeto il danno all’ambiente, alla salute e lo sfruttamento lavorativo di cui sono responsabili.




