Clima di guerra
La questione ambientale tra crisi, ristrutturazione e guerra
“Imperialismo e guerra” da Antitesi n.12 – pag.44
La guerra in Ucraina ha già cambiato radicalmente la partita della questione ambientale per come è stata fin qui giocata, in primo luogo dalla borghesia imperialista Ue, per rilanciare un proprio piano di ristrutturazione capitalistica ed egemonico in dialettica con il movimento ambientalista. Oggi siamo al punto che è posta all’ordine del giorno la riapertura generalizzata delle centrali a carbone e, in generale, l’energia di origine fossile è tutt’altro che in dismissione, acquistando invece maggiore importanza, diventando un’arma che viene impugnata tatticamente nella dimensione economica della guerra per provocare danno all’avversario.
In realtà, il fatto che la crisi climatico-ambientale stesse perdendo di interesse nell’ambito delle contese tra le diverse consorterie imperialiste lo si era già potuto notare con l’esito della Cop 26.
“La negoziazione perfetta è quella che scontenta tutti”, aveva detto il segretario di Stato americano, John Kerry, inviato speciale di Biden alla Cop 26 sul clima. Il commento di Kerry cercava maldestramente di coprire il deludente risultato dell’accordo raggiunto dai 197 Stati partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, meglio nota come Cop 26, che si è tenuta dal 31 ottobre a 12 novembre 2021 a Glasgow in Scozia.
Dal punto di vista concreto la Cop 26 è stata un ulteriore vertice inconcludente dopo quelli del Protocollo di Kyoto (1997) e dell’Accordo di Parigi (2015). A fronte del drammatico aggravarsi della crisi climatica non si è andati oltre l’ennesima dichiarazione di intenti formalizzata da un accordo finale promosso e imposto da un inedito allineamento tra India, Cina e Usa.
Si è trattato a tutti gli effetti di una sorta di tregua nella cosiddetta guerra climatica che oppone le potenze occidentali, Usa in testa, alle potenze emergenti, Cina in testa. L’oggetto del contendere di questa guerra climatica, cioè l’obiettivo di contenere le emissioni di Co2 in atmosfera causate dalla produzione di energia di origine fossile (al fine di contenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali), è stato trattato adottando il solito accorgimento di decidere di non decidere. Si è proseguendo nella formula degli inviti e delle esortazioni a promuovere le fonti energetiche rinnovabili, a ridurre le centrali a carbone e i sussidi alle fonti fossili, rimandando però qualsiasi tipo di risoluzione operativa al prossimo vertice Cop che si terrà nel 2022 in Egitto.
La contraddizione tra la vecchie potenze (Usa, Ue e Giappone), che sono di gran lunga storicamente le maggiori responsabili dei livelli raggiunti dalla devastazione ambientale, e le nuove potenze emergenti che sono attualmente le maggiori inquinatrici a livello globale (in ordine di emissioni: Cina, India e Russia) si è nuovamente evidenziata. Le prime puntano a mantenere e a rafforzare la propria supremazia globale in crisi attraverso lo sviluppo delle nuove fonti rinnovabili, fonti su cui hanno un vantaggio tecnologico che favorisce un controllo monopolistico, le seconde rivendicano la possibilità di continuare ad utilizzare le vecchie fonti fossili, ritenendole ancora necessarie per lo sviluppo delle loro economie.
La forte resistenza dell’India a considerare l’eliminazione graduale dell’uso del carbone ha imposto, nel documento finale, il termine di “riduzione graduale”. La disincentivazione dei sussidi al settore dei combustibili fossili è stata ridimensionata e riguarda solo quelli considerati “inefficienti”. Su questa linea di compromesso chi ci ha rimesso sono gli Stati più piccoli e più colpiti dalle conseguenze della crisi climatica che denunciano di essere stati messi di fronte ad un aut aut1. In particolare il modo con cui è stata trattata, nel documento finale, la problematica del sostegno finanziario ai paesi meno sviluppati per aiutarli ad affrontare la crisi climatica mostra chiaramente lo stile di decidere di non decidere. C’è stato l’invito a che i cosiddetti paesi ricchi raddoppino gli stanziamenti, ma non è stata fissata alcuna scadenza per attivare il fondo (già previsto dall’Accordo di Parigi e mai realizzato) di 100 miliardi di dollari all’anno di aiuti per la decarbonizzazione. A fronte della non volontà dei paesi più avanzati di procedere all’erogazione di finanziamenti, anche dopo Glasgow, il fondo è rimasto una promessa.
In aggiunta, per quanto riguarda il risarcimento delle perdite dovute al cambiamento climatico nei paesi più vulnerabili, il documento finale non ha previsto alcun fondo specifico, ma solo di avviare il dialogo in proposito2.
Il fatto che la guerra climatica, come capitolo dello scontro tra vecchie potenze e potenze emergenti, sia stata momentaneamente sospesa ha avuto anche come conferma le mancate conseguenze e reazioni al veto posto dalla Russia nei confronti della prima risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite volta a definire “la crisi climatica come minaccia alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo internazionale”. La risoluzione proposta da Irlanda e Niger e appoggiata da 12 dei 15 paesi che compongono il Consiglio di sicurezza (India e Russia contrarie e Cina astenuta) era tesa a inserire la questione climatica all’interno delle strategie Onu per la gestione dei conflitti, delle operazioni per il mantenimento della pace e nelle cosiddette missioni politiche.
La tregua armata sul clima formalizzata nel compromesso a ribasso di Glasgow ha registrato da una parte il rapporto di forza che sono in grado di far valere le potenze emergenti e dall’altra la volontà Usa di non procedere sul piano operativo.
Le ragioni più profonde di questa tregua sono da ricercare sia nelle difficoltà ad abbandonare la produzione fossile che incontrano le economie emergenti (ma anche quelle avanzate), sia in quelle che si determinano nell’ambito dell’implementazione della produzione energetica rinnovabile e cosiddetta sostenibile. Se però gli Usa in qualche modo hanno sorriso all’accordo, l’Unione europea si è trovata messa all’angolo. Il vicepresidente con delega al Green deal, Frans Timmermans ha ingoiato la pillola appoggiando un accordo che ha detto espressamente di non condividere.
Gestione capitalistica della crisi climatica e ambientale
La Ue, a direzione tedesca, da tempo cavalca la questione ambientale come volano per far uscire l’economia dalle secche della crisi di sovraccumulazione di capitale. Il grande capitale è passato dal negazionismo della questione ambientale al considerarla una grande opportunità attraverso il lancio di un Green deal europeo. Alla base di questo Green deal c’è il proposito della borghesia imperialista europea, a direzione tedesca, di fare fronte alla crisi di sovraccumulazione di capitali in cui è impelagato da decenni il capitalismo e di riproporre l’Ue come grande potenza globale proprio ponendosi alla testa della “rivoluzione ambientale”.
Già prima della pandemia, nel primo Business Forum trilaterale delle Confindustrie di Germania, Francia e Italia, tenutosi a Roma all’inizio di dicembre 2019, i padroni industriali dell’Europa indicavano la necessità di “fare della mitigazione dei cambiamenti climatici un obiettivo stabile e inclusivo a lungo termine … per rendere l’economia molto più dinamica e competitiva”. Prevedevano che l’implementazione di questo Green Deal avrebbe richiesto “un robusto aumento degli investimenti aggregati, pari a circa 250-300 miliardi di euro annui, a cui si sarebbe dovuto aggiungerne altrettanti “da destinare alle innovazioni e alla digitalizzazione, alla industria e alle infrastrutture, nonché alla ricerca e sviluppo”3.
Alla luce del poi, risulta chiaramente evidente come questi “suggerimenti” dei padroni sono stati recepiti e rilanciati nel Recovery Plan europeo e nelle sue articolazioni nazionali, prendendo la palla al balzo della “pandemia”. L’emergenza Covid è stata utilizzata per promuovere un keynesismo green, per costituire attraverso il grande indebitamento pandemico il volano finanziario di una grande riconversione, verso un modello produttivo ritenuto necessario per rilanciare la valorizzazione e far uscire il sistema dalle secche della crisi di sovraccumulazione di capitali.
Dal punto di vista delle teorie economiche, assistiamo ad un drastico accantonamento sia del neoliberismo anglosassone che dell’ordoliberismo tedesco. Non si tratta di una svolta “buonista” alla ricerca di una nuova edizione del “capitalismo dal volto umano”, ma di una scelta obbligata di fronte all’ennesimo tornante di aggravamento della crisi di sovraccumulazione di capitale. Aggravamento che ha riscontrato la particolare coincidenza con la “pandemia” da Covid e che con essa è stato giustificato.
La vulgata della crisi economica dovuta al Covid è stata utile a nascondere la realtà di un capitalismo della fase imperialista che parafrasando Lenin si può dire sempre più di putrefazione del sistema. Ma è stata utile anche a legittimare l’inversione di rotta keynesiana. Il keynesismo (in versione green) potenziato dai grandi indebitamenti pandemici torna di nuovo utile per salvare il sistema diretto dall’oligarchia finanziaria. Dalla Grande Depressione del ‘29 le politiche interventiste dello Stato, tramite l’indebitamento pubblico in economia da esso ispirate, sono sempre state l’ultima spiaggia dei tentativi di uscire dalla crisi.
La necessità di fare fronte alla crisi climatica (con l’ausilio della questione sanitaria) è così interpretata come il presupposto ideologico utile al rilancio di un nuovo modello di accumulazione. A questo fine anche l’apertura e lo sviluppo del dialogo con il movimento ambientalista sono articolati dalla borghesia imperialista Ue come una vera a propria linea di massa per legittimare culturalmente, socialmente e politicamente questo passaggio. La riconversione economica epocale, di cui il Green deal è il cappello ideologico, apprestata come tentativo di uscita dalla crisi, ha bisogno, infatti, di essere giustificata e legittimata agli occhi delle masse perché saranno queste a pagarne i costi certi (licenziamenti, aumento delle tariffe, nuove devastazioni ambientali nei paesi della periferia, ecc.), mentre i possibili vantaggi saranno appannaggio della borghesia imperialista (sovrapprofitti, asset finanziari in crescita, rendite dovute al monopolio di tecnologie ecc.).
La ricerca della supremazia tecnologica è la spinta principale che impone questo passaggio. L’imposizione in chiave monopolistica di un nuovo modello di accumulazione, basato su un deciso salto tecnologico, è la strada che la borghesia imperialista tedesca e Ue hanno intrapreso per puntare al rilancio dei sovrapprofitti e contendere posizioni dominanti nell’ambito della catena imperialista globale.
Il fatto che le strutture deputate a salvaguardare l’interesse complessivo del capitalismo, come governi nazionali e sovranazionali, banche centrali, organizzazioni padronali ecc., soprattutto in Europa siano concordi nel voler imporre la svolta “verde” non vuol dire che la questione sia esente da contraddizioni, anzi. Criticità emergono già in ambito finanziario. Gli investimenti “verdi”, trainati dai mega finanziamenti pubblici, stanno crescendo sui mercati finanziari, ma non è tutto oro quello che luccica. Alla fine del 2021 si è evidenziata una bella crepa. Ilmarinen, un fondo pensione finlandese, ha provocato il peggior tracollo dell’anno per un exchange traded fund (Etf, un tipo di fondi di investimento quotati in borsa) ritirandosi dal fondo di BlackRock (la più importante società di investimento finanziario nel mondo) che investe in società Egs emergenti4. In seguito al disinvestimento gli asset gestiti dal fondo di BlackRock sono crollati da 830 a 69 milioni di dollari perdendo il 91% in due sedute. La gravità dell’episodio è sottolineata dal fatto che Ilmarinen è un fondo pensione, che quindi dovrebbe avere un orizzonte temporale lungo e un carattere non speculativo, e l’investimento era rivolto a imprese asiatiche e russe non certo secondarie come Taiwan Semiconductor Maifacturing, Tencent, Alibaba e Gazprom. La causa del disinvestimento è stata lo scarso rendimento. L’Etf green di BlackRock ha infatti registrato negli ultimi due anni un rendimento del 10,44%, mentre nello stesso periodo l’indice S&P500 ha segnato un rialzo del 43%5. Quella innescata dalla mossa fatta da Ilmarinen è ancora una piccola valanga, ma profila già l’incubo di un’esplosione della bolla green che potrebbe oscurare quella della bolla delle Dot-com (New Economy) del 2000-2001.
Ma la criticità che si è già resa oltremodo più evidente agli occhi e alle tasche delle grandi masse è quella relativa all’onda inflattiva che ha caratterizzato fin da subito la prima fase della ripresa economica post pandemica. In questi mesi l’inflazione ha ripreso a correre, interessando in maniera particolare le materie prime e principalmente quelle strategiche del settore energetico. Diversi fattori vi concorrono sul piano congiunturale. L’enorme liquidità che si è accumulata con il reiterarsi delle manovre monetarie espansive di tutte la Banche centrali (tassi a zero e quantitative easing) per puntellare la valorizzazione in un sistema in crisi è la benzina che alimenta l’incendio. I contrasti interimperialisti ne risultano acuiti, come si evidenzia nel caso delle forniture russe di gas all’Europa e nel precipitare della guerra in Ucraina, ma al fondo c’è una questione strutturale. Nel rimbalzo economico post pandemico l’energia prodotta da fonti rinnovabili si rivela incapace di rimpiazzare nel breve periodo quella prodotta dalle fonti fossili tradizionali, tanto che la produzione di carbone mondiale è in continua crescita. Ad esempio nel 2021 le esportazioni di carbone degli Usa è cresciuta del 30% e il consumo interno del 18%6.
In presenza di una situazione in cui domina l’aspettativa di una domanda in crescita si scatenano anche le operazioni speculative e si scatena un’onda inflattiva foriera di gravi conseguenze come si è già visto con la rivolta in Kazakistan del gennaio scorso.
Un’onda inflattiva che si preannuncia non di breve periodo a cui contribuisce anche quella che è stata definita greenflation, inflazione generata dalla transizione ecologica. Definizione intrigante che però nasconde l’aspetto principale della penuria che si registra nel campo delle materie prime, non solo energetiche, ma che ad esempio coinvolge anche quello dei semilavorati (vedi il caso dei chip). Questa penuria in realtà è un portato del salto tecnologico (che viene colorato green) che va interessando tutte le economie avanzate in competizione tra di loro alla ricerca di una via di uscita dalla crisi di sovraccumulazione.
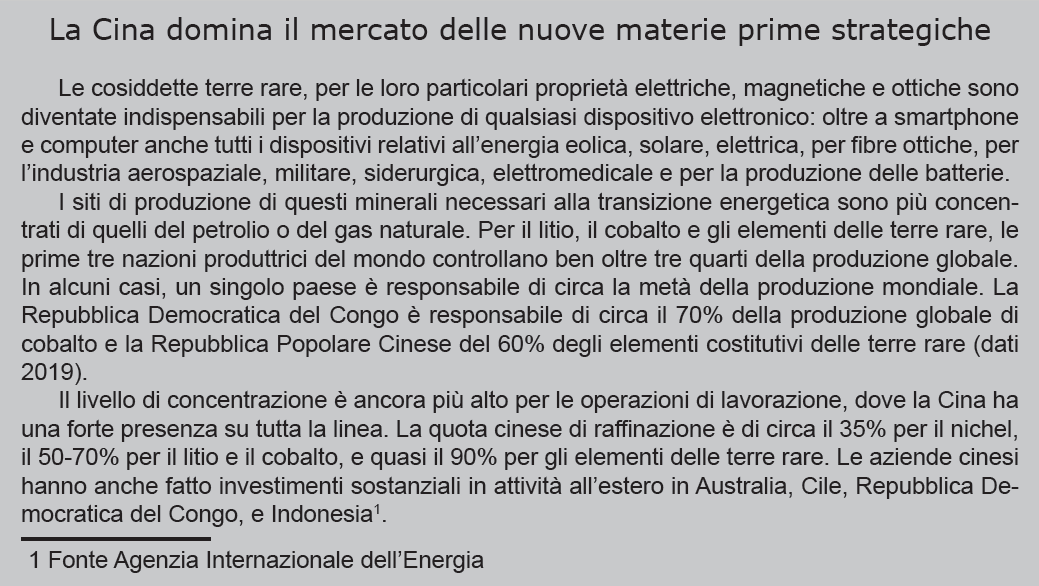
Questione ambientale e crisi del capitale
La strada maestra strutturale di uscita dalla crisi di sovraccumulazione è l’aumento della composizione organica del capitale (più capitale costante e meno capitale variabile impiegati nel processo produttivo inteso come processo di valorizzazione) rivoluzionando la composizione tecnica attraverso l’implementazione di nuove e più avanzate tecnologie (più macchinari e meno operai) alla ricerca di una più elevata produttività del lavoro e di conseguenza maggiore plusvalore relativo, profitto, e sovrapprofitto.
Per questo l’aspetto essenziale della svolta green è il salto tecnologico. La strumentalità del carattere green si smaschera palesemente sulla questione del nucleare. In una situazione che vede l’Europa spaccata in due, tra Stati che investono nel settore (Francia, Regno Unito, Finlandia, Paesi Bassi, Polonia e Estonia) e Stati che, anche grazie alla spinta del movimento antinucleare, lo dismettono (Italia, Germania, Spagna, Belgio e Svizzera), negli ultimi giorni del 2021 la Commissione Europea ha deciso di inserire il nucleare (e il gas naturale) all’interno della “tassonomia” prevista dal Green deal europeo che dà gli indirizzi per l’investimento delle risorse finanziarie da stanziare in attività economiche considerate sostenibili dal punto di vista ambientale. La decisione ha tra l’altro suscitato disappunto all’interno del nuovo governo tedesco7.
La crescita della produttività del lavoro in regime capitalistico ha però come portato il fatto che l’incremento dei profitti è possibile solo con un incremento ancora più grande del volume della produzione. Deve essere prodotto un numero maggiore di prodotti per garantire la valorizzazione del capitale e questo ha come conseguenza diretta un grande aumento del volume delle materie prime trattate. “Quanto più è sviluppata la produzione capitalistica, quanto maggiori sono perciò i mezzi per aumentare improvvisamente e in modo duraturo la parte del capitale costante composta di macchine, ecc., quanto più rapida è l’accumulazione, tanto maggiore sarà la sovrapproduzione relativa di macchine e altro capitale fisso, e tanto più frequente la sottoproduzione relativa delle materie prime (…); tanto più marcati saranno il già descritto aumento del loro prezzo e le ripercussioni ad esso corrispondenti”8.
Qui abbiamo la radice profonda dell’impatto del capitalismo nella questione ambientale. Perché il capitalismo ha devastato e distruggerà sempre di più l’ambiente? La risposta è la ricerca di sovrapprofitti tramite la competizione tecnologica tra le imprese alla costante ricerca dell’aumento della produttività del lavoro. Questo ha come conseguenza fondamentale la progressione della caduta tendenziale del saggio di profitto e l’aumento volumetrico della produzione per garantire la stessa massa di profitto.
Non c’è scampo. Aumentare la produttività del lavoro in regime capitalistico si traduce direttamente in fame di materie prime, nella progressione della devastazione ambientale per produrle e nell’acutizzarsi della tendenza alla guerra tra i diversi gruppi imperialisti per accaparrarsene.
Contrasti interimperialisti a partire dalla svolta verde
Come abbiamo visto la cosiddetta svolta green europea, cioè il piano di colorare di verde il salto tecnologico, si colloca all’interno dell’aggravamento della crisi di sovraccumulazione di capitali che attanaglia le economiche delle cosiddette formazioni avanzate. Questo passaggio si colloca inevitabilmente nel contesto dell’accelerazione della tendenza alla guerra, verso la quale la stessa crisi del capitalismo della fase imperialista conduce. Il tragico riscontro di questa interconnessione è la guerra in Ucraina. Qui la linea strategica degli imperialisti occidentali, Usa in testa, di penetrazione ad est portando la Nato fino ai confini della Russia, impattando con la resistenza del popolo del Donbass e la risoluta volontà degli oligarchi russi di difendere la loro sfera di influenza, è stata costretta ad uscire dalle nebbie della palude della guerra strisciante, fino a evidenziarsi come il principale fattore dell’aggravamento della guerra in Europa. Nel conflitto geostrategico sulle sfere di influenza ha un posto di primo piano la questione delle materie prime e in particolare il flusso di gas russo verso l’Europa. Qui la contraddizione legata alla penuria di materie prime ha un aspetto congiunturale e uno di più ampio respiro. Sul piano congiunturale (tattico) vediamo come la questione sia giocata dall’amministrazione Biden, principale responsabile dell’aggravamento della situazione, per rinsaldare il campo imperialista occidentale e ribadire una gerarchia imperialista sotto il suo comando. Puntando con questo a contrastare la propria grave crisi di egemonia, ben evidenziata dalla fallimentare avventura afgana.
L’obiettivo non dichiarato, ma coscientemente perseguito dagli Usa, è quello di impedire lo sviluppo dell’interconnessione economica tra Europa e Russia. L’effetto immediato della precipitazione della crisi è stato una nuova grande pressione al rialzo del prezzo del gas, che aveva già visto la quintuplicazione nel giro di un anno. Il blocco dell’entrata in funzione del gasdotto già ultimato Nord Stream 2 e la reazione russa, improntata alla riduzione delle forniture all’Europa, aprono allo scenario della trasformazione della svolta green dell’Ue in un vero e proprio bagno di sangue per le economie europee con tragiche conseguenze per i lavoratori e le masse popolari del continente. L’autonomia energetica che l’Ue vuole ottenere con la svolta green non è precisamente dietro l’angolo e il taglio delle forniture russe complica gravemente la fase di transizione.
Inoltre, si struttura a livello globale un nuovo scenario inedito in cui si accentuano le tensioni nelle catene del valore del settore strategico della produzione energetica, fino a provocare rotture e ridefinizioni. Il gas russo che non fluisce in Europa prende la strada della Cina. È già in programma il raddoppiamento dei gasdotti Power of Siberia. Il Power of Siberia 1 è già in funzione con i suoi 2.200 km di tubi che uniscono i giacimenti della Siberia orientale alla Cina del nord (400 mld dollari di business). A pieno regime (2025) porterà 38 miliardi di metri cubi di gas russo all’anno. A questo si aggiungerà il Power of Siberia 2 che sancisce la svolta strategica, dato che collega alla Cina gli stessi giacimenti della Siberia occidentale che finora hanno rifornito l’Europa. Si conteranno altri 50 miliardi di metri cubi previsti a pieno regime9.
Parallelamente gli Usa hanno attivato una fornitura del loro gas all’Europa tramite una flotta di navi cisterna cariche di gas liquefatto (Lng). Un shale gas estratto con la tecnologia del fraking con costi ambientali e di produzione molto più alti, nonché costi di trasporto ancora più onerosi di quello russo, dato che deve essere liquefatto, attraversare via nave l’Atlantico e poi essere rigassificato. A questo si aggiungere il problema strutturale degli impianti di rigassificazione che non sono, ove assenti, di costruzione immediata e hanno anch’essi un impatto pesante a livello di ambiente e di sicurezza delle aree circostanti.
Insomma una gran brutta congiuntura per i progetti Ue. Un cul de sac in cui l’Europa è costretta nella posizione di vaso di coccio in mezzo i vasi di ferro.
Nuove materie prime strategiche
A questa criticità congiunturale se ne aggiunge un’altra più di prospettiva, ma che già inizia a pesare. È la criticità che riguarda le nuove materie prime che diventano fondamentali per il livello tecnologico definito dalla riconversione green. Entrambi i settori in cui si sostanzia questo passaggio, cioè quello della digitalizzazione e quello delle fonti rinnovabili, hanno come materie prime fondamentali le terre rare (cobalto, coltan, litio, disprosio, terbio, ecc.). Dai prodotti di elettronica, alle auto elettriche, fino alle turbine eoliche, tutti i settori in cui prende corpo il salto tecnologico necessitano di queste materie prime che vanno a contendere al petrolio e al gas la posizione di materie prime strategiche.
Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, la domanda di minerali e raw materials secondo le previsioni crescerà del 500% entro il 2050 e questo comporta già una grande corsa all’accaparramento. La prospettiva di una loro penuria, relativa all’eccesso di domanda, già mostra strozzature in alcuni comparti, come ad esempio quello delle batterie per le auto elettriche o quello dei chip per l’industria del settore elettronico.
Questa prospettiva, in una situazione in cui la “pandemia” ha posto sotto stress le catene del valore, indica chiaramente che questo campo sarà uno dei principali delle contese tra i monopoli che si svilupperanno nel prossimo periodo di questa fase imperialista del capitalismo in putrefazione. Ciò si traduce nella tendenza al rilancio dell’oppressione neocoloniale sui popoli che abitano i territori che contengono queste risorse minerarie, come si è già visto con il cosiddetto “Golpe del litio” in Bolivia del novembre 2019. Un golpe promosso dagli Usa e che ha avuto come sponsor Elon Musk patron di Tezla, la più grande impresa di produzione di auto elettriche al mondo. E si traduce anche in fattore di aggravamento delle tensioni interimperialiste tra vecchie potenze e potenze emergenti, in particolare tra Usa e Cina. Una situazione in cui gli appetiti delle formazioni economiche occidentali impegnate nella svolta green sono frustrati dalla posizione di vantaggio della Cina nell’ambito dell’estrazione e raffinazione delle terre rare.
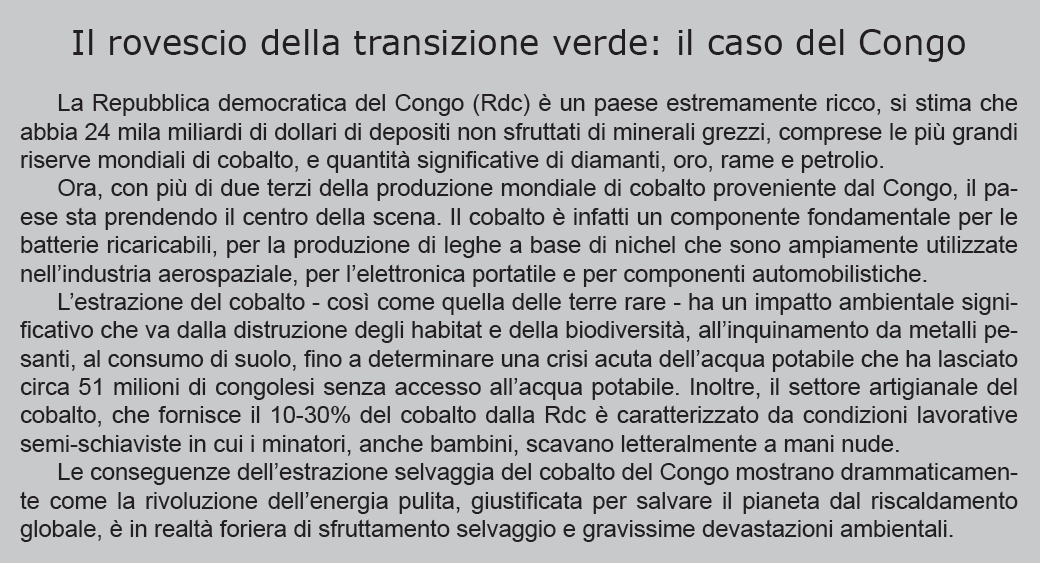
Capitalismo o ambientalismo?
Insomma la svolta green promossa dai gruppi imperialisti occidentali, con un ruolo di punta dell’Ue, è tutt’altro che una soluzione per la questione ambientale, ma risponde alla necessità di implementare un nuovo modello di accumulazione in grado di rilanciare la valorizzazione del capitale. E per molti aspetti è una strada in salita, foriera di molte criticità tra cui quella più evidente è l’accelerazione della tendenza alla guerra.
Dal punto di vista ambientale l’effetto “benefico” dell’economia green, con la sostituzione delle fonti fossili, è tutto confinato nella sfera delle emissioni a unico beneficio delle aree metropolitane avanzate dove si può prevedere diminuirà l’emissione di Co2 nell’aria. Per quanto riguarda invece la produzione e la raffinazione degli elementi minerali necessari ai nuovi settori, ben rappresentati dalle terre rare, si apre un nuovo scenario di grande devastazione ambientale. In particolare, lo sfruttamento delle terre rare genera una contaminazione da torio, un elemento radioattivo rilasciato durante l’estrazione, che ha effetti devastanti sul territorio circostante. Questo ha comportato il rallentamento delle estrazioni di terre rare negli Usa dove è stata posta sotto inchiesta la miniera californiana di Mountain Pass, principale fonte mondiale di terre rare per la produzione di dispositivi tecnologici, inclusi i componenti delle auto ibride, del XX secolo, dopo che un’indagine federale degli anni ‘90 ha rivelato come siano stati sversati 2.300 litri di acque reflue radioattive. Questo rallentamento in Usa ha comportato che attualmente l’80% delle terre rare lavorate dalle imprese statunitensi è importata dalla Cina. Se la Cina chiudesse i rubinetti metterebbe in crisi interi settori industriali delle formazioni occidentali. Ad esempio a Bayan Obo, nella Mongolia interna, si trova il più grande giacimento finora mai scoperto. Bayan Obo fornisce il 45% della produzione globale di terre rare. Negli ultimi anni, nonostante le pressioni Usa, la produzione totale cinese è stata contenuta dal governo cinese sempre per questioni relative alla devastazione ambientale, attestandosi comunque nel 2018 al 70,6% della produzione totale globale10.
Le terre rare non si trovano in alte concentrazione e sono molto difficili da separare. Il processo per ottenerle è complesso e molto costoso dal punto di vista dell’ambiente. Allo scopo vengono usati abbondantemente solventi chimici, separazione magnetica e temperature attorno ai mille gradi. Secondo l’Associazione cinese per le terre rare, per ogni tonnellata di metalli estratti vengono rilasciati più di 10 mila metri cubi di gas di scarto contenenti alte concentrazioni di acido fluoridrico, anidride solforosa e acido solforico. Inoltre si producono 75 metri cubi di acque reflue acide e una tonnellata di rifiuti radioattivi.
Naturalmente la stessa attenzione per le devastazioni ambientali dovute all’estrazione delle terre rare, che hanno già determinato la resistenza contro l’apertura di nuovi siti di estrazione delle popolazioni oltre che in California anche in Spagna e in Serbia11, non è posta riguardo ai siti collocati nei paesi oppressi strettamente dominati dall’imperialismo come in Africa e in America Latina.
Inoltre la produzione di un’auto elettrica o ibrida comporta in fatto di emissioni di Co2 in atmosfera una quantità doppia rispetto a quella di un’auto a energie fossili e di conseguenza per cominciare a creare un vantaggio ambientale l’auto elettrica in questione deve fare più di 40 mila chilometri. Per ottenere il silicio puro per i pannelli solari bisogna fondere il quarzo ad altissime temperature e questo provoca una grande emissione di Co2, che è esattamente quello che si dice di voler evitare, poi il silicio deve essere trattato con idrogeno e acido muriatico e questo produce tetraclururo di silicio, una sostanza altamente tossica12. E questo solo per citare un paio di una serie innumerevole di esempi.
La cosiddetta svolta green è quindi tutt’altro che la soluzione dei problemi ambientali. La questione ambientale e la fake news della relativa riduzione delle emissioni complessive di Co2 è stata usata strumentalmente in particolare dalla borghesia imperialista Ue per legittimare ed imporre una riconversione tecnologica funzionale alla ricerca di un nuovo modello di accumulazione. Il vero obiettivo è quello di giocarsi con ciò un rilancio come polo imperialista in grado di sviluppare una propria egemonia basata sul primato tecnologico definito dalla svolta green. Una direzione che porta già, e porterà sempre di più, a devastazioni ambientali di nuovo tipo, ancora più gravi di quelle relative al modello di accumulazione caratterizzato dalla produzione di energia di origine fossile. Inoltre con le ripercussioni in campo energetico della guerra in Ucraina il Green deal europeo rischia di trasformarsi in un incubo per il drastico restringersi dei tempi in cui sarebbe vitale realizzare la riconversione, in una situazione in cui le contraddizioni interimperialiste trovano sbocco concreto nella guerra interimperialista.
Il movimento ambientalista che è sceso in piazza con le grandi manifestazioni degli ultimi anni in tutto il mondo dovrà fare i conti con la sua strumentalizzazione e in uno sviluppo futuro, si spera prossimo, cogliere l’antinomia che esiste tra capitalismo, avvitato in una spirale di crisi e distruzione fino alla guerra, e ambientalismo.
Ai comunisti spetta il compito di favorire questa comprensione, chiarire che “ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio”13 cioè che non ci potrà essere reale tutela dell’ambiente finché non si fuoriuscirà dal modo capitalistico di produrre.
Note:
1 Cfr. A. Piemontese, L. Zorloni, Gli accordi della Cop26 di Glasgow sul clima spiegati in 10 punti, 14.11.2021, wired.it
2 S. Secondino, Cop 26, che cosa è stato deciso alla conferenza, 15.11.2021 ansa.it
3 V. Castronovo, La svolta green della Ue guidata da Francia, Germania e Italia, Il Sole 24 Ore, 11/12/19
4 Esg sta per Environmental, Social e Governance. Il rating Esg (o rating di sostenibilità) esprime un giudizio sintetico che certifica la solidità di un emittente di azioni o obbligazioni, di un titolo o di un fondo finanziario dal punto di vista dell’impegno in ambito ambientale, sociale e di governance (impatto ambientale, diritti umani, parità di genere, ecc.). I rating Esg vengono elaborati da agenzie specializzate nell’analisi della sostenibilità dell’attività delle imprese. Nel concreto è una modalità che definisce uno standard per promuovere una finanza green.
5 cfr, G. Timpone, Un Etf perde il 91% degli asset in due giorni ed è un investitore “green”, 3.1.22, investireoggi.it
6 Crisi energetica, la chiave potrebbe essere il carbone indonesiano, it.sputniknews.com
7 H. Von Der Burchard, La Germania critica il piano di Bruxelles per etichettare il nucleare e il gas come verdi, 2.1.22, politico.eu
8 K. Marx, Il capitale, vol. 3, cap. 6, pag. 160-161, ed. Il sole 24 ore, Milano 2010
9 Cfr. M. Bottarelli, Nord Stream 2 addio? Pechino corteggia Mosca per il raddoppio del flusso di gas, 29.12.21, money.it
10 Cfr. Terre rare e inquinamento, euronews.com 19/08/2019
11 La mobilitazione della popolazione di Campo de Montil nella provincia spagnola di Ciudad Real ha impedito che la multinazionale Quantum Mineria ottenesse il permesso di aprire una miniera a cielo aperto. Lo stesso è accaduto nella zona occidentale della Serbia dove un analogo progetto della multinazionale Rio Tinto è stato abbandonato di fronte alla protesta popolare.
12 Cfr. S. Rossi e A. Di Crescenzo, L’ambientalismo senza anticapitalismo è giardinaggio, 18.7.20, lacittàfutura.it
13 Sintesi coniata dal compagno brasiliano Chico Mendes (1944-1988), sindacalista e militante ambientalista, ucciso dai latifondisti perché si opponeva alla devastazione dell’Amazzonia.




