Di chi è il “mare nostrum”?
La contesa interimperialista sul Mediterraneo
“Imperialismo e guerra” da Antitesi n.11 – pag.40
Da sempre al centro degli equilibri mondiali, il Mediterraneo continua ad essere uno degli scenari principali in cui si esplicitano contese tra potenze globali e regionali, per ritagliarsi la loro fetta di controllo sulle rispettive zone di interesse economico e di influenza politica. Sicuramente la crisi dell’imperialismo statunitense, descritta nell’articolo precedente, concede spazio ad altri attori e permette, in alcuni casi, alle potenze regionali di giocare un ruolo determinante nello scontro interimperialista.
È il caso della Turchia che, per garantirsi la sovranità sulle acque territoriali, ha riaperto lo scontro con la Grecia, obbligando Stati Uniti, paesi Ue, Cina e Russia ad intervenire per difendere i rispettivi interessi. Ankara non ha ancora ratificato la Convenzione Onu sul diritto del mare (Unclos) la quale prevede che le acque territoriali si estendessero sino a 6 miglia, con la possibilità per uno Stato costiero di estendere le proprie acque territoriali sino a 12 miglia. Se tale principio venisse applicato alle isole del Mar Egeo, questo diventerebbe un lago greco e il passaggio delle navi turche, così come gli accessi verso Cipro e Suez, sarebbero drasticamente limitati. Atene, da parte sua, ha visto in questo l’opportunità di diventare lo scalo per la commercializzazione del gas del Mediterraneo orientale, ma, per contendere tale posizione alla Turchia, ha dovuto creare un fronte antiturco con Cipro, Egitto e Israele, coinvolgendo anche l’Italia, l’Autorità palestinese e la Giordania, che hanno costituito l’East Mediterranean Gas Forum (Emgf).
L’Emfg, fondato nel gennaio 2019, è finalizzato a facilitare la creazione di un mercato del gas regionale nel Mediterraneo orientale. Si tratta del braccio operativo internazionale che permetterà agli Stati aderenti di ricavare il massimo beneficio economico dai giacimenti di gas esistenti e che saranno trasportati dal gasdotto Eastmed che mira a trasferire tra 9 e 12 miliardi di metri cubi all’anno di gas offshore da pompare tra Israele e Cipro verso la Grecia e poi verso l’Italia. Dell’Emgf, vista la presenza di Israele, non fa parte il Libano così come ha dichiarato lo scorso settembre il ministro uscente Raymond Ghajar dopo aver firmato l’accordo per ricevere gas egiziano attraverso la Giordania e la Siria. Tale consesso coinvolge tutti i paesi citati e condanna così la Turchia all’isolamento dai progetti energetici nell’area, in particolare riguardo lo sfruttamento di vasti giacimenti di gas tra Cipro, Libano, Israele ed Egitto, scoperti nel 2009.
Tra i paesi dell’Unione Europea la Francia, spinta dalla necessità di tutelare i propri interessi nelle partite energetiche dell’area e dall’urgenza di ostacolare la corsa turca verso il mare, si è esposta particolarmente prendendo le parti della Grecia e di Cipro, schierando in acque cipriote una squadra navale guidata dalla portaerei Charles de Gaulle e aderendo anch’essa all’Emfg.
La posizione dell’Italia risulta invece più ambigua. Da una parte, si posiziona come il secondo partner commerciale turco in ambito europeo e il quinto su scala mondiale, con un interscambio annuo pari a circa 18 miliardi di euro (gli investimenti sono principalmente rivolti al settore bancario, energetico, infrastrutturale e della difesa) ma dall’altra si schiera a favore dell’asse Parigi-Atene-Nicosia per avere la propria fetta di gas levantino. E ancora: da una parte si dimostra come uno dei maggiori sostenitori del dialogo tra Turchia e paesi dell’Unione europea ma dall’altra agisce militarmente in chiave antiturca, come dimostra l’impegno italiano nell’esercitazione aeronavale Eunomia 2020, svoltasi a fine agosto in cui hanno partecipato oltre anche Cipro, Francia e Grecia, oppure l’Iniziativa Quad sul Mediterraneo orientale, che vede gli stessi paesi lavorare ad un programma di cooperazione per tutelare la libertà di navigazione e incrementare l’interoperabilità tra le marine partecipanti. Le parole di Draghi su Erdogan come “dittatore di cui si ha bisogno” riassumono questa posizione ambigua: gli interessi economici del capitale italiano in Turchia sono forti, ma contemporaneamente vi è uno scontro rispetto al predominio sulle risorse energetiche.
Gli interessi in quest’area del Mediterraneo, inoltre, riguardano anche un altro gasdotto che vede coinvolti in prima linea anche l’Italia e tutti i paesi già citati: il Trans Adriatic Pipeline (Tap). Questo gasdotto, attraverso il punto di interconnessione di Kipoi, località al confine tra Grecia e Turchia, porta il gas in Europa. A circa nove mesi dalla messa in esercizio il gasdotto che interessa il litorale salentino ha raggiunto il livello di 5 miliardi di metri cubi di gas trasportato ed attualmente ha una capacità di 10 miliardi di metri cubi trasportati, che Tap Italia dice di poter raggiungere insieme al raddoppiamento della capacità stessa del gasdotto1.
La questione del gas nel Mediterraneo assume, quindi, sempre più un carattere centrale e interessa tutte le potenze che vedono ancora in questo mare un luogo strategico dove esprimersi politicamente, economicamente e militarmente. Gli Stati Uniti, per esempio, temendo la minaccia cinese così come quella russa, che esercita la sua influenza dal Nord Africa alla Mesopotamia, così come quella iraniana, tentano di rafforzare la propria presenza nel Mediterraneo anche militarmente. Ad oggi gli Stati Uniti posseggono o hanno accesso a basi militari in tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Escludendo Libano e Francia, essi sono presenti con delle basi militari a Rota in Spagna, a Sigonella, a Niscemi, a Napoli con la sede della VI° Flotta, in Italia, nella cretese Souda, a Incirlik e Kürecik, in Turchia, in Tunisia, a Cipro. Inoltre hanno altre istallazioni in località segrete del Marocco, Algeria, Libia e Israele, e mantengono una presenza in Egitto e in Siria.
Quando si parla di paesi mediterranei l’estensione geografica si amplia fino a comprendere la zona del Sahel e i paesi mediorientali che non hanno sbocco sul mare. Una nozione, quella di “Mediterraneo allargato”, che dimostra come l’interesse economico e politico delle potenze imperialiste si gioca sul mare nostrum come luogo di sbocco e di passaggio, ma arriva anche laddove ci siano risorse energetiche e territori da sfruttare, per mantenere in piedi un sistema economico che ha bisogno dello sfruttamento e dell’oppressione dei popoli per reggersi in piedi.
Vediamo, quindi, alcuni esempi in cui la contraddizione tra imperialismo e popoli oppressi viene meglio alla luce.
Nuovi conflitti in Maghreb
Nel novembre scorso, il dispiegamento di truppe marocchine nella zona cuscinetto di Guerguerat ha sancito la fine della tregua tra le Forze armate marocchine e l’Esercito di liberazione popolare saharawi, provocata dall’intervento di Trump che, sul finire del suo mandato, facendosi garante del rafforzamento delle relazioni tra Marocco e Israele (aderenti al cosiddetto patto di Abramo), aveva preannunciato l’impegno degli Stati Uniti nel riconoscere la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale.
Il Marocco ha investito notevolmente nell’acquisto di armamenti a tecnologia avanzata, la spesa militare è aumentata del 25% nel 2020 e ha subito solo un piccolo calo nel 2021 a causa della diffusione del Covid19, registrandosi a 4,6 miliardi di dollari. Tra gli acquisti vi sono anche i droni che per la prima volta sono stati usati lo scorso aprile a Tifariti, nella zona liberata del Sahara Occidentale uccidendo il capo della gendarmeria del Fronte Polisario2. La guerra è anche economica: sono circa trenta i paesi che investono nei territori occupati del Sahara e oltre il 70% delle aziende provengono da paesi dell’Unione Europea. Tra questi anche l’Italia è presente con diverse aziende tra cui Eni ed Enel, ma soprattutto la Spagna, che insieme alla Francia è il principale partner economico del Marocco e della sua politica di sfruttamento di risorse nei territori saharawi occupati.
Le relazioni tra Spagna e Marocco si sono incrinate quest’estate quando il governo spagnolo ha accusato il Marocco di allentare i controlli e permettere l’entrata in territorio spagnolo di migliaia di emigranti. Si è trattato in realtà di una ritorsione marocchina in risposta all’accoglienza nell’ospedale di Madrid di Ghali, il leader dei separatisti saharawi del Fronte Polisario, motivata dall’interesse spagnolo a normalizzare il conflitto.
Le mire del Marocco sul territorio del Sahara occidentale, poi, preoccupa da quest’estate in maniera più esplicita la confinante Algeria, a causa del sostegno marocchino dato al Movimento Separatista per l’Autonomia della Cabilia, regione a maggioranza berbera a est di Algeri. L’Algeria, inoltre, accusa il Marocco di utilizzare il software israeliano Pegasus per spiare funzionari e cittadini algerini e di essere coinvolto negli incendi che hanno colpito il nord del Paese e la Cabilia a inizio agosto, che sono costati la vita a 90 persone. Queste incomprensioni compromettono la cooperazione dei due paesi sul gasdotto Maghreb-Europa che collega i giacimenti algerini alla Spagna attraverso il Marocco. Il contratto scadrà il prossimo 31 ottobre e potrebbe non essere rinnovato, con la conseguenza che il gas arriverebbe in Spagna solo tramite il gasdotto Medgaz che collega direttamente l’Algeria alla Spagna.
Scontro di predoni in Libia
Uno dei fronti di scontro più rappresentativo del Mediterraneo è sicuramente quello in atto in Libia3 un paese che dal 2011, a partire dall’aggressione della Nato, si trova al centro degli interessi delle potenze globali e regionali, che in questi 10 anni sono intervenute per assicurarsi il controllo delle vie di trasporto e delle aree strategiche per l’estrazione delle risorse energetiche, petrolio e gas.
Tra le varie potenze un ruolo non indifferente lo gioca la borghesia imperialista italiana, che tenta di riaccreditarsi come uno dei partner principali candidandosi al processo di ricostruzione delle infrastrutture e dell’estrazione e lo sfruttamento delle risorse naturali. Tutti i paesi che intervengono in Libia sanno che affermarsi come il paese che più contribuirà alla ricostruzione delle infrastrutture libiche, oltre che uno scontato vantaggio economico, garantirà anche un’importante influenza politica nel paese che è ricco di petrolio e di altre risorse energetiche. Il 31 maggio, il ministero degli esteri italiano ha ospitato il primo business forum tra i due paesi che ha visto partecipare alcune tra le imprese italiane più importanti nel settore energetico (Ansaldo Energia, Saipem, Snam, Terna, Eni), militare e aereo-spaziale (Leonardo e Fincantieri), costruzioni (WeBuild, Psc Group), mezzi industriali (Cnh Industrial), telecomunicazioni (Italtel) e ospedaliero (gruppo San Donato). L’affare che si prospetta è ingente: il premier libico infatti ha chiesto l’aiuto italiano per ricostruire ospedali, scuole, strade e chiaramente le infrastrutture petrolifere, posto che la Libia vuole tornare ad estrarre 3-4 milioni di barili giornalieri. Questi grandi affari sono chiaramente subordinati al raggiungimento di una stabilità politica e per questo il governo italiano persegue il processo di unità libica sotto la guida del governo di Dbeibah, che dovrebbe condurre il paese alle elezioni a dicembre. Oltre a questo piano vi è quello del controllo dei flussi migratori, che consente all’imperialismo di legarsi alle fazioni borghesi locali e di allargare di fatto le sue frontiere marittime, con il protagonismo militare nel Mediterraneo. Su tale fronte, dal 2017, anno dell’accordo Italia-Libia, l’Italia ha speso un totale di 32,6 milioni di euro, considerando anche gli ultimi 500 mila euro stanzianti per la guardia costiera libica, mentre per le missioni navali la cifra arriva a 960 milioni, con un aumento di 17 milioni rispetto al 2020 per la missione Mare Sicuro e 15 milioni per la missione Irini. Tutto ciò mentre continua ad aumentare il numero di vittime della frontiera marittima mediterranea: 896 nei soli primi sei mesi del 2021. Secondo l’International organisation for migration il numero di immigrati libici che intendevano raggiungere l’Europa è raddoppiato da gennaio ad agosto 2021 e il numero di persone intercettate o soccorse in mare e riportate in Libia ha toccato quota 20.257.
Ovviamente la classe dominante italiana non è sola nel giocare le proprie carte politiche e militari rispetto ad un fenomeno così vasto come l’emigrazione dalle coste libiche. La prerogativa di bloccare o meno i flussi migratori viene usata come strumento di ricatto dalle autorità libiche nei confronti dei paesi Ue. Da ottobre 2020, la Turchia ha dato il via al programma di addestramento della Guardia costiera libica, su motovedette italiane, e questo accresce la sua posizione sulle coste libiche e le fornisce un ulteriore potere contrattuale nei confronti dell’Italia e dell’Ue.
Questa intesa tra Turchia e Libia si inserisce nel rapporto stretto tra il regime di Erdogan e le fazioni borghesi libiche di Tripoli, vicine alla Fratellanza Mussulmana, contrapposte, nella guerra civile successiva all’intervento Nato, alle fazioni della Tripolitania. L’anno scorso, l’intervento militare turco, con soldati e mercenari, a sostegno del governo di Tripoli assediato dalle forze del generale Haftar, ha permesso di fatto un ribaltamento dei rapporti di forza sul campo. Grazie a questo protagonismo politico e militare, la Turchia ha ottenuto il rinnovo del memorandum d’intesa siglato nel 2019 riguardante la demarcazione dei confini marittimi nel Mediterraneo, per il riconoscimento delle Zone economiche esclusive (Zee) dei due paesi, cinque protocolli di intesa e diversi accordi di cooperazione reciproca in vari settori economici, soprattutto progetti infrastrutturali ed energetici. L’accordo sulle Zee, in particolare, si inserisce nello scontro sul controllo del Mediterraneo orientale di cui si diceva poc’anzi: attraverso tale intesa la Turchia vuole ostacolare il fronte dell’Emgf e la stessa costruzione del gasdotto Eastmed.
Nel frattempo il 15 agosto il Comitato militare congiunto 5+5, l’organismo formato a seguito della Conferenza di Berlino del gennaio 2020 e che include i delegati di entrambi le parti che si sono combattute negli ultimi anni, l’esercito legato al Governo di accordo nazionale e l’Esercito nazionale libico guidato da Haftar, ha ribadito la necessità di allontanamento dei combattenti e mercenari stranieri, lo scambio di detenuti e la nomina di un ministro della difesa. Ma le incognite sulla stabilizzazione interna sono molte, anche in relazione agli appetiti esterni delle diverse potenze.
La crisi libanese
Altro fronte di tensione nel Mediterraneo è rappresentato dal Libano, ancora in piena crisi politica ed economica: ad un anno dall’esplosione del porto di Beirut si è al terzo tentativo di formazione del governo e dopo lo scontro tra Hariri con il presidente Michel Aoun, a fine luglio l’incarico è stato affidato al sunnita Najib Mikati. Il suo incarico ha ricevuto il sostegno dei parlamentari sunniti del Blocco del futuro, quello dei deputati sciiti di Hezbollah mentre non ha ricevuto l’appoggio del Movimento Patriottico Libero, il blocco cristiano del parlamento. Non ha sicuramente ricevuto l’appoggio della popolazione che ha manifestato il suo dissenso il giorno stesso del suo insediamento. All’uomo più ricco del Libano, coinvolto in una serie di inchieste per appropriazione indebita e abuso di potere, quindi, sono state affidate le sorti del paese la cui situazione economica è profondamente peggiorata negli ultimi mesi. I dati forniti dall’Onu erano già allarmanti, il tasso di povertà è salito nel 2020 al 55%, la lira libanese negli ultimi due anni è crollata di oltre il 90%, determinando il fatto che la percentuale di libanesi che vivono in condizioni di povertà estrema sia passata dall’8% al 23%.
Tale situazione è la sintesi di diversi fattori. Fondamentalmente è causata dalla crisi generale del capitalismo, che si aggrava in determinate formazioni sociali particolarmente deboli ed esposte, come quella libanese. Principalmente però a pesare sono le dinamiche di guerra economica, politica e militare nell’area mediorientale, essendo il Libano attraversato direttamente e indirettamente da tutti i conflitti regionali: quello tra Usa e Israele contro l’Iran, quello tra Resistenza Palestinese e Israele, quello in corso in Siria. A causa delle continue minacce e provocazioni sioniste, la frontiera meridionale con Israele è di fatto un confine di guerra, ove è schierato il contingente militare Unifil, formalmente di interposizione, attualmente a comando italiano.
Infine, vi è la paralisi della vita politica interna, con un regime fondato sul confessionalismo. Il principio che ne sta alla base è che le comunità confessionali presenti nel paese devono avere la garanzia di essere rappresentate negli apparati istituzionali, amministrativi e militari dello stato. Le principali religioni monoteiste sono quindi rappresentate anche nelle loro divisioni interne: i cristiani si dividono in maroniti, greco-ortodossi e greco-cattolici, i musulmani in sunniti, sciiti e drusi. Tutto ciò ha generato un sistema di borghesia clientelare, mafiosa e settaria, in continua lotta per la spartizione dei gangli di potere economico e politico.
In questi mesi, poi, la situazione è ulteriormente peggiorata con la carenza di carburante, accelerata con il sequestro da parte dell’esercito israeliano di milioni di litri di gasolio e diesel, che ha portato a un drastico razionamento dell’elettricità, all’aumento dei prezzi di beni di prima necessità, inclusi i medicinali, alla chiusura di ristoranti e bar, e ha lasciato gli ospedali in situazioni allarmanti. A tutto ciò, l’11 agosto si è aggiunta la decisione della Banca centrale di revocare i sussidi sulle importazioni di carburante e di passare ai tassi di mercato, a causa dell’esaurimento delle risorse monetarie in dollari. Contro questa misura vi è stata l’opposizione del governo libanese che non ha modificato i prezzi di vendita ufficiali causando il prosciugamento di tutte le forniture del paese. Le stazioni di servizio sono state obbligate a vendere le proprie scorte al vecchio prezzo fissato l’11 luglio 2021 ma tale misura non è stata rispettata e così il 23 agosto ancora una volta migliaia di persone sono scese in strada e numerose situazioni di tensione si sono create in diverse parti del paese. Collegati a questa crisi sono i diversi incidenti che si sono verificati in diverse parti del paese che ancora una volta ricadono sulla popolazione provocando morti e feriti come è accaduto con l’esplosione di un’autocisterna di carburante il 15 agosto nel Nord del Libano. L’unico concreto aiuto alla popolazione in questa fase, come riferito da Hezbollah, arriva dall’Iran con una serie di navi cariche di carburante.
Ancora Resistenza in Palestina
Da settanta anni Israele e i suoi alleati occidentali, in prima fila Usa e i paesi dell’Unione Europea, provano a imporre il loro controllo sul territorio palestinese ma la Resistenza del popolo palestinese riesce a tener testa agli occupanti, come è accaduto anche questo maggio. La decisione del governo israeliano, il 6 maggio scorso, di sfrattare 7 famiglie palestinesi dal quartiere di Sheirkh Jarrah a Gerusalemme est e il giorno successivo gli abusi della polizia israeliana durante il primo giorno di Ramadan alla moschea di al-Aqsā, sono stati i detonatori di una serie di scontri nei territori occupati e dei bombardamenti a Gaza, ma anche della risposta palestinese, con incessanti lanci di missili sulla colonia israeliana, terminati con il cessate il fuoco accordato tra Hamas e Israele il 21 giugno. Durante questo mese l’appoggio alla lotta per la liberazione della Palestina ha avuto il sostengo di settori di massa in tanti paesi mentre, come era prevedibile, mentre le classi dominanti reazionarie si sono schierate dalla parte di Israele.
Del resto per i paesi dell’Unione Europea sarebbe impossibile negare l’appoggio ad Israele posto che le alleanze economiche, nell’ambito della ricerca4 e soprattutto in ambito militare sono strettissime. A luglio, per esempio, l’aeronautica militare italiana si è recata in Israele per due settimane di addestramento insieme alle forze aeree di Usa, Francia, Germania e Regno Unito. L’operazione di addestramento all’utilizzo di droni killer “Blue Guardian” segue un altro appuntamento, “Falcon Strike 21”, un’esercitazione che vede le forze navali e aeree dei paesi già citati incontrarsi in territorio italiano (poligoni della Sardegna, mar Tirreno, il sud Italia, l’isola di Pantelleria, il mare Ionio e il Mediterraneo centrale) per provare i cacciabombardieri a capacità nucleare di quinta generazione prodotti da Lockheed Martin e i droni lanciamissili di Elbit System Ltd, ovvero i nuovi strumenti di morte che useranno contro le popolazioni dell’Africa e del Medio Oriente.
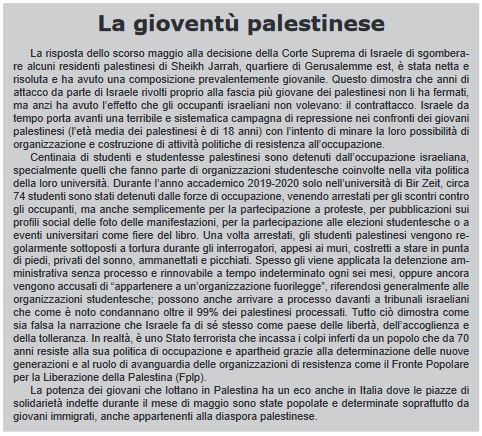
Il golfo di Guinea
Nell’ottica dell’allargamento del Mediterraneo, a cui facevamo riferimento all’inizio dell’articolo, una posizione centrale ricopre il Golfo di Guinea, luogo privilegiato per quanto riguarda il settore energetico dato che ospita due tra i maggiori esportatori di petrolio africano: la Nigeria con una media di 2 milioni di barili al giorno e l’Angola con 1,5 milioni di barili al giorno; nel complesso, l’output regionale costituisce il 13% dell’import di greggio e il 6% dell’import di gas dell’Europa. Nell’area, quindi, si riversano gli interessi di Total, Exxon Mobil, Shell, Eni e China National Petroleum Corporation. Per quanto riguarda l’Italia, il 18% di petrolio viene importato dall’Africa, quasi la metà di questo transita nel Golfo di Guinea (in particolare: Nigeria 2,5%, Angola 1,4% e Camerun 1%) e un terzo del volume di scambio tra Italia e Africa interessa i paesi della regione. Oltre al petrolio, l’Italia è interessata anche al mercato ittico del Golfo, e già nel 2018 importava il 13% degli stock di tonno e palamita dalla Costa d’Avorio e dal Ghana. A supporto di questi interessi economici la Marina italiana è presente con molte operazioni di controllo contro la pirateria per la salvaguardia dei pozzi petroliferi dell’Eni e dei mercantili delle grandi compagnie armatoriali in modo da garantire all’holding energetica a capitale statale e ai gruppi privati di continuare ad investire nell’area, in particolare nelle acque prospicienti la Nigeria. Le operazioni chiamate Operazione Gabinia sono già alla loro terza fase iniziata il 23 febbraio 2021 e vedono una stretta collaborazione con le forze navali statunitensi.
Con i popoli che resistono
Questi pochi esempi che abbiamo illustrato mostrano la strategia che i paesi imperialisti mettono in campo per sopravvivere, con un sistema cangiante di alleanze che rimarca come la tendenza alla guerra sia per loro l’unica via percorribile per mantenere in vita un sistema capitalista in crisi.
L’internazionalismo si esprime concretamente nella solidarietà ai popoli che subiscono e combattono l’oppressione imperialista, come nel caso della lotta del popolo palestinese. È stato necessario essere nelle piazze di maggio, per portare la solidarietà alla Resistenza Palestinese, che tanti giovani, sopratutto di origine immigrata, hanno riempito, dimostrando come la contraddizione tra imperialismo e popoli oppressi sia chiara, continuando ad essere sentita anche dalle generazioni che sono nate e cresciute lontane dai territori in cui materialmente si fa la guerra.
Internazionalismo significa concretamente opporsi ai luoghi e agli strumenti di guerra imperialista presenti nel nostro paese, come Sigonella e il Muos. In questo senso è stata fondamentale la partecipazione di molte compagne e compagni all’appuntamento di agosto a Niscemi per ribadire la necessità dello smantellamento del Muos e per denunciare la tendenza alla guerra imperialista sempre più grave.
Inoltre, la contraddizione tra imperialismo e popoli oppressi si salda in Europa con la contraddizione capitale-lavoro come dimostra il crescente protagonismo del proletariato immigrato che in maniera combattiva si inserisce nelle lotte economiche per il miglioramento delle condizioni di lavoro: lo abbiamo visto a Piacenza o a Prato dove a condurre le lotte sono stati principalmente lavoratori immigrati. Il nostro compito allora è quello di generalizzare la lotta tenendo insieme il piano economico, politico e ideologico e costruendo nuovi quadri militanti anche a partire dalla pratica dell’internazionalismo e dell’antimperialismo.
1 Domenico Palmiotti, Il gasdotto Tap taglia il traguardo dei primi 5 miliardi di metri cubi trasportati, 18 settembre 2021, ilsole24ore.com
2 Il Fronte Polisario è un movimento di liberazione nazionale che ha dichiarato la sua indipendenza dal Marocco nel 1976 fondando la Repubblica Araba Sawhrawi Democratica. Il governo attualmente in esilio nel campo profughi di Tindofou (Algeria) è riconosciuto da 83 paesi
3 Vedi Pandemia, crisi e guerra, Antitesi n. 9, pp. 44-45 e I predoni del deserto, Antitesi n°0 p. 46 ss
4 L’alleanza tra le università italiane e Israele dal 2014 ha trovato un nuovo e produttivo sbocco nel progetto europeo Horizon 2020 che prevede la partecipazione di Israele a ben 1216 progetti per un totale di 872 milioni di euro nell’ambito della ricerca per scopi duali, civili e bellici.
La gioventù palestinese
La risposta dello scorso maggio alla decisione della Corte Suprema di Israele di sgomberare alcuni residenti palestinesi di Sheikh Jarrah, quartiere di Gerusalemme est, è stata netta e risoluta e ha avuto una composizione prevalentemente giovanile. Questo dimostra che anni di attacco da parte di Israele rivolti proprio alla fascia più giovane dei palestinesi non li ha fermati, ma anzi ha avuto l’effetto che gli occupanti israeliani non volevano: il contrattacco. Israele da tempo porta avanti una terribile e sistematica campagna di repressione nei confronti dei giovani palestinesi (l’età media dei palestinesi è di 18 anni) con l’intento di minare la loro possibilità di organizzazione e costruzione di attività politiche di resistenza all’occupazione.
Centinaia di studenti e studentesse palestinesi sono detenuti dall’occupazione israeliana, specialmente quelli che fanno parte di organizzazioni studentesche coinvolte nella vita politica della loro università. Durante l’anno accademico 2019-2020 solo nell’università di Bir Zeit, circa 74 studenti sono stati detenuti dalle forze di occupazione, venendo arrestati per gli scontri contro gli occupanti, ma anche semplicemente per la partecipazione a proteste, per pubblicazioni sui profili social delle foto delle manifestazioni, per la partecipazione alle elezioni studentesche o a eventi universitari come fiere del libro. Una volta arrestati, gli studenti palestinesi vengono regolarmente sottoposti a tortura durante gli interrogatori, appesi ai muri, costretti a stare in punta di piedi, privati del sonno, ammanettati e picchiati. Spesso gli viene applicata la detenzione amministrativa senza processo e rinnovabile a tempo indeterminato ogni sei mesi, oppure ancora vengono accusati di “appartenere a un’organizzazione fuorilegge”, riferendosi generalmente alle organizzazioni studentesche; possono anche arrivare a processo davanti a tribunali israeliani che come è noto condannano oltre il 99% dei palestinesi processati. Tutto ciò dimostra come sia falsa la narrazione che Israele fa di sé stesso come paese delle libertà, dell’accoglienza e della tolleranza. In realtà, è uno Stato terrorista che incassa i colpi inferti da un popolo che da 70 anni resiste alla sua politica di occupazione e apartheid grazie alla determinazione delle nuove generazioni e al ruolo di avanguardia delle organizzazioni di resistenza come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (Fplp).
La potenza dei giovani che lottano in Palestina ha un eco anche in Italia dove le piazze di solidarietà indette durante il mese di maggio sono state popolate e determinate soprattutto da giovani immigrati, anche appartenenti alla diaspora palestinese.




