Essere comunisti
Dalla concezione del mondo alla linea di massa
“Ideologia borghese e teoria del proletariato” da Antitesi n.11 – pag.69
Continuiamo a dare in questa sezione della rivista il nostro modesto contributo rivolto a chi è alla ricerca di una strada per lo sviluppo di un’opzione rivoluzionaria, in questa situazione di aggravamento della crisi generale del sistema in cui viviamo. Cerchiamo di farlo rinsaldando il legame con la nostra storia, riannodando i fili lacerati dal revisionismo, per trarre alcuni insegnamenti dall’elaborazione teorica del movimento comunista internazionale e, per questo, attingeremo abbondantemente alla fonte. Insegnamenti che ci siano utili per dare una corretta impostazione al lavoro che dobbiamo fare ora, con la consapevolezza che c’è un grande ritardo da colmare rispetto a quanto va evidenziando il concreto sviluppo della situazione oggettiva, che caratterizza le formazioni sociali del capitalismo “avanzato” come la nostra.
Nel contesto dell’avvitamento della crisi di sovraccumulazione di capitali, che attanaglia soprattutto il sistema economico delle formazioni imperialiste occidentali (Usa, Ue, Giappone) ed è aggravata dalla pandemia, la borghesia imperialista cerca la via che permetta di utilizzare tale crisi come trampolino di lancio per un nuovo ciclo di accumulazione. È la via di un’ulteriore grande incremento della finanziarizzazione dell’economia, perseguito per foraggiare il salto tecnologico e l’aumento della composizione organica del capitale investito produttivamente (come nel caso del piano “industria 4.0”)1, attraverso i grandi indebitamenti pandemici, con una proiezione che va dalla green economy all’aereospazio, perseguendo così l’obiettivo di ricreare grandi margini di profitto.
Un aumento della composizione organica che incrementa il plusvalore relativo e il sovrapprofitto, ma che ricrea le condizioni per un prossimo aggravamento della crisi di sovraccumulazione nella misura in cui i concorrenti monopolisti si mettano al pari o addirittura sopravanzino nel salto tecnologico. Per questo, in tali dinamiche oggettive, si trova la radice profonda della tendenza alla guerra nella fase imperialista del capitalismo.
Un processo che nell’immediato si traduce in ristrutturazione dispiegata dell’apparato produttivo con chiusure e licenziamenti di massa. Oltre alle chiusure dovute alla crisi, si avvia la fase delle chiusure dovute alla ristrutturazione. Una fase in cui la classe operaia è oggetto di un attacco a fondo e vede la sua composizione nuovamente scomposta.
Concezione e movimento reale
Ma questa crisi del sistema è anche un momento in cui le masse sono costrette a riflettere sulla loro condizione, in cui l’egemonia delle classi dominanti scricchiola, in cui si evidenzia la fragilità del modo capitalistico di produrre e la sua incapacità di ampliare i margini della riproduzione sociale, diventati incompatibili con la ricerca di più ampi margini di profitto. Le condizioni materiali e culturali della società peggiorano. In questa situazione la classe e le masse sono spinte a difendersi sviluppando un movimento di resistenza, ma anche a darsi una spiegazione di quello che succede a partire dai propri interessi materiali, che diventano sempre più stringenti. Sono masse più ricettive nei confronti di concezioni del mondo alternative, in un quadro in cui le tradizionali concezioni del mondo borghesi sono sempre meno capaci di giustificarsi nel loro coprire ideologicamente la ricerca del profitto ad ogni costo. Ricerca che sta alla base della precarietà e dello sfruttamento sempre più selvaggio che caratterizzano la condizione proletaria, com’è anche alla base della distruzione ambientale del pianeta e della tendenza alla guerra imperialista.
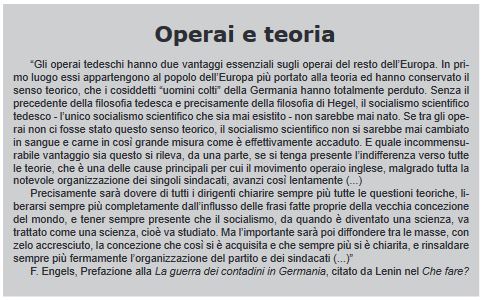
Il materialismo dialettico e la sua linea politica, il comunismo, è la concezione ideologica che meglio consente alla classe operaia e al proletariato di comprendere questa propria condizione destabilizzata. È la concezione in dialettica e più vicina agli interessi materiali della classe, l’unica teoria che oggi può giustificare realmente la resistenza della classe nella crisi del capitalismo e darle la possibilità di interpretare un ruolo storico positivo.
Per questo essa può essere più facilmente abbracciabile da parte proletaria in questa situazione, cioè quando la crisi destabilizza oltre che il quadro economico anche il quadro sociale e culturale dato, come sta accadendo di questi tempi.
Ma cosa è il comunismo?: “Il comunismo per noi non è uno stato di cose che debba essere instaurato, un ideale al quale la realtà dovrà conformarsi. Chiamiamo comunismo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente. Le condizioni di questo movimento risultano dal presupposto ora esistente”2. Non si tratta cioè semplicemente di una concezione del mondo confinata nella sfera delle idee, ma di un movimento reale che si sviluppa sulla base dei presupposti sociali storicamente determinati.
Considerare il comunismo solo una concezione apre la strada al dogmatismo, le idee si scindono dalla pratica sociale e politica, i principi prendono il sopravvento sugli obiettivi concretamente perseguibili. Posizioni di questo tipo nel campo politico si crogiolano nel tenere alta la bandiera coltivando il proprio auto isolamento e, in quello organizzativo, facilmente degenerano nel burocratismo, che è la strada maestra al revisionismo.
Però come dice Lenin “senza teoria rivoluzionaria non vi può essere movimento rivoluzionario”3. La resistenza della classe operaia per sviluppare un movimento rivoluzionario deve dotarsi di una teoria rivoluzionaria e lo può fare se la sua avanguardia si attrezza non solo per la lotta economica e politica, ma anche per quella ideologica, come indica chiaramente Engels4.
Quindi il comunismo è entrambe la cose: è sia concezione del mondo che movimento reale. È distinzione e unità dialettica tra i due aspetti. Le sue forme concrete, storicamente rilevanti, che si sono manifestate in movimenti rivoluzionari anche vittoriosi, sono una sintesi di questi due aspetti.
I comunisti devono perciò anche oggi percorrere questa dialettica, sviluppare la lotta teorico-ideologica in relazione concreta con lo sviluppo del movimento reale di resistenza della classe che si determina nel corso della crisi del capitalismo. Devono elaborare una concezione scientifica della dinamica della crisi del capitalismo, per porla al servizio dell’obiettivo della formazione del proletariato in classe autonoma, del rovesciamento del sistema borghese e della conquista del potere politico5.
Dobbiamo e possiamo farlo appropriandoci degli insegnamenti che derivano dallo studio del marxismo-leninismo-maoismo e dalle esperienze del movimento comunista internazionale, rielaborati alla luce della situazione attuale di crisi del sistema. Accompagnando l’esperienza di resistenza delle masse con una teoria che la giustifichi e la rafforzi strategicamente in un processo che avvii l’accumulazione politica e organizzativa di forze rivoluzionarie.
Per operare in questo modo i comunisti devono essere organizzati. Devono costituirsi in soggetto politico allo stesso tempo distinto e unito alla classe e alle masse. Questa condizione dialettica è posta chiaramente da Lenin nella sua produzione teorica (in particolare nel Che fare?) e trova una precisa espressione nel dibattito sullo statuto del partito che caratterizzò il secondo congresso del Partito Operaio Socialdemocratico Russo (Posdr) nel 19036.
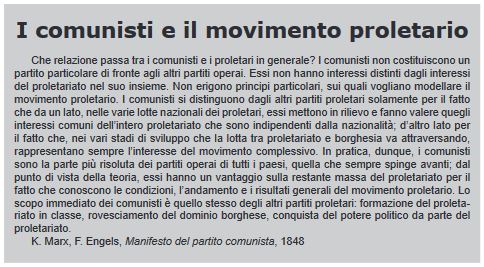
L’idea leninista che definiva la posizione bolscevica in quella occasione era che “il partito, come reparto di avanguardia della classe, costituisca qualcosa che sia organizzato al massimo, che il partito accetti nel suo seno soltanto quegli elementi che ammettano almeno un minimo di organizzazione”7. Era un’idea che si contrapponeva alla posizione menscevica che difendeva un’organizzazione di partito amorfa e indistinta. Posizione, quella dei menscevichi, che era apertamente ostile all’idea dell’edificazione del partito “dall’alto in basso” e incarnava la tendenza ad andare “dal basso in alto”, dando in particolare la possibilità a chiunque di essere considerato membro del partito, senza esigerne l’appartenenza ad una delle organizzazioni ad esso appartenenti.
Una “piccola” divergenza che ha una grande importanza per l’impostazione del lavoro dei comunisti. Infatti, se “il partito è l’interprete cosciente di un processo incosciente” non si può dimenticare “la differenza che esiste tra il reparto di avanguardia e tutte le masse che gravitano verso di esso”8. Il piano di lavoro dei comunisti per essere veramente cosciente “deve saper creare legami organizzativi che assicurino un certo grado di coscienza e lo elevino sistematicamente”9.
Ne deriva che il processo di impostazione e di sviluppo del lavoro dei comunisti è anche un processo di distinzione e di lotta contro le concezioni orizzontaliste e “dal basso verso l’alto” (che sono il “prodotto naturale e necessario della mentalità dell’individualista anarchico”10) e le posizioni opportuniste caratterizzate dal cosiddetto codismo organizzativo “che difende e giustifica sempre ogni arretratezza: programmatica, tattica e organizzativa”11.
Questo per affermare che i comunisti non possono essere semplici aderenti di un programma di emancipazione, ma devono essere tutti dirigenti nell’ambito del lavoro rivoluzionario.
Teoria e pratica
Elevare sistematicamente il proprio livello di coscienza sulle contraddizioni che portano il capitalismo alla crisi e sviluppare la comprensione concreta del processo storico che si determina è quindi il compito fondamentale di comunisti. Ma questa non può essere cosa fine a se stessa, né nei presupposti e né nei risultati. La teoria deve essere costruita “su una determinata pratica” in modo che “coincidendo e identificandosi con gli elementi decisivi della pratica stessa, acceleri il processo storico in atto”12.
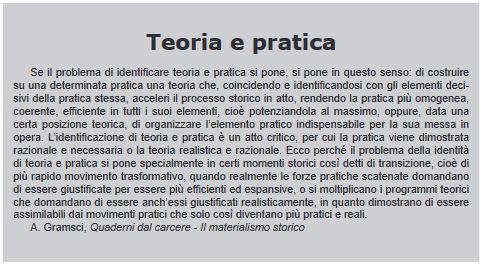
Il rapporto tra teoria e pratica, tra concezione del mondo e movimento reale che distrugge e supera lo stato presente della cose, è un contenuto essenziale del lavoro dei comunisti, il quale diventa particolarmente stringente “in certi momenti storici così detti di transizione” come quello attuale. Sono periodi in cui il radicalizzarsi delle contraddizioni scatena forze pratiche, lotte e movimenti di massa, che “domandano di essere giustificate”, cioè di essere comprese e valorizzate teoricamente, per procedere più efficacemente nel loro sviluppo. E i programmi teorici stessi verificano la loro correttezza “dimostrando di essere assimilabili dai movimenti pratici che solo così diventano più pratici e reali”.
La concezione filosofica marxista (materialismo dialettico) chiarisce “che la teoria dipende dalla pratica, che la teoria si basa sulla pratica e a sua volta serve la pratica”13. Il criterio della verità è la pratica sociale. La verifica della correttezza di una teoria può essere data solamente dalla sua corrispondenza con le leggi di sviluppo del mondo oggettivo e in particolare dalla sua sintonia con lo sviluppo concreto della pratica sociale14.
Una teoria che non si applica nella pratica non serve a nulla. Per questo il marxismo non può essere un dogma, ma deve essere una guida per l’azione. “La teoria diventa priva di oggetto se non viene collegata con la pratica rivoluzionaria, esattamente allo stesso modo che la pratica diventa cieca se non si rischiara la strada con la teoria rivoluzionaria”15.
Tutte le deviazioni ideologiche manifestatesi nella storia del movimento comunista internazionale e che, sia esplicitamente che sottotraccia, sono presenti tutt’ora nelle determinazioni della classe in conseguenza dell’influenza ideologica esercitata della borghesia, siano esse caratterizzate dall’idealismo o dal materialismo meccanicista, dall’opportunismo o dall’avventurismo, provengono dal distacco della conoscenza teorica dalla pratica rivoluzionaria.
In lotta contro queste deviazioni, e con la consapevolezza che le idee giuste si affermano combattendo quelle sbagliate, i comunisti devono perseguire “l’unità storica concreta del soggettivo con l’oggettivo, della teoria con la pratica, del sapere e del fare”16. Possono farlo applicando linee politiche che discendano dalla teoria per orientare la pratica al raggiungimento di obiettivi determinati, sia sul piano tattico che su quello strategico.
Però avere una linea giusta non basta. “Avere una linea politica giusta è naturalmente la prima cosa, la più importante. Ma ciò è pure sempre insufficiente. Una giusta linea politica non deve servire per fare una dichiarazione, ma per essere applicata. E, per applicare una giusta linea politica, occorrono dei quadri, occorrono degli uomini che comprendano la linea politica del Partito, che l’accettino come la loro propria linea, che siano pronti a realizzarla, che sappiano metterla in pratica, che siano capaci di risponderne, di difenderla, di lottare per essa. Senza di ciò, la linea politica giusta rischia di restare sulla carta”17.
Linea di massa
Concezione del mondo, teoria rivoluzionaria, pratica rivoluzionaria e linea politica rimandano quindi al problema del quadro, dei comunisti e dei loro compiti.
Ma di che comunisti si tratta? Di comunisti organizzati in partito che si pongono come il reparto avanzato nella lotta della classe per la conquista del potere. Conquista questa necessaria per perseguire gli interessi strategici della classe, che in definitiva consistono nell’abolizione del lavoro salariato tramite l’instaurazione della dittatura del proletariato, fino alla costruzione di una società senza classi. Questo essere reparto avanzato non può che svilupparsi e strutturarsi in particolare nel lavoro tra le masse, un lavoro finalizzato alla lotta contro il nemico di classe.
A quale scopo e con quali compiti i comunisti lavorano tra le masse? La questione fondamentale da risolvere è la sconfitta del regime borghese. Questo è l’obiettivo strategico da perseguire tenendo presente la condizione, più volte storicamente verificata, che “con la sola avanguardia non si può vincere”18.
Conquistare l’avanguardia cosciente del proletariato alla causa della rivoluzione e del comunismo è il primo compito, è un fattore essenziale, “Senza di esso non si può compiere neanche il primo passo verso la vittoria”19. E questo primo compito non può essere assolto “senza una completa vittoria ideale e politica sull’opportunismo”20.
Tuttavia va ribadito (anche alla luce delle esperienze rivoluzionarie degli anni ‘70) che “con la sola avanguardia non si può vincere. Gettare la sola avanguardia nella battaglia decisiva, prima che tutta la classe, prima che le grandi masse abbiano preso una posizione o di appoggio diretto all’avanguardia o, perlomeno, di benevola neutralità nei suoi riguardi e di completa incapacità di appoggiare i suoi avversari, non sarebbe soltanto una sciocchezza, ma anche un delitto”21. Ma perché le grandi masse “giungano a prendere tale posizione la sola propaganda e la sola agitazione non basta. Per questo è necessaria l’esperienza politica delle masse stesse. Tale è la legge fondamentale di tutte le grandi rivoluzioni”22. Per questo il secondo compito dei comunisti sta “nel saper guidare non soltanto il proprio partito, ma anche queste masse durante il loro avvicinamento, durante il loro passaggio alla nuova posizione”23.
Lo sviluppo della relazione dei comunisti con le masse è quindi fondamentale per il conseguimento dell’obiettivo strategico. In questo campo, l’idea sbagliata da sconfiggere è che basti lanciare appelli generali alle masse, contando sul loro slancio, affinché il movimento si organizzi e si sviluppi (cosa che ad esempio si manifesta oggi con il ripetersi di appelli allo sciopero generale da parte di piccoli gruppi sindacali). È un’idea che contraddistingue l’opportunismo nel campo organizzativo, opportunismo che magari si copre con il massimalismo delle posizioni e la radicalità di tipo soggettivista. È un’idea sbagliata che, a fronte degli inevitabili insuccessi, non tarda scaricarne la responsabilità sulle masse apatiche e incapaci di prendere in mano il loro destino. In realtà il mancato successo riguarda i comunisti e l’inadeguatezza del loro lavoro rispetto alla situazione che le masse vivono. I comunisti devono organizzarsi loro per riuscire a sviluppare un rapporto concreto con le masse, sulla base dell’inchiesta, per poter indicare parole d’ordine adeguate a raccogliere le tensioni delle masse e a incanalarle nell’alveo della rivoluzione proletaria, individuando e generalizzando le forme di lotta praticabili, cioè quelle che scaturiscono realmente nello scontro tra le classi (non c’è niente da inventare), e promuovendo le forme organizzative necessarie al loro sviluppo24.
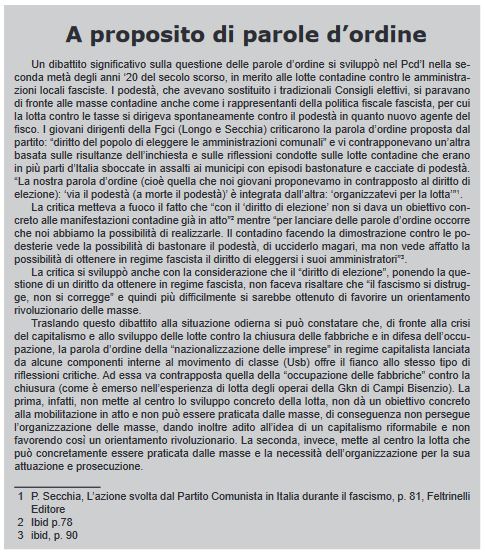
Con quale metodo i comunisti lavorano tra le masse? La più completa sistematizzazione su questo terreno è stata realizzata nell’ambito dell’esperienza rivoluzionaria dei comunisti cinesi, elaborata da Mao Tse Tung. Innanzi tutto, contro la concezione di chi contrappone il lavoro tra le masse al lavoro di partito, bisogna chiarire che l’impostazione data è quella del processo “dall’alto”. Qui quella che è stata definita “linea di massa” è inquadrata tra i metodi di direzione, non si tratta di quello che i comunisti devono dire alle masse, ma di come i comunisti, a partire dal loro organizzarsi come reparto avanzato della classe, impostano e sviluppano il lavoro tra le masse, come parte fondante del loro lavoro complessivo.
La linea di massa maoista è quindi un metodo di direzione. “In tutto il lavoro pratico del nostro partito, una direzione giusta deve fondarsi sul seguente principio: dalle masse alle masse”25. La messa a fuoco di come i comunisti lavorino tra le masse discende da un principio generale (dalle masse alle masse) che caratterizza il lavoro di partito. È un principio che si fonda sul materialismo dialettico e in particolare sulla considerazione che le idee giuste “provengono dalla pratica sociale e solo da questa. Provengono da tre tipi di pratica sociale: la lotta per la produzione, la lotta di classe e la sperimentazione scientifica”26.
La direttiva generale è che “bisogna raccogliere le idee delle masse (frammentarie, non sistematiche), sintetizzarle (attraverso lo studio trasformarle in idee generalizzate e sistematiche), quindi portarle di nuovo alle masse, diffonderle e spiegare queste idee finché le masse non le assimilano, vi aderiscono fermamente e le traducono in azione e verificare in tale azione la giustezza delle idee”27.
Si tratta di un processo che ha come passaggi: 1) l’inchiesta sulla condizione delle masse, 2) la proposta-appello per la lotta e l’organizzazione come risultato dell’elaborazione dell’inchiesta, 3) la direzione e lo sviluppo dell’azione concreta, 4) il bilancio-verifica della correttezza della proposta-appello sulla base dei risultati ottenuti. Questo per realizzare una nuova sintesi delle idee da riportare nuovamente alle masse ripetendo il processo “ininterrottamente, come una spirale senza fine”28.
L’aspetto fondamentale è legare la direzione alle masse: la direzione può formulare idee giuste solo raccogliendo le idee delle masse, rielaborandole per poi riportarle alle masse. Però, affinchè il processo abbia uno sviluppo, occorre legare la proposta-appello a una direzione particolare e specifica. Chi lancia l’appello deve occuparsi “in modo concreto e approfondito” dell’esecuzione del lavoro per il quale ha lanciato l’appello, diversamente non avrà la possibilità di verificarne la giustezza e di migliorarlo per procedere in uno sviluppo allargato.
Anche questa direzione particolare e concreta deve attingere alle masse, deve basarsi sull’appoggio e sviluppo della tendenza positiva (di chi cerca una strada di lotta per l’emancipazione) e sul contenimento di quella negativa (di chi è succube e rassegnato) presenti nelle masse. In qualsiasi situazione si tratta di riunire e organizzare la sinistra, cioè gli elementi attivi che incarnano la tendenza positiva (sinistra) per influenzare, attrarre ed elevare il livello di quelli intermedi (centro) e isolare, contenere e alla fine conquistare anche quelli arretrati (destra). Se non si coglie l’importanza di riunire e organizzare gli elementi attivi e avanzati e di farne un gruppo dirigente (tutti i comunisti devono essere dirigenti) legato alle larghe masse, o se non si è concretamente capaci di farlo, si otterrà nel migliore dei casi solo una direzione burocratica e per questo in definitiva inconcludente e negativa.
Alcune indicazioni di lavoro
La concezione maoista della linea di massa come metodo di direzione ribadisce chiaramente la necessità dell’organizzazione dei comunisti per impostare e sviluppare il lavoro tra le masse nella prospettiva della rivoluzione proletaria. È questo il presupposto essenziale. L’organizzazione dei comunisti è l’aspetto principale della dialettica partito-masse.
Ma di che partito si tratta? Innanzitutto è il reparto di avanguardia della classe operaia. “Il partito deve essere, prima di tutto, il reparto di avanguardia della classe operaia. Il partito deve assorbire tutti i migliori elementi della classe operaia, la loro esperienza, il loro spirito rivoluzionario, la loro devozione sconfinata alla causa del proletariato. Ma per essere effettivamente il reparto di avanguardia, il partito deve essere armato d’una teoria rivoluzionaria, deve conoscere le leggi del movimento, deve conoscere le leggi della rivoluzione”29. È la teoria rivoluzionaria che ci pone nella condizione di non limitarci a registrare la condizione delle masse, il loro malessere e la loro insofferenza alle condizioni poste dallo sfruttamento capitalista. È la teoria rivoluzionaria che ci mette della condizione di poter superare l’inerzia e l’indifferenza politica del movimento spontaneo della classe.
Appropriarsi di una teoria rivoluzionaria è il primo passo per non trascinarsi alla coda del movimento spontaneo. Essa ci permette di elevarci al di sopra degli interessi momentanei del proletariato e di impostare il lavoro per elevare la classe al livello dei suoi interessi strategici. Un lavoro orientato alla costruzione del partito della classe operaia, un partito che si costruisca in funzione della presa del potere e che fin dal suo embrione si caratterizzi come il più coerente, intransigente e determinato nemico dei gruppi dominanti (monopolisti, burocratici e finanziari) che compongono la borghesia imperialista.
A questo fine è oggi necessario sviluppare il lavoro di formazione ideologico-politica dei compagni, rivolto a ricucire la cesura operata dal revisionismo, che ha avuto come conseguenza l’interruzione della trasmissione degli insegnamenti che il movimento comunista internazionale ha potuto trarre dalla sua ricchissima esperienza. Quello della formazione teorico-ideologica del quadro è un contenuto fondamentale per perseguire il primo compito generale dei comunisti, cioè conquistare l’avanguardia cosciente del proletariato alla causa della rivoluzione e del comunismo. Si tratta di un passaggio oggi oltremodo necessario, il primo passo da fare per mettersi nella condizione di perseguire l’obiettivo, ormai ineludibile, di colmare il ritardo della soggettività comunista rispetto allo sviluppo delle contraddizioni dovute alla crisi del capitalismo.
Il lavoro di formazione teorico-ideologica può e deve avere oggi, come risvolto organizzativo importante, la definizione di ambiti formali di confronto tra comunisti. Seminari e gruppi di studio sui testi marxismo-leninismo-maoismo (finalizzati ad avere una impostazione ideologica corretta e trarre insegnamenti politici utili ad affrontare i compiti che abbiamo di fronte) devono essere concepiti come passaggio d’organizzazione, devono cioè essere impostati come passaggi utili a costituire fin da subito ambiti di organizzazione comunista seguendo l’indicazione data da Lenin. “Secondo me, il tipo generale di organizzazione deve essere dunque pressappoco così: alla testa di tutto il movimento locale, di tutto il lavoro socialdemocratico locale si trova il comitato (…) In secondo luogo, dal comitato si diramano i vari circoli e gruppi d’ogni genere che sono al servizio di tutto il movimento”30.
La costituzione di ambiti di dibattito e lavoro collettivo tra comunisti non è solo utile, ma anche necessaria per porsi nella condizione adeguata ad affrontare il secondo compito generale, che è quello di sviluppare in senso rivoluzionario la dialettica soggettività-masse, applicando a questo scopo la linea di massa come metodo di direzione.
È una riflessione che possiamo sintetizzare in una direttiva generale di fase: “raccoglierci, formarci e organizzarci come quadro comunista per orientarci e darci strumenti al fine di sviluppare collettivamente il nostro legame con le masse”. Ponendo così le basi per lo sviluppo dell’aspetto principale della dialettica partito-masse (il partito), aspetto che fin da subito può concretamente darsi “agendo da partito per costruire il partito”.
Va precisato che “I testi del marxismo vanno studiati, ma devono essere integrati con la conoscenza della nostra situazione reale”31. Infatti “La giusta e decisa tattica di lotta del partito non può assolutamente essere opera di una minoranza di uomini seduti in una stanza; essa non può che scaturire dal corso delle lotte di massa, vale a dire dall’esperienza pratica. Per questo dobbiamo avere una costante comprensione della situazione sociale, svolgere costantemente delle inchieste sui fatti”32.
Lo sviluppo della linea di massa come metodo di direzione ha come primo passaggio l’inchiesta.
Ma questo tipo di inchiesta non discende da una generica voglia di conoscenza, come non è fine a sé stessa. Fare inchiesta significa risolvere i problemi che si pongono nell’ambito del nostro lavoro. Ci serve ad individuare gli obiettivi che possiamo concretamente porci e il modo corretto di perseguirli per procedere nello sviluppo del movimento rivoluzionario della classe e delle masse.
In questa fase il ‘fare inchiesta’ ci serve per individuare principalmente il quadro che può essere raccolto, i compagni che, tra gli operai e i proletari, incarnano la tendenza positiva (cioè quella che tende verso la prospettiva della rivoluzione proletaria); e secondariamente i passi con cui questo quadro, formandosi ideologicamente e organizzandosi politicamente, può contribuire allo sviluppo di nostri punti di appoggio tra le masse, fino a conquistare collettivamente un rapporto di direzione con settori sempre più ampi del proletariato.
Una parte importante di questo nostro lavoro verso le masse ne riguarda la nostra internità, fino anche alla promozione di organismi di massa in cui le avanguardie operaie e proletarie si organizzano per cercare una via rivoluzionaria, per dare uno sbocco politico alla resistenza che le masse oppongono alle misure di sfruttamento, adottate per cercare di fare fronte alla crisi del sistema. I collettivi di compagni ‘senza partito’ (costituiti da compagni operai, studenti, proletari) presenti in diverse situazioni di classe, di massa e territoriali, portanti avanti contenuti e pratiche diverse (antimperialismo, antifascismo, lotte specifiche) sono in questa fase il nostro humus. Si tratta di conquistare un rapporto, un’internità, e di portare il nostro contributo al lavoro, più o meno particolare, di questi compagni, al fine di raccogliere e integrare quelli che sono interessati al nostro lavoro, ad un lavoro che prova ad essere più generale e complessivo; accompagnarli nella loro esperienza, con l’obiettivo di coinvolgerli in una esperienza comune più elevata.
Ad un altro livello si collocano le organizzazioni di massa del proletariato come i sindacati e gli organismi di lavoratori, disoccupati, pendolari, donne, giovani, le associazioni culturali, di mutua assistenza o sportive. Sono organizzazioni senza le quali il proletariato avrebbe maggiori difficoltà di riproduzione e di lotta contro il capitale. Anche in questi organismi si tratta di fare inchiesta per individuare le tendenze interne (positiva e negativa) e valutare se la nostra partecipazione alle loro attività (applicando la linea di massa) ci aiuta a perseguire meglio nostro il piano di costruire il partito.
Un contributo per cercare di capire come lavorare in queste organizzazioni lo troviamo nelle indicazioni che danno i compagni rivoluzionari indiani, oggi organizzati nel Partito Comunista dell’India (maoista)33 per orientare il loro lavoro nel contesto urbano. “La maggior parte di queste organizzazioni nascono in modo spontaneo a seconda dei bisogni delle masse, tuttavia molte di queste sono affiliazioni dirette e indirette di partiti od organizzazioni della classe dominante. Ciò non deve tuttavia influenzare il nostro programma di lavoro tra di esse ai livelli più bassi. I nostri principali criteri per stabilire se lavorare in una particolare organizzazione sono: in primo luogo se le masse sono o possono essere mobilitate da quella stessa organizzazione e, in secondo luogo, se la sua situazione sia tale da permetterci di influenzare politicamente le masse e di attirarne alcuni elementi verso il partito”34.
La decisione di condurre un lavoro in queste organizzazioni e in particolare sulla loro base di massa dipende quindi dal fatto che esse siano reali centri di mobilitazione e dalla possibilità che, tramite esse, abbiamo di mettere in relazione il nostro sviluppo politico-organizzativo con nuove, o più ampie, situazioni di classe e di coinvolgere nel nostro lavoro nuovi compagni. Con questi criteri va condotta l’inchiesta per stabilire in quali di esse è utile lavorare sulla base delle nostre possibilità e dei nostri obiettivi, soprattutto nel caso di organizzazione di massa di diversa appartenenza presenti nella stessa situazione di classe. È questo il caso dei diversi sindacati e sindacatini in competizione più o meno settaria tra di loro. In questi contesti, purtroppo comuni anche nella realtà di classe del nostro paese, “il nostro approccio generale deve essere quello di opporci alla scissione dell’unità delle masse e di schierarci per l’unità di tutte le organizzazioni rappresentative di massa che lavorano in quella determinata zona”35.
Questo con la consapevolezza che l’unità politica della classe può essere affermata e valorizzata realmente solo tramite il lavoro di partito sul piano politico-strategico della conquista del potere.
Nell’auspicio che questo contributo possa essere utile ai comunisti di oggi non ci resta che dire: buon lavoro compagni.
1 Vedi Collettivo “Zeno Sorgato”, Industria 4.0: un punto di vista di classe, tazebao.org, 1/5/2017
2 K. Marx – F. Engels, L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma, 1972, pagg. 24-25
3 Lenin, Che fare?, marxist.org
4 Vedi manchette: Operai e teoria
5 Vedi manchette: I comunisti e il movimento proletario
6 All’epoca il termine “comunista” era messo al bando dai regimi borghesi e lo stesso movimento operaio presentava tendenze non propriamente marxiste, ma genericamente socialiste. Solo l’8 Marzo del 1918 il Posdr (bolscevico) si ridenominò Partito Comunista, ma nelle opere di Lenin e degli altri dirigenti bolscevichi il termine “socialdemocratico” va sempre letto come “comunista”
7 Lenin, Un passo avanti e due indietro, Opere Scelte, Vol. 1, pag. 490, Editori Riuniti
8 Ivi, pag. 492
9 Ivi, pag. 502
10 Ivi, pag. 525
11 Ivi, pag. 529
12 Vedi Antitesi n. 0, pag. 1. Questa e le successive citazioni da A. Gramsci, Quaderni dal carcere, q. 15, par. 22, p. 1780, Vol. 8, Einaudi, 1977, Torino. Vedi inoltre la manchette: Teoria e pratica.
13 Mao Tse Tung, Sulla pratica, opere complete, Vol. 5, p. 171, Edizioni Rapporti Sociali.
14 cfr, K. Marx, Tesi su Feuerbach e V. Lenin, Materialismo ed empiriocriticismo, cap. 2, par. 6, opere, vol. 38
15 I. Stalin, Principi del leninismo, opere scelte, p. 427, Edizioni Movimento Studentesco
16 Mao Tse Tung, Sulla pratica, opere complete, vol. 5, p. 180, Edizioni Rapporti Sociali
17 I. Stalin, Rapporto al XVIII° Congresso del Partito (marzo 1938), opere scelte, p. 973, Edizioni Movimento Studentesco
18 V. Lenin, Estremismo, malattia infantile del comunismo, Opere complete, vol. 31, pp. 82-83, Editori Riuniti
19 Ibidem
20 Ibidem
21 Ibidem
22 Ibidem
23 Ibidem
24 Cfr. manchette: A proposito di parole d’ordine
25 Mao Tse Tung, Alcune questioni riguardanti i metodi di direzione, Opere complete, vol. 5, Edizione Rapporti Sociali
26 Mao Tse Tung, I dieci punti, opere complete, vol. 20, pag. 69, Edizioni Rapporti Sociali
27 Mao Tse Tung, Alcune questioni riguardanti i metodi di direzione, op. cit. , p. 213
28 Ibidem
29 I. Stalin, Questioni del leninismo, op. cit. pag. 477
30 V. Lenin, Lettera ad un compagno sui nostri compiti organizzativi, marxist.org
31 Mao Tse Tung, Contro la mentalità libresca, Opere complete, Vol. 3, pag. 37, Edizioni Rapporti sociali
32 Ivi, pag. 39
33 Il Partito Comunista dell’India (maoista) è una delle esperienze attualmente più significative del movimento comunista internazionale. Si è costituito nel 2004 e ha l’obiettivo di condurre la guerra popolare fino alla presa del potere del proletariato e delle masse contadine. I suoi militanti sono anche conosciuti come ‘naxaliti’ con riferimento all’insurrezione di Naxalbari del 1967.
34 Brano tratto da Prospettiva urbana, traduzione della redazione dall’originale in inglese, reperibile sul sito bannedthought.net.
35 Ibidem
Operai e teoria
“Gli operai tedeschi hanno due vantaggi essenziali sugli operai del resto dell’Europa. In primo luogo essi appartengono al popolo dell’Europa più portato alla teoria ed hanno conservato il senso teorico, che i cosiddetti “uomini colti” della Germania hanno totalmente perduto. Senza il precedente della filosofia tedesca e precisamente della filosofia di Hegel, il socialismo scientifico tedesco – l’unico socialismo scientifico che sia mai esistito – non sarebbe mai nato. Se tra gli operai non ci fosse stato questo senso teorico, il socialismo scientifico non si sarebbe mai cambiato in sangue e carne in così grande misura come è effettivamente accaduto. E quale incommensurabile vantaggio sia questo si rileva, da una parte, se si tenga presente l’indifferenza verso tutte le teorie, che è una delle cause principali per cui il movimento operaio inglese, malgrado tutta la notevole organizzazione dei singoli sindacati, avanzi così lentamente (…)
Precisamente sarà dovere di tutti i dirigenti chiarire sempre più tutte le questioni teoriche, liberarsi sempre più completamente dall’influsso delle frasi fatte proprie della vecchia concezione del mondo, e tener sempre presente che il socialismo, da quando è diventato una scienza, va trattato come una scienza, cioè va studiato. Ma l’importante sarà poi diffondere tra le masse, con zelo accresciuto, la concezione che così si è acquisita e che sempre più si è chiarita, e rinsaldare sempre più fermamente l’organizzazione del partito e dei sindacati (…)”
F. Engels, Prefazione alla La guerra dei contadini in Germania, citato da Lenin nel Che fare?
I comunisti e il movimento proletario
Che relazione passa tra i comunisti e i proletari in generale? I comunisti non costituiscono un partito particolare di fronte agli altri partiti operai. Essi non hanno interessi distinti dagli interessi del proletariato nel suo insieme. Non erigono principi particolari, sui quali vogliano modellare il movimento proletario. I comunisti si distinguono dagli altri partiti proletari solamente per il fatto che da un lato, nelle varie lotte nazionali dei proletari, essi mettono in rilievo e fanno valere quegli interessi comuni dell’intero proletariato che sono indipendenti dalla nazionalità; d’altro lato per il fatto che, nei vari stadi di sviluppo che la lotta tra proletariato e borghesia va attraversando, rappresentano sempre l’interesse del movimento complessivo. In pratica, dunque, i comunisti sono la parte più risoluta dei partiti operai di tutti i paesi, quella che sempre spinge avanti; dal punto di vista della teoria, essi hanno un vantaggio sulla restante massa del proletariato per il fatto che conoscono le condizioni, l’andamento e i risultati generali del movimento proletario. Lo scopo immediato dei comunisti è quello stesso degli altri partiti proletari: formazione del proletariato in classe, rovesciamento del dominio borghese, conquista del potere politico da parte del proletariato.
K. Marx, F. Engels, Manifesto del partito comunista, 1848
Teoria e pratica
Se il problema di identificare teoria e pratica si pone, si pone in questo senso: di costruire su una determinata pratica una teoria che, coincidendo e identificandosi con gli elementi decisivi della pratica stessa, acceleri il processo storico in atto, rendendo la pratica più omogenea, coerente, efficiente in tutti i suoi elementi, cioè potenziandola al massimo, oppure, data una certa posizione teorica, di organizzare l’elemento pratico indispensabile per la sua messa in opera. L’identificazione di teoria e pratica è un atto critico, per cui la pratica viene dimostrata razionale e necessaria o la teoria realistica e razionale. Ecco perché il problema della identità di teoria e pratica si pone specialmente in certi momenti storici così detti di transizione, cioè di più rapido movimento trasformativo, quando realmente le forze pratiche scatenate domandano di essere giustificate per essere più efficienti ed espansive, o si moltiplicano i programmi teorici che domandano di essere anch’essi giustificati realisticamente, in quanto dimostrano di essere assimilabili dai movimenti pratici che solo così diventano più pratici e reali.
A. Gramsci, Quaderni dal carcere – Il materialismo storico
A proposito di parole d’ordine
Un dibattito significativo sulla questione delle parole d’ordine si sviluppò nel Pcd’I nella seconda metà degli anni ‘20 del secolo scorso, in merito alle lotte contadine contro le amministrazioni locali fasciste. I podestà, che avevano sostituito i tradizionali Consigli elettivi, si paravano di fronte alle masse contadine anche come i rappresentanti della politica fiscale fascista, per cui la lotta contro le tasse si dirigeva spontaneamente contro il podestà in quanto nuovo agente del fisco. I giovani dirigenti della Fgci (Longo e Secchia) criticarono la parola d’ordine proposta dal partito: “diritto del popolo di eleggere le amministrazioni comunali” e vi contrapponevano un’altra basata sulle risultanze dell’inchiesta e sulle riflessioni condotte sulle lotte contadine che erano in più parti d’Italia sboccate in assalti ai municipi con episodi bastonature e cacciate di podestà. “La nostra parola d’ordine (cioè quella che noi giovani proponevamo in contrapposto al diritto di elezione): ‘via il podestà (a morte il podestà)’ è integrata dall’altra: ‘organizzatevi per la lotta’”1.
La critica metteva a fuoco il fatto che “con il ‘diritto di elezione’ non si dava un obiettivo concreto alle manifestazioni contadine già in atto”2 mentre “per lanciare delle parole d’ordine occorre che noi abbiamo la possibilità di realizzarle. Il contadino facendo la dimostrazione contro le podesterie vede la possibilità di bastonare il podestà, di ucciderlo magari, ma non vede affatto la possibilità di ottenere in regime fascista il diritto di eleggersi i suoi amministratori”3.
La critica si sviluppò anche con la considerazione che il “diritto di elezione”, ponendo la questione di un diritto da ottenere in regime fascista, non faceva risaltare che “il fascismo si distrugge, non si corregge” e quindi più difficilmente si sarebbe ottenuto di favorire un orientamento rivoluzionario delle masse.
Traslando questo dibattito alla situazione odierna si può constatare che, di fronte alla crisi del capitalismo e allo sviluppo delle lotte contro la chiusura delle fabbriche e in difesa dell’occupazione, la parola d’ordine della “nazionalizzazione delle imprese” in regime capitalista lanciata da alcune componenti interne al movimento di classe (Usb) offre il fianco allo stesso tipo di riflessioni critiche. Ad essa va contrapposta quella della “occupazione delle fabbriche” contro la chiusura (come è emerso nell’esperienza di lotta degli operai della Gkn di Campi Bisenzio). La prima, infatti, non mette al centro lo sviluppo concreto della lotta, non dà un obiettivo concreto alla mobilitazione in atto e non può essere praticata dalle masse, di conseguenza non persegue l’organizzazione delle masse, dando inoltre adito all’idea di un capitalismo riformabile e non favorendo così un orientamento rivoluzionario. La seconda, invece, mette al centro la lotta che può concretamente essere praticata dalle masse e la necessità dell’organizzazione per la sua attuazione e prosecuzione.
1 P. Secchia, L’azione svolta dal Partito Comunista in Italia durante il fascismo, p. 81, Feltrinelli Editore
2 Ibid p.78
3 ibid, p. 90




